Racconto inedito di Vincenzo Pardini
Le stagioni hanno rinnegato le antiche consuetudini. Il loro equilibrio si è rotto, spezzato come gli arti di un gigante che non riesce più a percorrere monti, valli e pianure. Prigioniero della sua disgrazia. Pioggia, vento o neve, può così accadere che si riversino su di noi nel momento più inaspettato. Addirittura di primavera. Una notte, il vento, si è abbattuto nella mia contrada divellendo castagni e querce secolari. Il mondo sembrava in bilico. Tornavo a casa il mattino presto, ancora a buio, allorché i fari della macchina illuminarono qualcosa sul ciglio della via; un qualcosa simile, per forma e mole, a un cane Corso. Ma dal ciglio in cui si trovava, balzò su quello opposto, scomparendo tra gli alberi. Volli credere fosse un’illusione creata dal vento, un alternarsi di ombre. Tra le nubi, la Luna andava e veniva come i sussulti di un dolore. A casa trovai la tettoia del loggiato divelta.
M’ero dimenticato del balzo della bestia in mezzo al vento quando, giorni dopo, un uomo del paese mi disse d’aver intravisto un grosso felino, colore rossiccio, nei pressi dei cassonetti dell’immondizia. Ma, in men che non si dica, era schizzato via, la lunga coda inarcata, scomparendo al di là del parapetto. Ricordai, allora, le teste di volpe, gatto e istrice che, durante l’inverno, i miei cani trovavano nelle piane degli oliveti, ancora insanguinate. Nel periodo della neve, lungo la via che scende nel bosco, avevo veduto delle impronte di forma rotonda più larghe di un tacco di scarpone di montagna, inoltrarsi nel folto. Pensavo fossero della lince. Erano invece del grosso felide. Dovetti, quindi, dare credito a ciò che m’aveva detto, d’estate, un amico: d’aver scorto, mentre in macchina risaliva la strada, le zampe posteriori d’un insolito animale dileguarsi nei cespugli. Conversando con un orologiaio, che sapevo essere anche cacciatore, gli dissi che, dalle mie parti, era stato avvistato un grosso felino. Toltosi il monocolo, e smesso di lavorare tra molle e rubini, narrò: “Due anni fa, una notte di maggio, nei pressi della rotonda delle Tre strade, mi sono trovato davanti i fanali della macchina, quello che americani e pellerossa chiamano leone di montagna, ossia il puma. Non credevo ai miei occhi. Se ne andava tranquillo lungo il margine della via maestra, finchè non svoltò nel sentiero dei campi e dei prati. Non ne parlai con nessuno. Chi m’avrebbe creduto?”. Gli raccontai, allora, della mattina del vento e il resto. Tirato un sospiro di sollievo, aggiunse: “Bene, non sono più il solo ad averlo visto”.
Un puma, dunque, si trovava allo stato brado, forse fuggito o reso libero da qualcuno a cui piace tenere bestie esotiche. Intanto, nella zona più a monte, nel bel mezzo del bosco, era stato veduto uno strano individuo. Piccolo, anziano e coi baffi, aveva scaricato dal furgone un certo numero di galline nane. Galline, fu accertato da chi ne catturò qualcuna, grasse e in salute. Altre volte aveva scaricato frattaglie e lembi di carne. “Servono al puma”, mi dirà infine il confidente. E proseguì: “La bestia sta da queste parti. Se vai in giro nelle selve ne respiri l’odore di carogna e piscio di gatto in amore. Comunque non teme le persone. Giorni fa, dopo pranzo, io e altri eravamo al fresco sotto la pergola, quando l’abbiamo visto nell’aia. Uscito dalla macchia è andato a bere nel truogolo. Peserà un quintale. E’ balzato via solo quando il vento ha sbattuto una finestra. C’è chi gli ha teso la trappola, chi il laccio, ma per adesso nulla. Se uno di noi aveva il fucile poteva, però, farlo secco”. Il giorno medesimo, arrivato a casa, mia figlia mi chiamò: alla televisione c’era un puma. Giunsi nell’attimo in cui il felide cercava di aggredire Robert Mitchum per impossessarsi d’un coscio che stava abbrustolendo allo spiedo. Il felino soffiava, abbassava le orecchie come un grosso gatto e, in un baleno, lui e l’eroe s’affrontano corpo a corpo. Ma esplode una fucilata e il puma crolla a terra. Due loschi individui, attirati quanto lui dal profumo della carne, sono accorsi appena in tempo. Così, almeno, sembra. In realtà la situazione si rivela assai diversa. Con Mitchum c’è Marilyn Monroe. Sarà lei che i due loschi individui vogliono. Il film è infatti La magnifica preda. Un’avventura che, in parte, si svolge sopra un zattera, lungo il Mississipi. Nel finale, Marilyn canta la canzone Il fiume senza ritorno. La sua voce penetra nei sensi e nella fantasia al pari della sua immagine.
Nelle piane degli oliveti, alle teste dei selvatici e dei gatti, se n’aggiunse qualcuna di cane. Una, assai grossa, aveva gli occhi sbarrati. Ne rimasi turbato. Dolore e morte di un cane credo ci riguardino da vicino più di quelli di altri animali. Poi fu la volta d’una capretta che soleva pascolare intorno a un casolare. Sparita. Cambiata mi parve, infine, la vita di volpi e gatti che, di notte, scorgevo sul margine della strada. Si mostravano guardinghi e diffidenti.
Nei paesi di collina e di montagna non esiste più la vita di un tempo quando la gente, nei giorni feriali, s’incontrava nelle piazze, all’osteria o alla bottega d’alimentari. Quest’ultime sono chiuse, e più nessuno sosta sui sagrati. Nemmeno gli anziani. Le loro case le hanno visitate i ladri, alla stregua delle chiese, anch’esse sprangate. Anziani e bambini rimangono, quindi, presso le abitazioni. Soltanto la domenica il paese si anima. Le vicende del puma continuavano a tenere banco. Una signora, che abita in una casa a mezza costa, diceva esserle spariti, nel volgere di un paio di mesi, ben sedici cani randagi da lei ospitati. Le sparizioni erano iniziate di primavera, insieme a grosse orme lasciate sul terreno appena arato. Saputo che potevano essere del puma, lo voleva morto. Lo chiedeva ai cacciatori, in particolare ai cinghialai. Lusingati e sorridenti, tono ambiguo le rispondevano: “Non si può, la caccia è chiusa. Guai sparare un colpo adesso. Se, tuttavia, capitasse durante una battuta …”
Di notte aveva cominciato a giungermi un lamento: una sorta di mugolio strozzato simile a una voce umana. I cani abbaiavano, forsennati. Consultai una vecchia enciclopedia. Descriveva il puma come un animale di un peso dai 60 ai 110 chili, il corpo lungo, inclusa la coda, fino a un metro e ottanta; altezza dai 60 ai 70 centimetri. Con gli uomini non si mostra aggressivo, anzi è accaduto corresse in loro difesa quando erano assaliti da orsi o altri grossi predatori. Ed emette lamenti che sembrano umani. Quella voce, dunque, era la sua.
Nel frattempo si occuparono di lui i giornali, descrivendolo come animale feroce e solitario, terrore degli indiani d’America. Le mamme si spaventarono. Temevano che i loro figli potessero esserne vittime.
Una sera di luglio, al tramonto, i suoi lamenti non mi giunsero dai boschi della valle, bensì da quelli estremi della collina. Avevano il ritmo d’una nenia, a cui si unirono quelli delle civette. I cani non abbaiavano, e la nenia rimbalzava nell’aria. Finché lui smise e proseguirono le civette, imitandolo. Ma, d’improvviso, dalle case del rialto provenne un trambusto di porte sbattute e il nitrito di un cavallo. La padrona chiamava i figli, urlando: “C’è il gattone! c’è il gattone!”. Scese il silenzio. Poi la voce di un uomo urlò: “Fate presto!”. Arrivato su, trovai la donna coi figli armati di fucile e altre persone con roncole, badili e coltelli da cucina. Alcuni anziani scrutavano a terra alla ricerca delle sue impronte. Non ne trovavano, ma il cavallo, collo teso e testa alta, continuava a scalpitare, innalzando polvere. Uno degli anziani disse: “Stavolta hanno ragione i giornali. Un felino è proprio in mezzo alle case”. La notte, poco dopo l’una, i cani presero ad abbaiare con affanno ed eccitazione. M’affaccio alla finestra soprastante il bosco e illumino con la torcia il circondario. Due globi scintillano tra rovi e felci; inquadro una sagoma rossiccia. Non credo ai miei occhi. Il puma è lì. Immobile. Sembra una leonessa. Il fascio di luce non sembra incutergli paura. Volge la testa verso di me. Poi si volta come si srotolasse e scende il poggio prospiciente il bosco in uno scricchiolare di rami. Nell’aria ristagna il suo odore. Torno a letto ma non riesco a dormire. L’emozione tiene desta la memoria e ripresenta aspetti e particolari del felino: le zampe posteriori più lunghe delle anteriori, la schiena non poi tanto più larga di un grosso molossoide. Sto per assopirmi, ma echeggia il grido di un cinghiale, analogo a quello d’una cornacchia. Torno alla finestra. Il grido cessa come spento. Giungono dei grugniti. All’alba scendo nel bosco. Trovo sue impronte su di un poggio di argilla. I segni degli artigli paiono striature di grossi chiodi. Nel sentiero che scende alla sorgente il suolo è, invece, segnato dalle orme degli ungulati. Seguirono giorni in cui pareva scomparso. Ma in un fine settimana, nel cuore della notte, lo vedrà una donna traversare un vicolo al margine del paese. Lo raccontava con stupore e paura. Dal canto mio non cessavo di svolgere perlustrazioni, scrutando col binocolo luoghi distanti e inaccessibili.
L’intensità dei nuovi temporali e l’abbandono in cui versano le foreste provocano, sovente, enormi smottamenti. Strade e sentieri può succedere vengano addirittura cancellati, gli alberi crollano sovrapponendosi. Le mie selve, che durante l’Ultima guerra furono anche ricetto di sfollati o di uomini che si nascondevano ai rastrellamenti dei nazifascisti, stanno divenendo la giungla d’occidente. Transitarle non è quindi agevole. Su di un cumolo di terra esposta a nord, umida nonostante la calura, trovai ben marcate le impronte del felide. Un silenzio insolito gravava attorno. Non un uccello. Nemmeno le petulanti ghiandaie. Col binocolo esplorai la distesa degli alberi soffermandomi sui rami alti e medio alti dove sostano i volatili. D’un tratto, nel fogliame di un grande castagno, centrai un involucro fulvo. Una corrente fredda mi percorse la schiena e il resto del corpo. Il colore s’era mosso, aveva preso forma. Era il puma, in piedi su di un ramo. Poi discese dal tronco alla stregua di un enorme gatto. I pensieri mi si accelerarono, assecondando i brividi. Il castagno non si trovava granché lontano. Non riuscivo, tuttavia, a fuggire. M’attraeva l’idea di vederlo allo scoperto confidando sulle nozioni dell’enciclopedia: il puma non attacca gli uomini se non deve difendersi. Ero intanto arrivato nei pressi di casa. Il sole pomeridiano splendeva ancora alto. Verso sera, quando non pensavo più al puma, mi giunse il suo lamento. Era di nuovo vicino. La Luna, enorme e vermiglia, oscillava sugli alberi che delimitano il promontorio del paese. Macchine passavano dalla strada ma, il loro rumore, giungeva attutito dal silenzio di una notte che, in virtù della Luna piena, pareva di seta e velluto. I lamenti del felino suonavano così più nitidi. Diversi a quelli già uditi: avevano un ritmo costante con variazioni di tono. Cos’è che voleva dire; soprattutto, a chi si rivolgeva? Poteva, pensai, aver nostalgia della femmina, oppure emettere il lamento alla stregua d’un canto solitario, forse per salutare la notte, il suo regno.
Tra boscaglia e coltivato, non molto lontano, seppi che si trovava una bestia riversa a terra. Chi l’aveva intravista s’era ben guardato da fare accertamenti. Temeva fosse il puma ferito. Si trattava, invece, di un grosso cane meticcio divorato nelle parti tenere, tra cui il ventre. Avvolto in un turbine d’insetti, giaceva al margine di un tratturo. Il puma doveva averlo incrociato e aggredito. La sua caccia vicino le abitazioni proseguiva, come io continuavo a cercarlo spingendomi ogni giorno nei boschi. Una sera, traversando una radura, mi giunsero fischi allarmati di merli e di non so quali altri pennuti, a cui si unì un frenetico canto di cuculo. Una poiana s’innalzò emettendo il suo stridulo richiamo. Pensai che gli uccelli potevano essere in allarme per lei, sennonché giunse un rumore di propaggini infrante come le investite dal vento. Scorsi ventre e coda del puma balzare da un albero all’altro, scorrendo sulle ramificazioni con la disinvoltura di un cane sul terreno.
Un conoscente, incontrato per caso al bar, mi chiese se, di notte, tenevo il cane libero. La domanda mi sembrò insolita e gliene chiesi il motivo. Rispose d’aver veduto, nella stradetta d’accesso a casa mia, un molosso enorme di colore fulvo. Tacqui. Chi poteva essere se non il puma? Sapere che continuava a venire nei pressi di casa mi dette tuttavia preoccupazione. Temevo per mia figlia ancora piccola. Pensai volesse aggredirla. Telefonai a un etologo chiedendogli se esisteva questa probabilità. Mi rispose ch’era molto remota. Anche se, da materiale di sua conoscenza, un puma aveva di recente aggredito una signora americana mentre passeggiava al margine di un bosco, ferendola. Ma era un caso assai isolato: si trattava di una femmina col cucciolo, la quale doveva aver veduto nella donna un avversario. Il mio caso era diverso, dal momento che doveva trattarsi di un soggetto probabilmente vissuto in cattività, visto che mostrava dimestichezza con gli umani. Quindi, non lo reputava pericoloso per la gente. Risposta che, tuttavia, non mi soddisfece. Il mio puma, diciamo così, uccideva e sapeva destreggiarsi tra rami di alberi e boscaglie con la spigliatezza e la maestria proprie della sua specie. Assalire una persona, per di più un bambino, gli sarebbe quindi stato facile. Pensiero che, in breve, mi si tramutò in una sorta di incubo. Una mattina molto presto, mentre in macchina risalivo la strada, in prossimità d’una curva fui costretto a inchiodare: per poco non entrai dentro un branco di cinghiali, adulti e piccoli. Dietro avevano il puma che, schivata la macchina, scomparve nel sottobosco. I cinghiali erano invece rimasti allo scoperto nella piana di un uliveto; fatto cerchio attorno ai piccoli, gli adulti non accennavano a muoversi. Finché un verro irsuto non scattò in avanti. Nell’erba alta vidi il puma balzare e, nello stesso tempo, ritrarsi insieme a un grido che si spostava.
Nei giorni seguenti m’accadeva di ripensare all’attimo in cui m’era apparso davanti la macchina e avevo veduto i suoi occhi d’un giallo trasparente. Poi m’era rimasto impresso il suo modo di camminare a piccoli balzi.
Ne trovai le impronte vicine una sorgente; dal terreno umido e renoso, si spostavano nel bosco scomparendo tra le piante. Da uno spiazzo argilloso circondato da alberi caduti, giunse il suo odore. Cominciai a esplorare il circondario. D’un tratto ebbi la sensazione d’essere spiato. Nel mezzo di due carpini vidi brillare la sua testa. Seduto mi osservava, le orecchie appena tirate indietro. Eravamo distanti una ventina di metri. Stranamente, non m’incuteva paura. Ci guardavamo. Immobili. Sprofondai in un silenzio fatto di voli d’api e di mosche. Alcune delle quali ronzavano attorno il suo muso. Mi mossi per andar via. Increspò le fauci come fanno i gatti. Svoltato che ebbi dal bosco alla strada, lui emise un lamento. Mi voltai. Uscito allo scoperto camminava lungo i cespugli, zoppicando su una zampa anteriore. Aveva una spalla lacerata. Inoltratosi nel bosco scomparve. Il messaggio che m’aveva lanciato era chiaro. Non potendo cacciare, sarebbe morto di fame. Dovevo soccorrerlo dandogli della carne. Un amico veterinario mi consigliò di portargli frattaglie con dentro antibiotici.
Seguirono giorni che potrebbero essere un diario, tanti i risvolti e le sorprese, ma preferisco andare per le spicce. Di pomeriggio scendevo fino allo spiazzo d’argilla in mezzo agli alberi con un sacco pieno di interiora di vacca, rognone e fegato. Deposta la carne, m’allontanavo posizionandomi col binocolo. Nel volgere di breve tempo, intravedevo i suoi movimenti nel folto. Veniva a prendere il cibo e s’imboscava. In seguito s’avvicinerà non appena gli volgevo le spalle. Ne avvertivo il rumore lieve e uniforme. Un giorno, con mia sorpresa, lo trovai ad attendermi seduto tra i castagni. Deposta la carne retrocessi un poco. A piccoli passi, la coda oscillante, s’accostò al cibo guardandomi coi suoi occhi d’una trasparenza dorata. Poi, svelto, afferrata la carne si ritrasse. La ferita, vidi, non mostrava più il colore dell’aceto e zoppicava assai meno. Il veterinario mi disse che sospendessi pure la donazione: poteva di nuovo cacciare. Ma io continuai. Per un paio di giorni non si fece vedere. Il terzo lo trovai ad attendermi nel punto in cui solevo depositargli il cibo. Al posto del quale si trovava un piccolo di cinghiale che sembrava ancora vivo. Coda sferzante, emise un brontolio che, sul principio, non compresi se di amicizia o di minaccia, tanto che mi pentii di non aver con me un’arma. Come avesse capito il mio pensiero, tramutò il brontolio in un profondo suono gutturale, analogo alle fusa di un gatto. Fissandomi, atteggiò il muso a un’espressione di dolcezza. Capii, alfine, che mi offriva il cinghialetto. Preso da un impeto di riconoscenza, quasi senza avvedermene, allungai una mano per carezzarlo. Lui mi venne appresso porgendo testa e collo. M’arrivava quasi a metà coscia, e, proprio alla stregua dei gatti, prese a strofinarmi col costato. Morbida e vellutata, la pelliccia gli aderiva su muscoli e ossa che avevano la compattezza di un attrezzo metallico. Il suo odore m’entrava nelle narici, lasciandovi una sensazione agrodolce. Si discostò quando gli sfiorai la ferita: una cicatrice appena chiusa, a forma di falce di Luna. Se n’andò. Appena fu notte i miei cani presero ad abbaiare. Dall’aia mi giunse il tonfo d’un involucro che cade a terra. M’affacciai. Vicino alle scale, giaceva la carogna del cinghialino. Continuava a sembrare ancora vivo. Il puma gli aveva spezzato la schiena lasciandolo intatto. Dal bosco provenne il suo lamento. Lo interpretai come un addio. Aveva infatti adempiuto ai doveri della sua specie: mostrarsi grato verso un essere umano che lo aveva assistito. Mi sbagliavo. Dovendo trasportare della legna, scendevo nel bosco per farne dei fasci. Intento a questa mansione di noia e fatica, avvertii del movimento sui rami di un albero. Il tempo di voltarmi e già il puma, con una sorta di sobbalzo come fosse di gomma, aveva toccato terra. Mi venne accanto e gli carezzai la testa; compatta e rotonda, sembrava l’elmo di un guerriero, mentre il collo era gonfio e teso come il tricipite d’un atleta. Poi si ritrasse, quasi a voler fuggire. Poi mi ritornò appresso. M’invitava a seguirlo. Ora precedendomi ora seguendomi iniziammo a scendere lungo un sentiero. M’avvidi che non riusciva a starmi vicino come, forse, desiderava; la flessibilità della sua colonna vertebrale lo obbligava a procedere a balzi. Così mi precedeva sempre d’una ventina di metri, aspettandomi. Eravamo nel ventre della boscaglia-jungla. Il mondo dei rumori e delle macchine, sembrava lontano, se non inesistente. Provai a tornare indietro per vedere se mi seguiva. Dopo qualche istante sbucò dai cespugli, oltrepassandomi. Ci fermammo in una radura. Bocca semiaperta sui lunghi denti, si sdraiò restando col collo eretto. Mi osservava spiandomi, pareva, non solo nei movimenti, ma anche nelle intenzioni. In realtà ci eravamo come gemellati. Tutto in virtù del più antico dei linguaggi: quello dei boschi, della terra e degli alberi che si rivela soltanto ai suoi eletti, oppure, in casi eccezionali come il nostro. Eravamo di fronte, ammaliati uno dell’altro e ci guardavamo. Dalla bocca, ancora semiaperta, gli spioveva adesso la lingua un poco forcuta e che sembrava dura come una suola di cuoio. A momenti socchiudeva gli occhi, quasi stesse assopendosi. Cosa che, forse, un poco fece allorché sedetti sopra una pietra, sdraiandosi tutto. Altro suo regalo: oltre la compagnia mi concedeva la fiducia. Lo carezzai. Restava immobile sfoderando i lunghi artigli dalle punte uncinate. Poi d’improvviso, come gli fosse giunto un richiamo misterioso, scattò in piedi sparendo nella selva. Luglio e parte d’agosto trascorsero senza che lo rivedessi. Ma un pomeriggio, che mi trovavo davanti casa con degli amici, ne avvertii la presenza. Guardato dalla parte del bosco, ne intravidi la testa tra degli arbusti. Era schiacciato a terra, come per un agguato. Volevo mostrarlo agli ospiti. Ma venni trattenuto da una strana considerazione. Ci sono state persone che hanno avuto la grazia di vedere la divinità; io, invece, quella di vedere e stare con un puma. Meglio, decisi, non rivelarla. Ne andava del suo segreto.
I cacciatori, che nelle loro perlustrazioni in vista dell’apertura della stagione venatoria avevano ricostruito i movimenti del felino, decisero di eliminarlo. Uno di loro m’era venuto a dire del suo covo: si trovava poco lontano da casa mia, nelle impenetrabili sterpaglie che si estendevano, quasi a picco, al limitare di un oliveto. Sogghignando, aggiunse ch’era tutto pronto per tendergli l’agguato: noceva alla caccia e doveva essere eliminato. E mi chiese se, per caso, non l’avessi veduto. La sera medesima, in una corte al centro del paese, presi parte al loro convegno. Erano una decina di individui, di piccola statura, le pance prominenti e i capelli grigi o bianchi. Appassionati di calcio, trascorrevano i meriggi domenicali con le radioline all’orecchio, oppure al circolo davanti il televisore. Se la squadra del cuore era in difficoltà o subiva un gol, le loro facce s’incupivano come quando condannavano il puma. Decisero di attaccarlo al calasole poco prima che uscisse dai roveti. Gli avrebbero sparato a raffica con fucili d’alta precisione, caricati coi proiettili da cinghiale. L’avrebbero fatto all’indomani. Disponevo, quindi, del tempo necessario per ordire un piano in sua difesa. Con questo pensiero mi coricai. Appena desto, sentii d’essere in sintonia col puma come quando n’avvertivo la presenza. Avevo la mente lucida e l’animo sereno. Era una bella giornata. Andai alla volta delle sterpaglie. Volevo accertarmi che ci fosse. M’affidai all’olfatto. Il suo odore era fresco. Mi ritrassi. Cominciavano le ore dell’ansia e dell’attesa. Non mi spostai da casa. Mi bastava il binocolo. I cacciatori sarebbero discesi da un certo sentiero traversando boschi e coltivato. Dovevano agire in incognito. Per la legge erano bracconieri. Venne infine il momento che li vidi incamminarsi. Procedevano in fila indiana, accosto agli alberi sfiorati dal tramonto. Sembravano un drappello d’ombre. Anch’io mi mossi e, assai prima di loro, giunsi sul posto. L’odore del puma era greve: era rimasto lì il giorno intero. Presi dei sassi, li scagliai nella sterpaglia. Subito, udii dei soffi. Parevano gli sfiati di un camion che frena. Seguì un forte scricchiolio di arbusti che si spezzano. Stava andandosene. Dovevo battere la ritirata prima dell’arrivo dei cacciatori. Appena ebbi scollettato, crepitò la raffica della fucileria. Silenzio. Finché il vento della sera non mi recò le loro voci. Certi d’averlo crivellato, se ne compiacevano come quando la squadra del cuore vinceva la partita. Invece l’avevano persa. Ho infatti saputo che lui si trova sull’altro versante della montagna, in una riserva. L’hanno visto cacciare caprioli. Ma, prima o poi, sento che ci rivedremo. Forse sarà lui a tornare. La sua mente selvaggia, proprio perché selvaggia, non può avermi dimenticato.
Le stagioni hanno rinnegato le antiche consuetudini. Il loro equilibrio si è rotto, spezzato come gli arti di un gigante che non riesce più a percorrere monti, valli e pianure. Prigioniero della sua disgrazia. Pioggia, vento o neve, può così accadere che si riversino su di noi nel momento più inaspettato. Addirittura di primavera. Una notte, il vento, si è abbattuto nella mia contrada divellendo castagni e querce secolari. Il mondo sembrava in bilico. Tornavo a casa il mattino presto, ancora a buio, allorché i fari della macchina illuminarono qualcosa sul ciglio della via; un qualcosa simile, per forma e mole, a un cane Corso. Ma dal ciglio in cui si trovava, balzò su quello opposto, scomparendo tra gli alberi. Volli credere fosse un’illusione creata dal vento, un alternarsi di ombre. Tra le nubi, la Luna andava e veniva come i sussulti di un dolore. A casa trovai la tettoia del loggiato divelta.
M’ero dimenticato del balzo della bestia in mezzo al vento quando, giorni dopo, un uomo del paese mi disse d’aver intravisto un grosso felino, colore rossiccio, nei pressi dei cassonetti dell’immondizia. Ma, in men che non si dica, era schizzato via, la lunga coda inarcata, scomparendo al di là del parapetto. Ricordai, allora, le teste di volpe, gatto e istrice che, durante l’inverno, i miei cani trovavano nelle piane degli oliveti, ancora insanguinate. Nel periodo della neve, lungo la via che scende nel bosco, avevo veduto delle impronte di forma rotonda più larghe di un tacco di scarpone di montagna, inoltrarsi nel folto. Pensavo fossero della lince. Erano invece del grosso felide. Dovetti, quindi, dare credito a ciò che m’aveva detto, d’estate, un amico: d’aver scorto, mentre in macchina risaliva la strada, le zampe posteriori d’un insolito animale dileguarsi nei cespugli. Conversando con un orologiaio, che sapevo essere anche cacciatore, gli dissi che, dalle mie parti, era stato avvistato un grosso felino. Toltosi il monocolo, e smesso di lavorare tra molle e rubini, narrò: “Due anni fa, una notte di maggio, nei pressi della rotonda delle Tre strade, mi sono trovato davanti i fanali della macchina, quello che americani e pellerossa chiamano leone di montagna, ossia il puma. Non credevo ai miei occhi. Se ne andava tranquillo lungo il margine della via maestra, finchè non svoltò nel sentiero dei campi e dei prati. Non ne parlai con nessuno. Chi m’avrebbe creduto?”. Gli raccontai, allora, della mattina del vento e il resto. Tirato un sospiro di sollievo, aggiunse: “Bene, non sono più il solo ad averlo visto”.
Un puma, dunque, si trovava allo stato brado, forse fuggito o reso libero da qualcuno a cui piace tenere bestie esotiche. Intanto, nella zona più a monte, nel bel mezzo del bosco, era stato veduto uno strano individuo. Piccolo, anziano e coi baffi, aveva scaricato dal furgone un certo numero di galline nane. Galline, fu accertato da chi ne catturò qualcuna, grasse e in salute. Altre volte aveva scaricato frattaglie e lembi di carne. “Servono al puma”, mi dirà infine il confidente. E proseguì: “La bestia sta da queste parti. Se vai in giro nelle selve ne respiri l’odore di carogna e piscio di gatto in amore. Comunque non teme le persone. Giorni fa, dopo pranzo, io e altri eravamo al fresco sotto la pergola, quando l’abbiamo visto nell’aia. Uscito dalla macchia è andato a bere nel truogolo. Peserà un quintale. E’ balzato via solo quando il vento ha sbattuto una finestra. C’è chi gli ha teso la trappola, chi il laccio, ma per adesso nulla. Se uno di noi aveva il fucile poteva, però, farlo secco”. Il giorno medesimo, arrivato a casa, mia figlia mi chiamò: alla televisione c’era un puma. Giunsi nell’attimo in cui il felide cercava di aggredire Robert Mitchum per impossessarsi d’un coscio che stava abbrustolendo allo spiedo. Il felino soffiava, abbassava le orecchie come un grosso gatto e, in un baleno, lui e l’eroe s’affrontano corpo a corpo. Ma esplode una fucilata e il puma crolla a terra. Due loschi individui, attirati quanto lui dal profumo della carne, sono accorsi appena in tempo. Così, almeno, sembra. In realtà la situazione si rivela assai diversa. Con Mitchum c’è Marilyn Monroe. Sarà lei che i due loschi individui vogliono. Il film è infatti La magnifica preda. Un’avventura che, in parte, si svolge sopra un zattera, lungo il Mississipi. Nel finale, Marilyn canta la canzone Il fiume senza ritorno. La sua voce penetra nei sensi e nella fantasia al pari della sua immagine.
Nelle piane degli oliveti, alle teste dei selvatici e dei gatti, se n’aggiunse qualcuna di cane. Una, assai grossa, aveva gli occhi sbarrati. Ne rimasi turbato. Dolore e morte di un cane credo ci riguardino da vicino più di quelli di altri animali. Poi fu la volta d’una capretta che soleva pascolare intorno a un casolare. Sparita. Cambiata mi parve, infine, la vita di volpi e gatti che, di notte, scorgevo sul margine della strada. Si mostravano guardinghi e diffidenti.
Nei paesi di collina e di montagna non esiste più la vita di un tempo quando la gente, nei giorni feriali, s’incontrava nelle piazze, all’osteria o alla bottega d’alimentari. Quest’ultime sono chiuse, e più nessuno sosta sui sagrati. Nemmeno gli anziani. Le loro case le hanno visitate i ladri, alla stregua delle chiese, anch’esse sprangate. Anziani e bambini rimangono, quindi, presso le abitazioni. Soltanto la domenica il paese si anima. Le vicende del puma continuavano a tenere banco. Una signora, che abita in una casa a mezza costa, diceva esserle spariti, nel volgere di un paio di mesi, ben sedici cani randagi da lei ospitati. Le sparizioni erano iniziate di primavera, insieme a grosse orme lasciate sul terreno appena arato. Saputo che potevano essere del puma, lo voleva morto. Lo chiedeva ai cacciatori, in particolare ai cinghialai. Lusingati e sorridenti, tono ambiguo le rispondevano: “Non si può, la caccia è chiusa. Guai sparare un colpo adesso. Se, tuttavia, capitasse durante una battuta …”
Di notte aveva cominciato a giungermi un lamento: una sorta di mugolio strozzato simile a una voce umana. I cani abbaiavano, forsennati. Consultai una vecchia enciclopedia. Descriveva il puma come un animale di un peso dai 60 ai 110 chili, il corpo lungo, inclusa la coda, fino a un metro e ottanta; altezza dai 60 ai 70 centimetri. Con gli uomini non si mostra aggressivo, anzi è accaduto corresse in loro difesa quando erano assaliti da orsi o altri grossi predatori. Ed emette lamenti che sembrano umani. Quella voce, dunque, era la sua.
Nel frattempo si occuparono di lui i giornali, descrivendolo come animale feroce e solitario, terrore degli indiani d’America. Le mamme si spaventarono. Temevano che i loro figli potessero esserne vittime.
Una sera di luglio, al tramonto, i suoi lamenti non mi giunsero dai boschi della valle, bensì da quelli estremi della collina. Avevano il ritmo d’una nenia, a cui si unirono quelli delle civette. I cani non abbaiavano, e la nenia rimbalzava nell’aria. Finché lui smise e proseguirono le civette, imitandolo. Ma, d’improvviso, dalle case del rialto provenne un trambusto di porte sbattute e il nitrito di un cavallo. La padrona chiamava i figli, urlando: “C’è il gattone! c’è il gattone!”. Scese il silenzio. Poi la voce di un uomo urlò: “Fate presto!”. Arrivato su, trovai la donna coi figli armati di fucile e altre persone con roncole, badili e coltelli da cucina. Alcuni anziani scrutavano a terra alla ricerca delle sue impronte. Non ne trovavano, ma il cavallo, collo teso e testa alta, continuava a scalpitare, innalzando polvere. Uno degli anziani disse: “Stavolta hanno ragione i giornali. Un felino è proprio in mezzo alle case”. La notte, poco dopo l’una, i cani presero ad abbaiare con affanno ed eccitazione. M’affaccio alla finestra soprastante il bosco e illumino con la torcia il circondario. Due globi scintillano tra rovi e felci; inquadro una sagoma rossiccia. Non credo ai miei occhi. Il puma è lì. Immobile. Sembra una leonessa. Il fascio di luce non sembra incutergli paura. Volge la testa verso di me. Poi si volta come si srotolasse e scende il poggio prospiciente il bosco in uno scricchiolare di rami. Nell’aria ristagna il suo odore. Torno a letto ma non riesco a dormire. L’emozione tiene desta la memoria e ripresenta aspetti e particolari del felino: le zampe posteriori più lunghe delle anteriori, la schiena non poi tanto più larga di un grosso molossoide. Sto per assopirmi, ma echeggia il grido di un cinghiale, analogo a quello d’una cornacchia. Torno alla finestra. Il grido cessa come spento. Giungono dei grugniti. All’alba scendo nel bosco. Trovo sue impronte su di un poggio di argilla. I segni degli artigli paiono striature di grossi chiodi. Nel sentiero che scende alla sorgente il suolo è, invece, segnato dalle orme degli ungulati. Seguirono giorni in cui pareva scomparso. Ma in un fine settimana, nel cuore della notte, lo vedrà una donna traversare un vicolo al margine del paese. Lo raccontava con stupore e paura. Dal canto mio non cessavo di svolgere perlustrazioni, scrutando col binocolo luoghi distanti e inaccessibili.
L’intensità dei nuovi temporali e l’abbandono in cui versano le foreste provocano, sovente, enormi smottamenti. Strade e sentieri può succedere vengano addirittura cancellati, gli alberi crollano sovrapponendosi. Le mie selve, che durante l’Ultima guerra furono anche ricetto di sfollati o di uomini che si nascondevano ai rastrellamenti dei nazifascisti, stanno divenendo la giungla d’occidente. Transitarle non è quindi agevole. Su di un cumolo di terra esposta a nord, umida nonostante la calura, trovai ben marcate le impronte del felide. Un silenzio insolito gravava attorno. Non un uccello. Nemmeno le petulanti ghiandaie. Col binocolo esplorai la distesa degli alberi soffermandomi sui rami alti e medio alti dove sostano i volatili. D’un tratto, nel fogliame di un grande castagno, centrai un involucro fulvo. Una corrente fredda mi percorse la schiena e il resto del corpo. Il colore s’era mosso, aveva preso forma. Era il puma, in piedi su di un ramo. Poi discese dal tronco alla stregua di un enorme gatto. I pensieri mi si accelerarono, assecondando i brividi. Il castagno non si trovava granché lontano. Non riuscivo, tuttavia, a fuggire. M’attraeva l’idea di vederlo allo scoperto confidando sulle nozioni dell’enciclopedia: il puma non attacca gli uomini se non deve difendersi. Ero intanto arrivato nei pressi di casa. Il sole pomeridiano splendeva ancora alto. Verso sera, quando non pensavo più al puma, mi giunse il suo lamento. Era di nuovo vicino. La Luna, enorme e vermiglia, oscillava sugli alberi che delimitano il promontorio del paese. Macchine passavano dalla strada ma, il loro rumore, giungeva attutito dal silenzio di una notte che, in virtù della Luna piena, pareva di seta e velluto. I lamenti del felino suonavano così più nitidi. Diversi a quelli già uditi: avevano un ritmo costante con variazioni di tono. Cos’è che voleva dire; soprattutto, a chi si rivolgeva? Poteva, pensai, aver nostalgia della femmina, oppure emettere il lamento alla stregua d’un canto solitario, forse per salutare la notte, il suo regno.
Tra boscaglia e coltivato, non molto lontano, seppi che si trovava una bestia riversa a terra. Chi l’aveva intravista s’era ben guardato da fare accertamenti. Temeva fosse il puma ferito. Si trattava, invece, di un grosso cane meticcio divorato nelle parti tenere, tra cui il ventre. Avvolto in un turbine d’insetti, giaceva al margine di un tratturo. Il puma doveva averlo incrociato e aggredito. La sua caccia vicino le abitazioni proseguiva, come io continuavo a cercarlo spingendomi ogni giorno nei boschi. Una sera, traversando una radura, mi giunsero fischi allarmati di merli e di non so quali altri pennuti, a cui si unì un frenetico canto di cuculo. Una poiana s’innalzò emettendo il suo stridulo richiamo. Pensai che gli uccelli potevano essere in allarme per lei, sennonché giunse un rumore di propaggini infrante come le investite dal vento. Scorsi ventre e coda del puma balzare da un albero all’altro, scorrendo sulle ramificazioni con la disinvoltura di un cane sul terreno.
Un conoscente, incontrato per caso al bar, mi chiese se, di notte, tenevo il cane libero. La domanda mi sembrò insolita e gliene chiesi il motivo. Rispose d’aver veduto, nella stradetta d’accesso a casa mia, un molosso enorme di colore fulvo. Tacqui. Chi poteva essere se non il puma? Sapere che continuava a venire nei pressi di casa mi dette tuttavia preoccupazione. Temevo per mia figlia ancora piccola. Pensai volesse aggredirla. Telefonai a un etologo chiedendogli se esisteva questa probabilità. Mi rispose ch’era molto remota. Anche se, da materiale di sua conoscenza, un puma aveva di recente aggredito una signora americana mentre passeggiava al margine di un bosco, ferendola. Ma era un caso assai isolato: si trattava di una femmina col cucciolo, la quale doveva aver veduto nella donna un avversario. Il mio caso era diverso, dal momento che doveva trattarsi di un soggetto probabilmente vissuto in cattività, visto che mostrava dimestichezza con gli umani. Quindi, non lo reputava pericoloso per la gente. Risposta che, tuttavia, non mi soddisfece. Il mio puma, diciamo così, uccideva e sapeva destreggiarsi tra rami di alberi e boscaglie con la spigliatezza e la maestria proprie della sua specie. Assalire una persona, per di più un bambino, gli sarebbe quindi stato facile. Pensiero che, in breve, mi si tramutò in una sorta di incubo. Una mattina molto presto, mentre in macchina risalivo la strada, in prossimità d’una curva fui costretto a inchiodare: per poco non entrai dentro un branco di cinghiali, adulti e piccoli. Dietro avevano il puma che, schivata la macchina, scomparve nel sottobosco. I cinghiali erano invece rimasti allo scoperto nella piana di un uliveto; fatto cerchio attorno ai piccoli, gli adulti non accennavano a muoversi. Finché un verro irsuto non scattò in avanti. Nell’erba alta vidi il puma balzare e, nello stesso tempo, ritrarsi insieme a un grido che si spostava.
Nei giorni seguenti m’accadeva di ripensare all’attimo in cui m’era apparso davanti la macchina e avevo veduto i suoi occhi d’un giallo trasparente. Poi m’era rimasto impresso il suo modo di camminare a piccoli balzi.
Ne trovai le impronte vicine una sorgente; dal terreno umido e renoso, si spostavano nel bosco scomparendo tra le piante. Da uno spiazzo argilloso circondato da alberi caduti, giunse il suo odore. Cominciai a esplorare il circondario. D’un tratto ebbi la sensazione d’essere spiato. Nel mezzo di due carpini vidi brillare la sua testa. Seduto mi osservava, le orecchie appena tirate indietro. Eravamo distanti una ventina di metri. Stranamente, non m’incuteva paura. Ci guardavamo. Immobili. Sprofondai in un silenzio fatto di voli d’api e di mosche. Alcune delle quali ronzavano attorno il suo muso. Mi mossi per andar via. Increspò le fauci come fanno i gatti. Svoltato che ebbi dal bosco alla strada, lui emise un lamento. Mi voltai. Uscito allo scoperto camminava lungo i cespugli, zoppicando su una zampa anteriore. Aveva una spalla lacerata. Inoltratosi nel bosco scomparve. Il messaggio che m’aveva lanciato era chiaro. Non potendo cacciare, sarebbe morto di fame. Dovevo soccorrerlo dandogli della carne. Un amico veterinario mi consigliò di portargli frattaglie con dentro antibiotici.
Seguirono giorni che potrebbero essere un diario, tanti i risvolti e le sorprese, ma preferisco andare per le spicce. Di pomeriggio scendevo fino allo spiazzo d’argilla in mezzo agli alberi con un sacco pieno di interiora di vacca, rognone e fegato. Deposta la carne, m’allontanavo posizionandomi col binocolo. Nel volgere di breve tempo, intravedevo i suoi movimenti nel folto. Veniva a prendere il cibo e s’imboscava. In seguito s’avvicinerà non appena gli volgevo le spalle. Ne avvertivo il rumore lieve e uniforme. Un giorno, con mia sorpresa, lo trovai ad attendermi seduto tra i castagni. Deposta la carne retrocessi un poco. A piccoli passi, la coda oscillante, s’accostò al cibo guardandomi coi suoi occhi d’una trasparenza dorata. Poi, svelto, afferrata la carne si ritrasse. La ferita, vidi, non mostrava più il colore dell’aceto e zoppicava assai meno. Il veterinario mi disse che sospendessi pure la donazione: poteva di nuovo cacciare. Ma io continuai. Per un paio di giorni non si fece vedere. Il terzo lo trovai ad attendermi nel punto in cui solevo depositargli il cibo. Al posto del quale si trovava un piccolo di cinghiale che sembrava ancora vivo. Coda sferzante, emise un brontolio che, sul principio, non compresi se di amicizia o di minaccia, tanto che mi pentii di non aver con me un’arma. Come avesse capito il mio pensiero, tramutò il brontolio in un profondo suono gutturale, analogo alle fusa di un gatto. Fissandomi, atteggiò il muso a un’espressione di dolcezza. Capii, alfine, che mi offriva il cinghialetto. Preso da un impeto di riconoscenza, quasi senza avvedermene, allungai una mano per carezzarlo. Lui mi venne appresso porgendo testa e collo. M’arrivava quasi a metà coscia, e, proprio alla stregua dei gatti, prese a strofinarmi col costato. Morbida e vellutata, la pelliccia gli aderiva su muscoli e ossa che avevano la compattezza di un attrezzo metallico. Il suo odore m’entrava nelle narici, lasciandovi una sensazione agrodolce. Si discostò quando gli sfiorai la ferita: una cicatrice appena chiusa, a forma di falce di Luna. Se n’andò. Appena fu notte i miei cani presero ad abbaiare. Dall’aia mi giunse il tonfo d’un involucro che cade a terra. M’affacciai. Vicino alle scale, giaceva la carogna del cinghialino. Continuava a sembrare ancora vivo. Il puma gli aveva spezzato la schiena lasciandolo intatto. Dal bosco provenne il suo lamento. Lo interpretai come un addio. Aveva infatti adempiuto ai doveri della sua specie: mostrarsi grato verso un essere umano che lo aveva assistito. Mi sbagliavo. Dovendo trasportare della legna, scendevo nel bosco per farne dei fasci. Intento a questa mansione di noia e fatica, avvertii del movimento sui rami di un albero. Il tempo di voltarmi e già il puma, con una sorta di sobbalzo come fosse di gomma, aveva toccato terra. Mi venne accanto e gli carezzai la testa; compatta e rotonda, sembrava l’elmo di un guerriero, mentre il collo era gonfio e teso come il tricipite d’un atleta. Poi si ritrasse, quasi a voler fuggire. Poi mi ritornò appresso. M’invitava a seguirlo. Ora precedendomi ora seguendomi iniziammo a scendere lungo un sentiero. M’avvidi che non riusciva a starmi vicino come, forse, desiderava; la flessibilità della sua colonna vertebrale lo obbligava a procedere a balzi. Così mi precedeva sempre d’una ventina di metri, aspettandomi. Eravamo nel ventre della boscaglia-jungla. Il mondo dei rumori e delle macchine, sembrava lontano, se non inesistente. Provai a tornare indietro per vedere se mi seguiva. Dopo qualche istante sbucò dai cespugli, oltrepassandomi. Ci fermammo in una radura. Bocca semiaperta sui lunghi denti, si sdraiò restando col collo eretto. Mi osservava spiandomi, pareva, non solo nei movimenti, ma anche nelle intenzioni. In realtà ci eravamo come gemellati. Tutto in virtù del più antico dei linguaggi: quello dei boschi, della terra e degli alberi che si rivela soltanto ai suoi eletti, oppure, in casi eccezionali come il nostro. Eravamo di fronte, ammaliati uno dell’altro e ci guardavamo. Dalla bocca, ancora semiaperta, gli spioveva adesso la lingua un poco forcuta e che sembrava dura come una suola di cuoio. A momenti socchiudeva gli occhi, quasi stesse assopendosi. Cosa che, forse, un poco fece allorché sedetti sopra una pietra, sdraiandosi tutto. Altro suo regalo: oltre la compagnia mi concedeva la fiducia. Lo carezzai. Restava immobile sfoderando i lunghi artigli dalle punte uncinate. Poi d’improvviso, come gli fosse giunto un richiamo misterioso, scattò in piedi sparendo nella selva. Luglio e parte d’agosto trascorsero senza che lo rivedessi. Ma un pomeriggio, che mi trovavo davanti casa con degli amici, ne avvertii la presenza. Guardato dalla parte del bosco, ne intravidi la testa tra degli arbusti. Era schiacciato a terra, come per un agguato. Volevo mostrarlo agli ospiti. Ma venni trattenuto da una strana considerazione. Ci sono state persone che hanno avuto la grazia di vedere la divinità; io, invece, quella di vedere e stare con un puma. Meglio, decisi, non rivelarla. Ne andava del suo segreto.
I cacciatori, che nelle loro perlustrazioni in vista dell’apertura della stagione venatoria avevano ricostruito i movimenti del felino, decisero di eliminarlo. Uno di loro m’era venuto a dire del suo covo: si trovava poco lontano da casa mia, nelle impenetrabili sterpaglie che si estendevano, quasi a picco, al limitare di un oliveto. Sogghignando, aggiunse ch’era tutto pronto per tendergli l’agguato: noceva alla caccia e doveva essere eliminato. E mi chiese se, per caso, non l’avessi veduto. La sera medesima, in una corte al centro del paese, presi parte al loro convegno. Erano una decina di individui, di piccola statura, le pance prominenti e i capelli grigi o bianchi. Appassionati di calcio, trascorrevano i meriggi domenicali con le radioline all’orecchio, oppure al circolo davanti il televisore. Se la squadra del cuore era in difficoltà o subiva un gol, le loro facce s’incupivano come quando condannavano il puma. Decisero di attaccarlo al calasole poco prima che uscisse dai roveti. Gli avrebbero sparato a raffica con fucili d’alta precisione, caricati coi proiettili da cinghiale. L’avrebbero fatto all’indomani. Disponevo, quindi, del tempo necessario per ordire un piano in sua difesa. Con questo pensiero mi coricai. Appena desto, sentii d’essere in sintonia col puma come quando n’avvertivo la presenza. Avevo la mente lucida e l’animo sereno. Era una bella giornata. Andai alla volta delle sterpaglie. Volevo accertarmi che ci fosse. M’affidai all’olfatto. Il suo odore era fresco. Mi ritrassi. Cominciavano le ore dell’ansia e dell’attesa. Non mi spostai da casa. Mi bastava il binocolo. I cacciatori sarebbero discesi da un certo sentiero traversando boschi e coltivato. Dovevano agire in incognito. Per la legge erano bracconieri. Venne infine il momento che li vidi incamminarsi. Procedevano in fila indiana, accosto agli alberi sfiorati dal tramonto. Sembravano un drappello d’ombre. Anch’io mi mossi e, assai prima di loro, giunsi sul posto. L’odore del puma era greve: era rimasto lì il giorno intero. Presi dei sassi, li scagliai nella sterpaglia. Subito, udii dei soffi. Parevano gli sfiati di un camion che frena. Seguì un forte scricchiolio di arbusti che si spezzano. Stava andandosene. Dovevo battere la ritirata prima dell’arrivo dei cacciatori. Appena ebbi scollettato, crepitò la raffica della fucileria. Silenzio. Finché il vento della sera non mi recò le loro voci. Certi d’averlo crivellato, se ne compiacevano come quando la squadra del cuore vinceva la partita. Invece l’avevano persa. Ho infatti saputo che lui si trova sull’altro versante della montagna, in una riserva. L’hanno visto cacciare caprioli. Ma, prima o poi, sento che ci rivedremo. Forse sarà lui a tornare. La sua mente selvaggia, proprio perché selvaggia, non può avermi dimenticato.
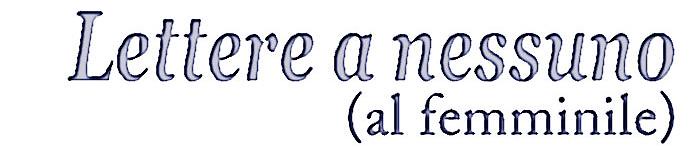
Nessun commento:
Posta un commento