La scorsa estate (agosto 2007) sul “Corriere della sera” si è svolta una polemica fra il critico letterario Giorgio Ficara e lo scrittore Alessandro Piperno circa il romanzo italiano di questi anni, che sta purtroppo voltando le spalle, a detta del critico, alla coraggiosa ricerca formale dell’intero Novecento. I narratori di oggi pare non si confrontino più con il senso della crisi: le strutture narrative paiono insomma persino troppo sicure di sé, tanto da adeguarsi senza alcun dubbio alle convenzioni. Senza che sia necessario estrapolare dal lavoro di Ficara, non è fuor di proposito ricordare alcune opere del primo Novecento, così ricco di proposte e spunti di riflessione. Senza che vi sia fra loro un particolare legame, ho scelto un romanzo incompiuto di Federigo Tozzi, un anti-romanzo di Massimo Bontempelli e un lungo racconto fantastico di Tommaso Landolfi.
Secondo Tozzi, per esempio, “gli effetti sicuri sono all’opposto della forza lirica (…) Ai più interessa un omicidio o un suicidio, ma è egualmente interessante, se non di più, anche l’intuizione e quindi il racconto di qualsiasi misterioso atto nostro; come potrebbe essere quello, per esempio, di un uomo che a un certo punto della strada si sofferma per raccogliere un sasso…” (“Come leggo io”, articolo pubblicato nel 1918, poi in Realtà di ieri e di oggi, Alpes, Milano 1928). A suo avviso può servire una pausa di riflessione e l’occasione di questa sosta gli si presenta nei bozzetti, nei frammenti: “i così detti frammenti lirici (…) sarebbero un segno miserevole se appunto non servissero a una sosta; di cui non si poteva fare a meno.” (“L’acqua fa l’orto”, in Realtà di ieri e di oggi).
Voltando le spalle agli artifici letterari, quel che si cerca è un rapporto più immediato, quasi elementare con la realtà. Di qui la scelta del diario come struttura narrativa, per esempio. Il vecchio narratore onnisciente ha già fatto il suo capitombolo ed è diventato, da dio unico dell’opera, un personaggio in mezzo agli altri, catturato anch’egli dal caos del mondo.
Nei Ricordi di un impiegato (uscito postumo nel 1920) Leopoldo viene strappato a una giovinezza di studi e fantasticherie e costretto dal padre a lavorare. Il protagonista che tiene un diario non è più l’esteta che sonda il ricco universo delle correspondances e gli dà significato grazie alla sua ipersensibilità romantica; e neppure lo scienziato che analizza in una specie di laboratorio il tessuto sociale in cui vive. Destituito dalla sua posizione d’artista privilegiato o di olimpico studioso, egli è un uomo come tanti, un semplice travet, un lavoratore qualunque sottoposto all’inflessibile legge dell’alienazione: deve dare concorsi pubblici, magari cambiare città per trovare un posto fisso, fare delle rinunce rispetto ai suoi sogni di realizzazione personale o sentimentale. Altroché vivere inimitabile! “… alla ricchezza del mondo interno si contrappone una realtà esterna sempre più ripetitiva, una società spietatamente meccanica dominata dall’automatismo” osserva Rossana Dedola nel Romanzo e la coscienza (Liviana, Padova 1981). La difficoltà dei conflitti e dei rapporti umani diventa talvolta insormontabile. Fra Leopoldo e i suoi colleghi si scava un abisso e i giorni trascorrono uguali senza che si presentino elementi tali da rendere possibile un qualche processo d’identificazione o di scambio. Persino la natura, che di consueto concedeva attimi di pacificazione al passeggiatore solitario, non riesce a compensare la negatività dell’ambiente: “Mi fermavo a guardare i frutti e i cipressi lungo i confini e in cima alle strade che portavano alle case dei contadini. Mi pareva che io potessi vedere la terra doventare quei frutti e quegli alberi. Il sole era dolcissimo; perché sempre basso, e la sua luce s’intratteneva tra le piante. Gli uccelli volavano dai rami sopra la strada e andavano negli altri campi. Essi facevano scuotere le gocciole della rugiada; anche addosso a me. Le finestre dei contadini erano chiuse, con sportelli verniciati di rosso; e l’erba cresceva da per tutto, anche sui margini della strada. Mi sentivo contento di essere solo, e non mi ricordavo affatto di niente. Io volevo fuggire e non tornare più a casa. Il cielo mi abbagliava. Mentre stavo così, io mi volsi e vidi vicino a me un uomo che mi guardava sogghignando. Mi venne da piangere, e non ho più dimenticato quei campi”. Egli rimane bloccato in una posizione ossessiva e paranoide. Benché questo romanzo non prescinda completamente da una trama, prosegue Dedola, “…gli avvenimenti si accavallano gli uni sugli altri senza uno stacco spaziale e temporale che dia loro una prospettiva. Acquistano perciò importanza le zone non funzionali allo sviluppo narrativo (le distrazioni tozziane)…”. Luigi Baldacci parla di “montaggio di spezzoni senza modulazioni di passaggio” e la realtà risulta scomposta in piccoli incubi quotidiani.
Un altro romanzo di quegli anni che mostra grande abilità nell’aggirare o nel depotenziare diversi cliché letterari è La vita operosa di Massimo Bontempelli (scritto nel 1919, pubblicato nel 1920 a puntate su rivista, quindi nel 1921 in volume da Vallecchi). Ancora più di prima ci troviamo sbalzati in una società industriale che lavora a pieno ritmo nello spazio fra le due guerre. La nuova società è complessa, iperproduttiva e sempre in movimento. Il narratore-protagonista tenta di far fortuna nientemeno che in una metropoli tentacolare: “Quando, due mesi dopo l’armistizio, rientrai (come dicevamo allora) in Italia, mi sono trovato nella città di Milano, aperta campagna per le maggiori battaglie della vita; mi sono ritrovato nell’aperta campagna di Milano, senza bussola, né orologio, né sole, né stelle.” La metafora militare iniziale dà un’idea delle difficoltà e degli scontri che si possono produrre in questo agglomerato urbano in pieno sviluppo, ma nello stesso tempo l’immagine di un campo di battaglia illuminato a giorno è notevolmente spiazzante rispetto alla tradizionale iconografia della città moderna, notturna e intrigante come Londra o Parigi. Infatti qualcuno ha parlato in proposito di “città priva di aura”. Per essere ancora più espliciti, fin dalle prime pagine viene ripreso e completamente rovesciato l’archetipo della passante di Baudelaire. “…una donna (…) camminava morbidamente verso non so qual sogno o realtà fascinosa, e presto mi scomparve e non ebbe mai nome per me; era bellissima e aveva corta e densa la pelliccia e lunghe e rade le calze, e due occhi di carbone e di luce. Come si allontanava, mi sorpresi a mormorare una frase di estasi ammirativa, che fu la seguente: ‘Perdio, qui bisogna trovar modo di fare molti quattrini’.”
In questo romanzo non vi sarà spazio né per donne fatali né per drammi amorosi, ma ritorniamo al mito della ricchezza. Sempre con grande ironia, colorita per l’occasione da un tocco di realismo magico, Bontempelli ci descrive la prosperità circostante: “Il cielo era coperto e l’aria un velo grigio; ma di tratto in tratto le vie s’illuminavano di lunghi bagliori folgoranti, perché rapide correnti d’oro invadevano il cielo, s’insinuavano tra le linee dei tetti, volavano sopra le strade della città con una voce d’aeroplano giovane. Le correnti dell’oro a ogni momento urtando negli spigoli dei tetti si frangevano e mandavan giù rutilanti cascate a zampillar sui marciapiedi sotto lo sguardo dei passanti.” Tutti quanti sono abbagliati dal miraggio della fortuna. E la prima occasione per mettere alla prova se stessi non tarda a presentarsi: proviene da qualcosa che proprio non ci riguarda più oggigiorno… la pubblicità! L’episodio del lancio pubblicitario ipotizzato dal protagonista per una sorta di fumeria d’oppio è estremamente gustoso. In quanto progetto di un uomo di cultura, consta principalmente di un’articolata fase preparatoria, con tanto di letture di Omero da tenersi all’università, nonché spettacoli teatrali ispirati ad autori famosi dediti alle droghe, ma viene immediatamente liquidato come “professorume e scrivaneria”. La nuova epoca ha bisogno di uomini d’azione, men che mai di pensiero. L’antieroe protagonista procede così da una gaffe all’altra fino alla rinuncia definitiva alla carriera negli affari. E, oltre che da varie sorprese e sgambetti narrativi, noi lettori rimaniamo felicemente colpiti dalla trovata dello sdoppiamento del narratore, che non solo si presenta nelle vesti di un personaggio come gli altri, soggetto quindi agli eventi e alle beffe del destino, ma si trova anche combattuto fra un sé ambizioso, avventuroso e intraprendente e un demone filosofo che lo fa cadere spesso in contraddizione. Una voce narrante continuamente contraddetta da se stessa mi pare uno spunto interessante su cui meditare.
In ultimo, un esperimento fantascientifico di Tommaso Landolfi, scritto nel 1949, dapprima pubblicato su rivista, poi in volume da Vallecchi nel 1950. Cancroregina è una delle prime opere italiane di fantascienza, ma, lungi dal mostrare interesse per la tecnologia, pare tragga giovamento più che altro dai risvolti surreali che il genere consente.
Anche qui l’attenzione maggiore è concentrata sulla figura del narratore, questa volta addirittura impazzito. La questione centrale (nel Novecento) del rapporto fra narratore e personaggio si spinge fino alle sue estreme conseguenze: la sfida è la rappresentazione che una mente folle può dare di se stessa.
In una notte di particolare abbattimento un uomo solitario e depresso si lascia convincere da un sedicente inventore (nonché pazzo fuggito dal manicomio) a seguirlo sulla sua navicella spaziale con direzione: Luna. Cancroregina è il nome della macchina volante, di cui l’inventore è oltretutto innamorato e geloso. I due compagni di viaggio, alla deriva nello spazio, impazziscono entrambi.
Alla fine gli eventi narrati sul diario di bordo potrebbero essere interpretati in vario modo: il narratore potrebbe aver descritto semplicemente una sua allucinazione oppure potrebbe essere lui l’unico pazzo assassino della vicenda, mentre l’amico potrebbe essere una persona del tutto normale nonché sua vittima. Così pure si può credere al contrario. Dal momento che l’io narrante è dichiaratamente folle, tutto è possibile. L’aspetto più interessante della situazione è proprio la ricerca di un linguaggio della follia. Essa pervade ogni cosa a cominciare dalla struttura narrativa, che si presenta inizialmente in modo piuttosto tradizionale (racconto di fatti strani, forse sognati) per diventare diario sui generis, con un’ampia sezione dedicata al finale delirio di persecuzione. L’autore ci mostra, tra il serio e il faceto, un ampio repertorio di scrittura degenerata: dalle varie allucinazioni paranoiche, popolate da inverosimili blatte, parameci o insetti non meglio identificati, alle visioni leggiadre dei mitici abitanti della Luna, dal discorso assolutamente ermetico del delirio (“Mangiato sesquipedale e draglia scopo combattere anguria…”) all’impossibile dialogo con la capricciosa astronave sfuggita al suo controllo. Nell’ultima pagina, ciliegina sulla torta, la narrazione diventa surreale, in quanto appartenente ormai ad un morto (che in ogni caso, ancora per tragica ironia, non si libera del tutto della sua angoscia: “Son morto da due giorni. Però niente è cambiato…”).
Nell’impossibilità di raccontare il mondo (secondo l’accurata analisi di J. Schramke, Teoria del romanzo contemporaneo), l’uomo contemporaneo si volge in se stesso e cosa trova? Un paesaggio altrettanto incomprensibile: la follia.
Bibliografia
Massimo Bontempelli, La vita operosa, SE, Milano 1988
Rossana Dedola, Il romanzo e la coscienza, Liviana, Padova 1981
Giorgio Ficara, Stile Novecento, Marsilio 2007
Tommaso Landolfi, Cancroregina, Adelphi, Milano 1993
J. Schramke, Teoria del romanzo contemporaneo, Liguori, Napoli 1980
Federigo Tozzi, Ricordi di un impiegato, da I romanzi, Vallecchi, Firenze 1961
(rivista “Il primo amore” n 2, 2007)
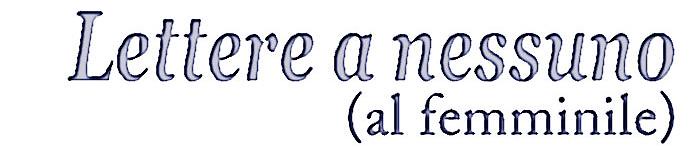
Nessun commento:
Posta un commento