Dopo aver letto Cristi polverizzati sorge spontanea la curiosità di sapere com’è stata la seconda parte della sua vita, quella vissuta in Norvegia. Come avvenne che andò a lavorare proprio a Oslo? Fu facile ambientarsi in un Paese così diverso dal nostro?
Avevo ventitré anni nel 1953 e per puro caso trovo un editore che mi pubblica la mia prima raccolta Non possiamo abituarci a morire,prefazione Franco Fortini, questa raccolta mi procurò solo irrisioni e portate in giro, la raccolta peggiorò la mia situazione avrei potuto trovare da lavorare solo come facchino muratore sono alto 1,66 pesavo 56 chili, ero gracilissimo e il lavorare come facchino muratore mi distruggeva, una domenica mattina per puro caso nella piazza di Fermo vicini ad una rivendita di giornali conobbi un signore, parlando del più e del meno mi disse che era per pochi giorni a Fermo dove era nato e avendogli detto che ero disoccupato mi disse di un suo ristorante a Bruxelles dove mi avrebbe dato lavoro. Mi licenzio da facchino di muratore e parto. Arrivo a Bruxelles a notte tarda, dormo in una panchina della stazione e al mattino mi presento al ristorante, in verità era un ristorante albergo, mi danno da lavorare come lavapiatti e un posto per dormire. Tutto fila bene per un certo periodo poi scoppiò una cagnara con una che lavava i piatti come me. Faceva delle cose disgustose, i bicchieri che ritornavano per essere lavati spesso contenevano vino rimasto e il mio compagno se li scolava tutti sino ad ubriacarsi e il lavoro che dovevamo fare in due lo facevo io solo. Mi stancai di questa storia e mi misi a capovolgere il vino che rimaneva nei bicchieri velocemente.
Scoppiò una scazzottata furibonda, vennero i superiori e tutta la colpa della cagnara fu mia, venni licenziato seduta stante, mi pagarono la mesata e via, mi trovai in mezzo la strada con pochi soldi e senza un posto per andare a dormire, vado alla stazione con l’intenzione di riposare su una panchina, vengo a trovarmi vicino ad un giovane come me e parlando del più e del meno mi disse che aspettava il treno per Oslo, cominciò a parlarmi bene di questa città ed io in seduta stante dissi che parto per Oslo anche io. Arrivo a Oslo con una piccolissima somma, cinquanta corone norvegesi, circa 10 euro, trovai da dormire dall’Armata della Salvezza, un grosso camerone con una cinquantina di letti, faccio un giro per i ristoranti e armato di una sola parola norvegese “arbeide” trovai da lavorare in un ristorante vicino alla stazione. Arrivai a Oslo nei primi di maggio, lavorai nel ristorante sino all’autunno, poi per un caso fortunato trovai da lavorare in una fabbrica metallurgica, la Christiania Spigerverk. Bisognava imparare il norvegese comperai un piccolo dizionario italiano-norvegese e norvegese-italiano, iniziai a comperare i fumetti, Topolino e Paperino, e cominciai ad ambientarmi, andare a ballare il sabato sera, parlare con i compagni di lavoro norvegesi, tutto iniziò senza problemi, che la cosa sia stata così facile ora meraviglia anche me e nel marzo del 1960 incontro Mary quella che sarebbe stata mia moglie. Con una grandissima incoscienza ci sposammo, abitavamo in una piccola cameretta con entrata indipendente, poi con mia moglie incinta la fabbrica mi aiutò per trovare un piccolo appartamento di una camera e cucina. Così iniziò la nostra vita e nonostante i vari avvenimenti e problematiche io scrivevo sempre, dovevo portare a termine la mia seconda raccolta.
Negli anni cinquanta l’Italia non le diede il lavoro (e dire che erano gli anni della ricostruzione e presto ci sarebbe stato il boom economico). Lei dovette emigrare. Ha del risentimento nei confronti di un Paese che non riuscì a offrirle nemmeno un posto da “guardiano dei gabinetti”, secondo le sue stesse parole, benché lei avesse già mostrato fin da giovanissimo uno spiccato talento almeno per qualcosa, la letteratura?
Certamente nessun risentimento verso l’Italia, forse un certo risentimento verso i compagni di partito, i comunisti di Fermo, quelli della sezione del partito comunista che non hanno cercato di aiutarmi neppure con consigli e con una certa comprensione. Anzi, quando nel 1953 pubblicai la mia prima raccolta nelle pagine dell’”Unità”, venne pubblicata una stroncatura alla mia raccolta che mi accusava di anarchismo e populismo. Questa stroncatura non me l’aspettavo proprio, mi depresse in una maniera paurosa, pubblicare la mia prima raccolta significò proprio una frattura completa con l’ambiente in cui vivevo. Perfino in famiglia la cosa era vista male, non dovevo scrivere certe cose, non dovevo sputtanare Fermo con la poesia che ha per titolo “La città dove viviamo”.
Dopo oltre cinquant’anni di vita in un Paese scandinavo ritiene che davvero si viva meglio che da noi (come abitualmente pensiamo), che siano maggiormente rispettati i diritti di ciascuno?
Certo Italia è l’Italia, io sono italiano in maniera totale nonostante sia vissuto in Norvegia dal 1957, ormai per cinquantadue anni, non ritornerò più in Italia, sono stato molto male e ora mi trovo in uno stato di grande debolezza fisica e il pensiero di un mio impossibile ritorno mi fa star male. Però la Norvegia è un paese avanzatissimo dal punto di vista umano. Basta pensare che un extracomunitario fa parte del governo norvegese, nel parlamento norvegese ci sono diversi extracomunitari, stessa cosa nel consiglio comunale di Oslo, quando a Roma per sindaco abbiamo un fascista. La mia pensione potrebbe farmi vivere degnamente se non dovessi aiutare mio figlio che si è venuto a trovare in una situazione disperata.
L’alienazione del lavoro in fabbrica, che ha occupato l’intera sua vita lavorativa, più di trentacinque anni, ha avuto un peso significativo per lei? E’ servita anche da stimolo per la scrittura?
Ho lavorato in fabbrica dal 1957 sino al 1994, per trentasette anni, lavoro terribile, basta pensare che quando ho degli incubi sogno di essere stato sbattuto in quel reparto. Ho sognato di essere dentro un ascensore che precipitava continuamente a fortissima velocità e alla fine si ferma di botto e mi scaraventa nel reparto dove ho lavorato per trentasette anni. Comunque il lavoro in fabbrica mi ha permesso di mantenere la mia famiglia di figli quattro e di continuare a scrivere tutti i giorni. Poi nella fabbrica ho incontrato gli amici più cari, amici fraterni, una diecina di norvegesi che a volte incontro e da lontano iniziano a urlare Ruscio Ruscio e mi abbracciano.
L’italiano è una lingua che non si parla nella sua famiglia a Oslo. Esprimersi in una lingua che non è quella quotidiana ma appartiene all’infanzia, un’infanzia per di più sgrammaticata e indisciplinata, un pezzo di vita lontanissima e perdutissima, rende l’operazione del suo scrivere fin dalle premesse un po’ surreale, fuori dall’ordinario. Vuole dirci qualcosa a proposito di questa lingua tutta particolare?
Che posso dirvi della mia lingua, la lingua con cui scrivo si è formata naturalmente dentro di me frequentando giornalmente il norvegese. Qui da Oslo scrivo e leggo in italiano ma io l’italiano lo parlo raramente tanto che la lingua italiana diventa lingua letteraria, il norvegese lo leggo e lo capisco come un norvegese ma lo parlo molto male, l’italiano è come l’anima mia, certamente non è un’anima candida. Si sporca continuamente e non sarà più l’italiano dell’Italia di oggi. Insomma la mia “lingua particolare”, il mio “italiano particolare” è venuto a formarsi naturalmente, essere “sbattuto” nel posto più appropriato per la mia formazione. Tenete sempre presente che vivo in Norvegia dal 1957, cinquantadue anni di vita in Norvegia e appena per ventisette anni sono vissuto in Italia, come ho già detto il mio italiano è quello di quando sono partito, più di mezzo secolo fa, e delle mie letture continue.
A proposito dello stile sgrammaticato, ci sono in Cristi polverizzati almeno due frasi molto significative, una che rimanda al linguaggio familiare e una più propriamente politica: "Tutte le storie raccontate in maniera tanto diversa ed opposta, la menzogna del maestro espressa con un italiano illustre, dall'altra parte la verità che mi raccontava nonna con un linguaggio straziato che si sarebbe prestato solo all'irrisione, così ho intuito prestissimo che i linguaggi illustri, raffinati, aulici sono i linguaggi della menzogna, la verità si esprime con una verbalizzazione stritolata, inceppata e caotica, una verbalizzazione straziata." (p. 41); "Io avevo anni quattordici e sognavo di diventare partigiano, scappai via di casa e arrivai in un paese dove c'erano i partigiani che mi dettero un calcio in culo e mi rimandarono a casa: Vai a casa! Vai a casa, scemo! Ferito nell'orgoglio me ne tornai indietro, babbo mi chiese dove ero stato e io zitto, custodii il segreto del mio tentativo di essere anch'io tra i liberatori rossi e garibaldini. E nonostante il mio affabulare, mai sarò tra i liberatori. Allora mi chiudo qui, almeno a liberare le parole e poter dire come disse e scrisse il grandissimo poeta ho adoperato le parole che nessuno osava." (p. 56).
La sgrammaticatura, conseguenza penalizzante di un profondo divario sociale d’origine, eletta a sistema, diventa consapevolmente eversiva, strumento di una battaglia culturale e politica portata avanti attraverso le matte scritture…
La sgrammaticatura, conseguenza penalizzante di un profondo divario sociale d’origine, eletta a sistema, diventa consapevolmente eversiva, strumento di una battaglia culturale e politica portata avanti attraverso le matte scritture…
E' difficile dire qualcosa sul tema delle "trasgressioni” linguistiche perché quello che io scrivo ha una valenza poetica, non è una ideologizzazione, cioè è come fosse la voce di un personaggio, cioè quello che ho scritto sulle trasgressioni non sempre è vero, però è bello pensare in questa maniera. Insomma bisogna tenere presente che sono un poeta, poi è da tener presente il perenne conflitto con me stesso tanto da farmi scrivere che vedendomi improvvisamente nelle specchio ho avuto l'impressione di vedere il mio proprio assassino. Un professore universitario mi manda le sue poesie, non erano male e gli scrissi che la poesia è roba di disgraziati, come disse Montale in una sua intervista, basta un pezzetto di carta e una matita per scrivere dei versi, è meglio che uno dedichi la propria intelligenza
in qualcosa di più utile a se stesso e alla società. Sono stato proprio io a scoraggiare un giovane poeta proprio io che avevo scritto questo: “Non disperate, mettetevi a scrivere le poesie, ne ricaverete rilassatezza, felicità gestuale, leggerezza nei contatti con il prossimo vostro, sentirete la presenza degli Dei in prossimità della tua ombra, gioia lavorativa, aumento vertiginoso nella creatività in tutti i campi, sviluppo della personalità. Leggermente folle correrai verso tutte le sciagure, ti crederai inseguito da bande antiblasfemiche armate di mazze ferrate, sfuggirai ai pericoli con rapidissime fughe, potrai metterti a volare come niente fosse, diminuzione vertiginosa della rigidità muscolare e anche mentale, diminuzione dei mali di testa, sarai in preda a dolcissimi spasimi sessuali. Iscrivere poesie a occhi chiusi, sgranare frasi una dietro l’altra con la massima velocità sino al punto che la battitura segue perfettamente il ritmo delle pensate anche quelle più stravaganti, velocità massima nel concatenare libere associazioni, scrivere con la schiena bene appoggiata alla spalliera della sedia, tenere la testa non troppo reclinata sulla tastiera, da oggi tutte le ore sono le nostre mi disse un poeta, fa’ rimbalzare tutto sulla tastiera. Piove, nevica, suona il telefono alla porta tu inchiodato davanti alla tastiera della macchina da scrivere”.
La ribellione permanente contro la lingua ufficiale, ma anche contro i vari condizionamenti e mode di questo periodo storico particolarmente conformista, la rende discepolo autodidatta di un continuo sperimentalismo e apprendistato: “In questi problemi abbiamo lasciato il nostro, che chiamiamo dilettante e autodidatta perché è rimasto in un apprendistato sperimentalistico eterno. Insomma fa le prove, apprendendo in maniera permanente (…) Forse questo sperimentalismo o apprendistato è inevitabile per ogni scrittura, ma lui questa posizione la spinge fino alle ultime conseguenze ed è come perennemente sospeso, come sempre sul punto di, sempre nella predisposizione, ma mai oltre…” leggiamo in Palmiro, il suo primo romanzo (Baldini&Castoldi, Milano 1996, p. 85; prima edizione Il lavoro editoriale, Ancona 1986). Oltre che per l’aspetto lessicale e sintattico, i suoi romanzi sono sperimentali anche come genere e struttura. A me pare che nascano e si sviluppino senza un’idea prestabilita…
I miei romanzi sarebbero sperimentali. Non è proprio vero, non faccio sperimenti, ho scritto nell'unica maniera che mi è possibile. Iniziai a scrivere il Palmiroverso il 1955 subito dopo aver scritto la prima raccolta nel 1953, avevo raccolto nella sezione del partito comunista di Fermo molti manifesti non adoperati, scrissi sul risvolto di quei fogli quello che sarebbe diventato il Palmiro. Emigrai in Norvegia nel 1957 e dopo alcuni anni ritornando per le ferie estive a Fermo a casa dei miei genitori ritrovai quei fogli dimenticati. Ritornai ad Oslo, decisi di ricopiare tutto, riscrivendo tutto mi liberavo, era come se fossi in una continua catarsi, ricopiavo, scrivevo e riscrivevo ridendo continuamente tanto che mia moglie pensava che fossi ammattito. Come vedi nessuno sperimentalismo, scrivo nell'unica maniera che in quel momento mi era possibile, non posso scegliere una maniera di scrivere, scrivo nelle sola maniera che mi è possibile.
Il nucleo originario di Cristi polverizzati è costituito dai ricordi d’infanzia e giovinezza (un’infanzia mitica, assoluta, secondo l’espressione di Marco Rovelli su “Alias” del 10-10-2009), che si addensano in un corposo memoriale “stravolto da furia espressionista” (Massimo Raffaeli su “La Stampa-TuttoLibri” dell’1-7-2009), o vi sono ceppi romanzeschi diversi, di romanzi precedenti forse rimasti allo stato embrionale e cresciuti poi tutti insieme in un più grande progetto narrativo?
Cristi polverizzatiha una gestazione estremamente complessa, negli anni settanta a Fermo c'era un foglio “Garofano rosso”, e i dirigenti di questo foglio decisero di dedicarmi un numero con il mio contributo, nel numero del 9 marzo 1977 compaiono in “Garofano rosso” 27 poesie, che verranno ripubblicate nella mia terza raccolta Apprendistatidel 1978, e un racconto che verrà ristampato in Cristi polverizzati, stampato quest'anno nella collana fuoriformato diretta da Andrea Cortellessa. Cioè questo romanzo l'ho iniziato negli anni settanta e l'ultimo capitolo che ho scritto è proprio quello all'inizio di questo romanzo. Ho lavorato in questa maniera: rileggendo quello già scritto mi veniva in mente di fare aggiunte e queste aggiunte potevano capitare alla fine o all'inizio e nel mezzo del romanzo e tutto questo veniva fatto per impulsi rapidi, poteva venirmi in testa di adoperare un brano che avevo destinato per un racconto per esempio. Tutto questo insomma non per scelta ma per impulsi veloci. Il numero di “Garofano rosso” con le mie scritte è molto bello, è accompagnato anche da una serie di fotografie di Luigi Crocenzi che erano state pubblicate nel primo dopoguerra sul “Politecnico” di Elio Vittorini.
Il riferimento costante alle matte scritture (Cristi polverizzati) mi fa pensare allo studio matto e disperatissimo di Leopardi. Tra l’altro l’incipit di Palmiro contiene memorie leopardiane: “Nella biblioteca c’era un infinito tutto scritto. Si poteva anche riscrivere tutto. Quell’infinito emanava un grande odore di sudore seccato: da questo enorme odore venne fuori l’espressione le sudate carte leopardiane”(p. 13). (A me pare, per esempio, tra le altre cose, che con il Leopardi ci sia questo tratto in comune: per Leopardi prosa e poesia sono la stessa cosa, la poesia non è data dal verso, la poesia è opera d’immaginazione quindi può essere espressa indifferentemente in versi o in prosa. Inoltre c’è l’importanza della fedeltà al vero.). In generale si trovano molte citazioni di poeti e filosofi nei suoi scritti. A quali poeti e prosatori si sente soprattutto legato?
Ero giovanissimo, avevo fatto solo la quinta elementare e verso i quattordici anni mi capita tra le mani la Divinacommedia, iniziai a leggere con continuo entusiasmo tanto da imparare interi canti a memoria a forza di rileggerli. Veramente sono stato sempre un grande lettore, con i compagni d'infanzia ci scambiavamo i libri i fogli i fumetti che riuscivamo a trovare, solo verso i quattordici anni mi imbatto nella Divina commedia,non fu certo questo libro a farmi iniziare a scrivere le poesie, nello stesso periodo leggevo Leopardi e Foscolo ma chi mi fece diventare poeta fu la lettura dei Lirici nuovidi Luciano Anceschi del 1942, trovato nella biblioteca di Fermo che frequentavo molto spesso. Ho scoperto il verso libero, poi in questi lirici nuovi non trovai un verso che dicesse della nostra vera vita, della nostra miseria e così nacque la mia prima raccolta Non possiamo abituarci a morire,che venne pubblicata per puro caso nel 1953. Avevo spedito ad una rivista di giovani una mia poesia e venni invitato ad un convegno di giovani poeti a Pontedera, non potevo recarmi a Pontedera perché non avevo una lira per il viaggio, parlando di questo con Luigi Crocenzi ebbi da lui i soldi per il viaggio. (Luigi Crocenzi è conosciuto per aver illustrato con le sue fotografie una edizione di Conversazione in Siciliadi Elio Vittorini). Durante il convegno fu letta una mia poesia e all'uscita mi fermò Arturo Schwarz che mi disse che dovevo mandargli tutte le mie poesie, ho spedito la raccolta che aveva per titolo semplicemente Poesie per un vicolo, fu Franco Fortini a trovare il titolo definitvo: Non possiamo abituarci a morire.
Lei è stato più volte associato allo scrittore ceco Bohumil Hrabal, i cui personaggi, dal punto di vista di umili lavoratori emarginati, riescono a vedere la realtà in una luce insolita e straniata, carnevalesca e rivelatrice. Pure lei rivendica una posizione straniata ed emigrata ("… qui c'è solo l'abbacinazione per la mia condizione disoccupata e straniata che diventerà anche emigrata…", Cristi polverizzati, p. 151). Riconosce questa somiglianza con Hrabal?
Disgraziatamente Hrabal non l'ho mai letto, anche Enrico Capodaglio mi disse di questo scrittore che non mi sono neppure preoccupato di cercare.
Nell’opera di Carlo Emilio Gadda la lingua non è mai accettata passivamente ma costantemente trasformata e reinventata (anche se Gadda lavora più sul lessico che sulla sintassi, mentre in Di Ruscio troviamo costruzioni ad sensum, anacoluti, una sintassi contorta e distorta, con frasi secondarie che si ribellano all’egemonia della principale, si sganciano e disarticolano, la lingua, sentita come carcere sociale e di classe, forzata il più possibile). Lei sente una vicinanza per esempio al Gadda del Pasticciaccio?
Gadda mi ha profondamente affascinato, lessi qui in Norvegia il Ducato in fiamme, soprattutto il racconto L'incendio di via Keplero,che considero uno dei capolavori della letteratura non solo italiana. Certo Gadda mi ha aiutato non certo ad imitarlo ma mi ha aiutato a rendermi più libero, nel senso che potevo andare oltre alla scrittura normale, potevo toccare anche argomenti scabrosi, insomma la lettura di Gadda mi diede vigore. Ho trovato Gadda in una biblioteca pubblica di Oslo, trovai uno scaffale di romanzi italiani, tutti i libri messi per ordine alfabetico, Bacchelli era il primo e mi lessi molti libri di Bacchelli, poi tutti gli altri, oltre a Gadda mi ha colpito anche un libro del fratello di De Chirico che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Io di De Chirico ho appeso in cucina la riproduzione di un quadro metafisico che mi è caro perché mio figlio quando aveva quattro o cinque anni, indicandomi col ditino l'illustrazione, disse una cosa che non dimenticherò mai: “QUELLO E' IL POSTO DOVE ERAVAMO PRIMA DI NASCERE”.
Nella postfazione di Antonio Porta a Palmiro si legge che “la comunicazione di Di Ruscio è in presa diretta (…) il tempo della narrazione di Luigi Di Ruscio è il presente del momento stesso in cui si racconta. Al tempo presente della presa diretta di cui si è appena detto, la comunicazione può giocare vittoriosamente le sue carte. Gli effetti di straniamento garantiscono che la coscienza critica dell’autore è sempre vigile e pronta a rintuzzare le malizie involutive dei sentimenti” (p. 176). Quest’esigenza della coscienza vigile, di testimoniare la verità del nostro tempo, smascherando le mistificazioni e gli inganni, direi che è la vera trama dei suoi romanzi. Condivide?
Come ho già detto, ho scritto e soprattutto riscritto Palmiromolto liberamente senza nessuno scopo cosciente, la riscrittura del libro fu una specie di liberazione, riscrissi con tutta la mia allegria, io sono molto grato ad Antonio Porta, sino alla sua morte avvenuta nel 1989 mi ha sempre aiutato facendomi pubblicare poesie nel suo bellissimo settimanale letterario “Alfabeta”. Ho un grosso gruppo di sue lettere scritte con la sua strana calligrafia, dovrei ritrovarle e cercare di salvarle. Però Porta del Palmirofa una sua lettura e per esempio la parola "straniamento”, "coscienza critica sempre vigile dell'autore" sono cose che un intellettuale come Porta trova nella mia scrittura ma non sono cose da me volute, scrivo sempre liberamente con il solo scopo di scrivere e spesso lo scrivere mi eccita tanto che il viso si imporpora tanto che in queste occasioni mia moglie mi domanda cosa mi sta succedendo forse perché sembra che sia l'imporporamento dell'orgasmo. La mia riconoscenza per Antonio Porta è tanta anche per questa recensione pubblicata sul “Corriere della sera” di domenica 11 maggio 1979. Che qui voglio riportare:
UNA PALLA DI NEVE ALL'INFERNO
Luigi Di Ruscio è nato a Fermo nel 1930 e da circa venticinque anni vive in Norvegia, dove lavora come operaio in un'industria siderurgica di Oslo. Ha preso piena coscienza della propria volontà di poesia partecipando ai convegni di giovani poeti organizzati da Lucio Lombardo Radice. Erano gli anni in cui la rivista “Momenti” cui Di Ruscio collaborò assiduamente, indicava con forza ai poeti nuovi la strada dell'impegno sociale e del rifiuto dei linguaggi letterari. Ma si sa quante bugie contengono le dichiarazioni di poetica: infatti Di Ruscio ha esordito nel 1953 con una raccolta di poesie Non possiamo abituarci a morire (Editore Schwarz, prefazione di Franco Fortini) in cui il linguaggio letterario resiste felicemente agli assalti della cronaca e della storia, affermandosi con una limpidezza e insieme un'arguzia di dettato che testimoniano a favore di una capacità di dire quasi mai inquinata dalla retorica neorealista. Dalla poetica neorealista ha invece saputo prendere il meglio: la rapidità della scrittura e l'assenza di indugi, e anche la forza nella lotta che non lo abbandona mai. Nel 1966 è uscita, presso l'editore Marotta, la seconda raccolta, Le streghe s'arrotano le dentiere, con prefazione di Salvatore Quasimodo. Nonostante tali autorevoli e partecipi segnalazioni, con molta ragione Giancarlo Majorino è stato costretto a scrivere, nella discussa ma utilissima rassegna di poesia dal '45 al '75, Poesie e realtà (Editore Savelli, 1977), che la poesia di Di Ruscio è “sconosciuta o quasi ma intensissima… Ora siamo al terzo libro Apprendistati e si ha l'impressione che l'occultamento di un poeta, che non si può esitare a definire di primissimo piano, continui”.
È curioso dover osservare che anche nello svilupparsi della scrittura poetica, intesa anche come opera “collettiva”, compiuta insieme dai poeti e dai lettori attivi, siano così spesso presenti fenomeni che è giocoforza chiamare di “rimozione”. Viene subito in mente un caso ormai divenuto famoso: l'occultamento del primo manoscritto di poesie di Dino Campana, che Soffici e Papini, “dimenticarono” in un baule e dichiararono perduto. Apprendistati è una riuscita, sotto tutti gli aspetti, e le 53 poesie che lo compongono hanno trovato un ritmo battente e articolato al punto che Di Ruscio riesce a adeguarlo alla velocità delle sue associazioni e combinazioni di immagini con tenaci concetti di rivolta. Di Ruscio è una talpa che continua a scavare e la sua macchina macina-parole funziona a pieno regime grazie a un sistema di verbi che ribadiscono, verso dopo verso, la necessità della presenza centrale di un io capace di interagire con il “farsi e disfarsi” della storia del nostro tempo. Al posto della disperazione vi è il senso del comico, invece delle sintesi e dei dogmi c'è l'incalzare delle domande. “Non abbiamo più speranza, di una palla di neve all'inferno” scrive Di Ruscio, citando Joyce, e anche: “la parola fa pensare allo sfrigolio del grasso nel fuoco”, sempre da Joyce. E si capisce che vuole significarci una volontà di resistenza a tutti i costi. Finché c'è fuoco e grasso, e sfrigolii, dunque il processo della storia non si è arrestato, c'è speranza, ci siamo ancora: con la poesia, con i verbi del nostro agire. La palla di neve seguita a riformarsi.”
(9-6-2010, Nazione Indiana)
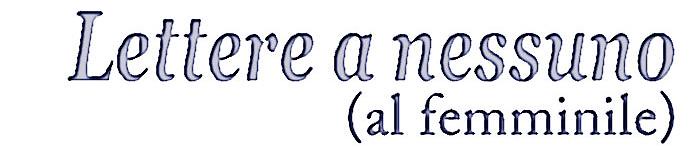
Nessun commento:
Posta un commento