Di Mariano Bargellini
Una mattina (era domenica) Isidoro si fermò a guardare i piccioni malati raccoltisi malinconicamente, di loro spontanea volontà, abuliche e rassegnate creature, come d'abitudine, nel loro lazzaretto di largo Cordusio. Tornava a piedi dall'ospedale ortopedico Gaetano Pini; la meta della sua passeggiata era il capolinea del tram di Musocco: in piazza Castello, di faccia alla torre del Filarete. La visita a sua madre chissà perché stamattina aveva avuto il potere di commuoverlo e angosciarlo, tanto che le sue filiali istrionerie, per consolarla e per farsi notare dalle infermiere, in specie da quella giovanissima romena, a un tratto gli erano divenute insostenibili e s'era congedato di furia, senza né ai né bai, con una gran pressa ingiustificata. In piazza del Duomo Isidoro, ricordandosi dell'avventura disgustosa capitatagli quella tale notte, circa una settimana fa, attraversò il sagrato, da portici a portici, imprecando e parandosi la faccia dietro il giornale, tra voli a stormo d'ali pestifere incuranti di sbattere contro l'ostacolo d'una testa, gli sembrava, e corserelle da aia affollata, tra i piedi, al richiamo di un fotografo e verso un gruppo di turisti prontamente individuati dai loro occhietti furbi e vitrei di ghiaccio marrone. Raggiunto l'ingresso della Galleria, invece di percorrerla fino all'arco opposto, cioè l'ingresso da piazza della Scala, e abbandonarsi a pubbliche sghignazzate davanti a certi libri e a certe facce esposte nelle vetrine delle librerie, cambiato programma, volubilmente era entrato nel bar Zucca. Aveva motteggiato con uno dei baristi, ordinandogli un aperitivo sotto il facile enigma d'uno slogan pubblicitario diventato famoso: - Mi dia "Milano città da bere", capo -. Ma poi aveva raffreddato la loro complicità e incrinato un rapporto confidenziale degno di un bar di periferia, basato su ammiccamenti e allusioni, disgustandolo coi suoi ticchi scimmieschi e una rapacità pure scimmiesca nel lavorar di stecchino, ovverossia nell'infilzare, frettoloso e vorace, un'esagerazione di antipasti, vuotandone i due vassoietti e sguarnendone un settore del banco.
In largo Cordusio, come detto, la folla dei piccioni malati l'obbligò a fare una sosta. La statua del Parini e la sottostante esedra, a Isidoro, più che una voliera altissima e monumentale priva di rete metallica e scoperchiata (non già una gabbia, un ospizio per i tetri volatili), a Isidoro, una simile indecorosità, che rivisitava per la prima volta dopo l'auspicio malauguroso, sembrò piuttosto il quadro vivente di un bestiario: una visione emblematica e fatale. Gli dette un'inquietudine strana il quadro, e gli suggerì un presentimento pazzesco: almeno secondo la logica diurna e il calcolo delle probabilità. Temette di riconoscere, in quel consesso di lebbrosi, il suo piccione viaggiatore venuto dall'aldilà o dal Nulla, e da lui rispedito al mittente, scacciato con orrore, la notte che la Lippa era stata uccisa.
Il Parini, risoluto elegante e giovane, abbastanza da guardare lontano e correre la sua strada ancora, alzava un tacco e si avvolgeva nel suo mantello da viaggio. Dall'alto del suo piedestallo però gli toccava di soprastare a una massa di piccioni, per di più appestati: fungeva da custode, in pratica, al loro lazzaretto e sorvegliava le loro latrine. Contemplando con interesse inusitato e una dimora affascinata, protrattasi come non mai, un tal quadro di vita animale urbana, e passandoli in rassegna a uno a uno i mesti figuranti della visio, Isidoro si accorse che per la verità soltanto una minoranza di loro, assiepatisi in una zona limitata dell'esedra e del monumento, faceva onore alla fama propria e del luogo o diciamo all'idea sommaria concepita da lui e forse in genere dai milanesi: che fosse, codesto recinto celebrativo, il lazzaretto dei piccioni. Quelli posati sulla statua, tanto per cominciare, senza alcuna eccezione, erano individui sani. Lo attestava il loro aspetto e lo confermava una solerzia attivistica e competitiva nell'animoso minuetto delle loro occupazioni di routine, dalle quali, financo dalle minime ed elementari, come verbigrazia spollinarsi e muoversi un po', gl'impestati e lebbrosi, caduti in depressione e stupefatti dalla catatonia, s'astengono immediatamente. Questi qui, la scomodità dei loro appoggiatoi, curvi accidentati precipiti esigui, di freddo bronzo, al posto di consigliargli la calma, li aizzava ai corteggiamenti acrobatici: si spollinavano il groppone sessualmente eccitati, maschi e femmine, e damerini da minuetto, i maschi si pavoneggiavano e tutti si scacciavano a beccate.
Al Parini, di 'sti colombi competitivi e inquieti, adesso gli capitava di averne quattro sulla testa, due, uno di qua e uno di là, sulle spalle, un paio lì tra le gambe divaricate nel passo, e un altro in una piega del suo mantello. Dalla statua poi scendendo con gli occhi a recensire la popolazione del piedestallo Isidoro constatò che in cima al dado di marmo bianco miracolosamente conservatesi netto da colate di guano, ossia sulla cimasa, anche lassù si erano posati, si divagavano piccioni sani. Il vero e proprio lazzaretto dei piccioni, la cui aura morbosa aleggiava e si diffondeva ovunque, imponendo quella fama al luogo, in realtà andava circoscritto alla base o zoccolo del piedestallo e alla panchina ad emiciclo, ovvero all'esedra in senso stretto ed etimologico. Specialmente su un listello e sul sottostante aggetto dello zoccolo si concentrava la turba dei malati "terminali": schiacciati, di profilo, lungo questa mensola in stentato rilievo, e radunanza impietrita, sulla cornice inferiore dello zoccolo di granito. A ispezionare fa folla plumbea del recinto, che sostava come i paesani in piazza sotto l'obelisco del piedestallo, ci si accorgeva che i malati e gli ammalazzati si mescolavano ai sani e ben pasciuti: ma neppure qui erano maggioranza. La corsia dei casi disperati, la più interna del lazzaretto per dir così, illogicamente secondo un criterio nostro umano, dato l'incomodo e la difficoltà del tenervisi in equilibrio, massime degl'invalidi, era l'avarissima cornice o mensola appena sbalzata lungo la base del piedestallo. La sala d'aspetto della morte era il listello dello zoccolo. Appiattiti là sopra, stilizzati come ideogrammi, oramai diventati morfemi di Thànatos, i lugubri piccioni morituri aspettavano il traballamento finale e un capitombolo conclusivo, giù di colpo stirati, scivolando rapidi tra le allumacature di guano, verdi e bianche, delle loro latrine. La livrea degli appestati, la nerezza e l'untume, sbigottì Isidoro. Al punto che rivide, quasi la sequenza di un video proiettato nel suo cervello, ma sovrappostosi alla realtà, il suo piccione viaggiatore venuto a recapitargli, quella notte di sangue, un dispaccio di orrore ferale. Svolazzava in tondo sopra il lazzaretto, seguito dalla sua ombra, vacillante, anziché sulle pareti e con picchi da elettroencefalogramma sul soffitto della stanza, nell'aria e nel sole della mattina milanese, rannuvolato e pallido sole, abbacinante nondimeno, a segno che lui sbattè gli occhi, li serrò con una smorfia dolorosa, e riapertili, fortunatamente, l'allucinazione provocata e consapevole si era dissolta. Un tetro untume incupiva la livrea degli appestati, che si allineavano, geroglifici neri a sbalzo, sul listello dello zoccolo. Aderendo col petto al granito, rivolti pateticamente alla parete, o di profilo, rattratta la cervice tra le spalle, con una loro istintiva teatralità s'erano estraniati dal soggetto, dal succo, dal senso della vita colombacea. Gli umori della peste colmavano il vaso del loro corpo al pari di un inchiostro nero e putrido, e filtrando su per il calamo di ciascuna penna la coloravano e la ungevano d'un crassume e nerume necrotico orribile a vedersi. Oltre a ciò, ricordandogli il messo infernale, questo loro piumaggio cupo ed unto, avendo perso la compattezza e il liscio della piuma, si sollevava a scaglie: una pigna vuota d'annerito e opacissimo piombo. Avevano il colore e la gravezza del piombo, ma in¬sieme una inerte levità, dovuta alla consunzione del loro corpo e alla sua prefigurata disgregazione. Era stata veramente, dunque, un'energia aliena, un'energia paranormale, quella che aveva animato un relitto del genere, anzi più misero e orrendo, e gli aveva dato la forza d'aggrapparsi coll'unico piede, sbattendo forsennatamente le ali, al cordone di stucco, lassù in alto, reagire, colpito dal proiettile dello straccio appallottolato che l'aveva sbalzato giù dal soffitto, riprendersi a mezz'aria, svolazzare a guisa di pipistrello attorno alla camera e perdersi nella notte, d'un subito, come un fantasma.
Isidoro per poco non urlò, ebbe un gesto di fobica difesa, si parò la faccia, al subbuglio scoppiato nel lazzaretto. In un attimo, tra schiocchi e gemiti, cigolii ventosi, come di vele, tutte le ali sane, o malate al primo stadio, si erano levate e sbattevano concentratesi in un punto, densità caotica inimmaginabile: tutta la massa aerea e surpiace dei piccioni si librava sopra la ringhiera da aiola dell'esedra, all'altezza del suo viso. Imprecando a fior di labbra, e fattosi da parte, spostatosi di qualche passo, Isidoro si acquietò. L'indiavolamento delle bestiacce infette era causato da una distribuzione di cibo. Due figuri, un trentenne con la barba, giubbotto di pelle e jeans sbiaditi ad arte, faccia da sicario assassino dell'intelligenza al soldo del sistema dell' "immagine", il regista, oltreché il distributore del becchime, e il suo socio l'operatore, con in spalla una videocamera professionale, stavano girando questa scena per una tivù privata. Eccezionalmente avevano ottenuto il permesso dai vigili, al pari dei fotografi di piazza del Duomo, d'impinguare i piccioni; il che, come si sa, è vietato. Un polverone preoccupante si era sollevato dal lazzaretto al battito delle ali, mentre il regista muoveva a sua volontà gli attori, la comparseria alata, attingendo l'esca da un grosso cartoccio di cellophane, una confezione di mangime per colombi ad uso degli avicoltori. Tanto era il trambusto, il far vento delle ali poggianti per aria, che volteggiavano delle piume, una bianca, stupì Isidoro, e difatti, in mezzo al nereggiare plumbeo, ecco la colomba di Picasso e di Stalin. I piccioni impestati e neri adesso si potevano contare. Insensibili al richiamo del cibo, e posatasi la calca famelica, spiccavano isolati sullo sfondo. S'allineavano sopra le loro mensole, cioè i due appoggiatoi dello zoccolo, il listello e l'aggetto, assenti, straniti, alla base del piedestallo lordata dalle colature di guano bianco gessose e verde bile. Altri stazionavan qua e là sulla panchina, afflitti e imperturbabili. Isidoro trasecolò: uno di quei foschi geroglifici come sbalzati nel granito, là sul listello (strano che se n'accorgesse solo ora), assomigliava al piccione di quella notte. Anzi, era lui! La sua zampetta monca e paonazza era visibile da qui: lasciata spenzolare, esibitagli come segno di riconoscimento. Meravigliò Isidoro, che nemmeno per un istante congetturò un'allucinazione, la piana sobrietà del fatto portentoso, la sua normalità, benché sia un gioco di parole, e una freddura, pensarlo e dirlo, trattandosi di un evento paranormale. Per contro non si meravigliò che il piccione, a sua volta, lo avesse riconosciuto e lo fissasse con cieca insistenza. Nella sua postura patetica e scomoda, premuto il petto alla parete di pietra e voltosi di profilo faticosamente, il piccione guardava all’indietro. Lo scrutava col suo occhio scialbo e acuto: l'acuità vuota di uno sguardo proveniente da un altrove impensabile: dardeggiato dal Nulla.
Brano tratto dal racconto “Falconeria da camera”, contenuto in Mus utopicus, Ignazio Maria Gallino editore, Milano 1999
Una mattina (era domenica) Isidoro si fermò a guardare i piccioni malati raccoltisi malinconicamente, di loro spontanea volontà, abuliche e rassegnate creature, come d'abitudine, nel loro lazzaretto di largo Cordusio. Tornava a piedi dall'ospedale ortopedico Gaetano Pini; la meta della sua passeggiata era il capolinea del tram di Musocco: in piazza Castello, di faccia alla torre del Filarete. La visita a sua madre chissà perché stamattina aveva avuto il potere di commuoverlo e angosciarlo, tanto che le sue filiali istrionerie, per consolarla e per farsi notare dalle infermiere, in specie da quella giovanissima romena, a un tratto gli erano divenute insostenibili e s'era congedato di furia, senza né ai né bai, con una gran pressa ingiustificata. In piazza del Duomo Isidoro, ricordandosi dell'avventura disgustosa capitatagli quella tale notte, circa una settimana fa, attraversò il sagrato, da portici a portici, imprecando e parandosi la faccia dietro il giornale, tra voli a stormo d'ali pestifere incuranti di sbattere contro l'ostacolo d'una testa, gli sembrava, e corserelle da aia affollata, tra i piedi, al richiamo di un fotografo e verso un gruppo di turisti prontamente individuati dai loro occhietti furbi e vitrei di ghiaccio marrone. Raggiunto l'ingresso della Galleria, invece di percorrerla fino all'arco opposto, cioè l'ingresso da piazza della Scala, e abbandonarsi a pubbliche sghignazzate davanti a certi libri e a certe facce esposte nelle vetrine delle librerie, cambiato programma, volubilmente era entrato nel bar Zucca. Aveva motteggiato con uno dei baristi, ordinandogli un aperitivo sotto il facile enigma d'uno slogan pubblicitario diventato famoso: - Mi dia "Milano città da bere", capo -. Ma poi aveva raffreddato la loro complicità e incrinato un rapporto confidenziale degno di un bar di periferia, basato su ammiccamenti e allusioni, disgustandolo coi suoi ticchi scimmieschi e una rapacità pure scimmiesca nel lavorar di stecchino, ovverossia nell'infilzare, frettoloso e vorace, un'esagerazione di antipasti, vuotandone i due vassoietti e sguarnendone un settore del banco.
In largo Cordusio, come detto, la folla dei piccioni malati l'obbligò a fare una sosta. La statua del Parini e la sottostante esedra, a Isidoro, più che una voliera altissima e monumentale priva di rete metallica e scoperchiata (non già una gabbia, un ospizio per i tetri volatili), a Isidoro, una simile indecorosità, che rivisitava per la prima volta dopo l'auspicio malauguroso, sembrò piuttosto il quadro vivente di un bestiario: una visione emblematica e fatale. Gli dette un'inquietudine strana il quadro, e gli suggerì un presentimento pazzesco: almeno secondo la logica diurna e il calcolo delle probabilità. Temette di riconoscere, in quel consesso di lebbrosi, il suo piccione viaggiatore venuto dall'aldilà o dal Nulla, e da lui rispedito al mittente, scacciato con orrore, la notte che la Lippa era stata uccisa.
Il Parini, risoluto elegante e giovane, abbastanza da guardare lontano e correre la sua strada ancora, alzava un tacco e si avvolgeva nel suo mantello da viaggio. Dall'alto del suo piedestallo però gli toccava di soprastare a una massa di piccioni, per di più appestati: fungeva da custode, in pratica, al loro lazzaretto e sorvegliava le loro latrine. Contemplando con interesse inusitato e una dimora affascinata, protrattasi come non mai, un tal quadro di vita animale urbana, e passandoli in rassegna a uno a uno i mesti figuranti della visio, Isidoro si accorse che per la verità soltanto una minoranza di loro, assiepatisi in una zona limitata dell'esedra e del monumento, faceva onore alla fama propria e del luogo o diciamo all'idea sommaria concepita da lui e forse in genere dai milanesi: che fosse, codesto recinto celebrativo, il lazzaretto dei piccioni. Quelli posati sulla statua, tanto per cominciare, senza alcuna eccezione, erano individui sani. Lo attestava il loro aspetto e lo confermava una solerzia attivistica e competitiva nell'animoso minuetto delle loro occupazioni di routine, dalle quali, financo dalle minime ed elementari, come verbigrazia spollinarsi e muoversi un po', gl'impestati e lebbrosi, caduti in depressione e stupefatti dalla catatonia, s'astengono immediatamente. Questi qui, la scomodità dei loro appoggiatoi, curvi accidentati precipiti esigui, di freddo bronzo, al posto di consigliargli la calma, li aizzava ai corteggiamenti acrobatici: si spollinavano il groppone sessualmente eccitati, maschi e femmine, e damerini da minuetto, i maschi si pavoneggiavano e tutti si scacciavano a beccate.
Al Parini, di 'sti colombi competitivi e inquieti, adesso gli capitava di averne quattro sulla testa, due, uno di qua e uno di là, sulle spalle, un paio lì tra le gambe divaricate nel passo, e un altro in una piega del suo mantello. Dalla statua poi scendendo con gli occhi a recensire la popolazione del piedestallo Isidoro constatò che in cima al dado di marmo bianco miracolosamente conservatesi netto da colate di guano, ossia sulla cimasa, anche lassù si erano posati, si divagavano piccioni sani. Il vero e proprio lazzaretto dei piccioni, la cui aura morbosa aleggiava e si diffondeva ovunque, imponendo quella fama al luogo, in realtà andava circoscritto alla base o zoccolo del piedestallo e alla panchina ad emiciclo, ovvero all'esedra in senso stretto ed etimologico. Specialmente su un listello e sul sottostante aggetto dello zoccolo si concentrava la turba dei malati "terminali": schiacciati, di profilo, lungo questa mensola in stentato rilievo, e radunanza impietrita, sulla cornice inferiore dello zoccolo di granito. A ispezionare fa folla plumbea del recinto, che sostava come i paesani in piazza sotto l'obelisco del piedestallo, ci si accorgeva che i malati e gli ammalazzati si mescolavano ai sani e ben pasciuti: ma neppure qui erano maggioranza. La corsia dei casi disperati, la più interna del lazzaretto per dir così, illogicamente secondo un criterio nostro umano, dato l'incomodo e la difficoltà del tenervisi in equilibrio, massime degl'invalidi, era l'avarissima cornice o mensola appena sbalzata lungo la base del piedestallo. La sala d'aspetto della morte era il listello dello zoccolo. Appiattiti là sopra, stilizzati come ideogrammi, oramai diventati morfemi di Thànatos, i lugubri piccioni morituri aspettavano il traballamento finale e un capitombolo conclusivo, giù di colpo stirati, scivolando rapidi tra le allumacature di guano, verdi e bianche, delle loro latrine. La livrea degli appestati, la nerezza e l'untume, sbigottì Isidoro. Al punto che rivide, quasi la sequenza di un video proiettato nel suo cervello, ma sovrappostosi alla realtà, il suo piccione viaggiatore venuto a recapitargli, quella notte di sangue, un dispaccio di orrore ferale. Svolazzava in tondo sopra il lazzaretto, seguito dalla sua ombra, vacillante, anziché sulle pareti e con picchi da elettroencefalogramma sul soffitto della stanza, nell'aria e nel sole della mattina milanese, rannuvolato e pallido sole, abbacinante nondimeno, a segno che lui sbattè gli occhi, li serrò con una smorfia dolorosa, e riapertili, fortunatamente, l'allucinazione provocata e consapevole si era dissolta. Un tetro untume incupiva la livrea degli appestati, che si allineavano, geroglifici neri a sbalzo, sul listello dello zoccolo. Aderendo col petto al granito, rivolti pateticamente alla parete, o di profilo, rattratta la cervice tra le spalle, con una loro istintiva teatralità s'erano estraniati dal soggetto, dal succo, dal senso della vita colombacea. Gli umori della peste colmavano il vaso del loro corpo al pari di un inchiostro nero e putrido, e filtrando su per il calamo di ciascuna penna la coloravano e la ungevano d'un crassume e nerume necrotico orribile a vedersi. Oltre a ciò, ricordandogli il messo infernale, questo loro piumaggio cupo ed unto, avendo perso la compattezza e il liscio della piuma, si sollevava a scaglie: una pigna vuota d'annerito e opacissimo piombo. Avevano il colore e la gravezza del piombo, ma in¬sieme una inerte levità, dovuta alla consunzione del loro corpo e alla sua prefigurata disgregazione. Era stata veramente, dunque, un'energia aliena, un'energia paranormale, quella che aveva animato un relitto del genere, anzi più misero e orrendo, e gli aveva dato la forza d'aggrapparsi coll'unico piede, sbattendo forsennatamente le ali, al cordone di stucco, lassù in alto, reagire, colpito dal proiettile dello straccio appallottolato che l'aveva sbalzato giù dal soffitto, riprendersi a mezz'aria, svolazzare a guisa di pipistrello attorno alla camera e perdersi nella notte, d'un subito, come un fantasma.
Isidoro per poco non urlò, ebbe un gesto di fobica difesa, si parò la faccia, al subbuglio scoppiato nel lazzaretto. In un attimo, tra schiocchi e gemiti, cigolii ventosi, come di vele, tutte le ali sane, o malate al primo stadio, si erano levate e sbattevano concentratesi in un punto, densità caotica inimmaginabile: tutta la massa aerea e surpiace dei piccioni si librava sopra la ringhiera da aiola dell'esedra, all'altezza del suo viso. Imprecando a fior di labbra, e fattosi da parte, spostatosi di qualche passo, Isidoro si acquietò. L'indiavolamento delle bestiacce infette era causato da una distribuzione di cibo. Due figuri, un trentenne con la barba, giubbotto di pelle e jeans sbiaditi ad arte, faccia da sicario assassino dell'intelligenza al soldo del sistema dell' "immagine", il regista, oltreché il distributore del becchime, e il suo socio l'operatore, con in spalla una videocamera professionale, stavano girando questa scena per una tivù privata. Eccezionalmente avevano ottenuto il permesso dai vigili, al pari dei fotografi di piazza del Duomo, d'impinguare i piccioni; il che, come si sa, è vietato. Un polverone preoccupante si era sollevato dal lazzaretto al battito delle ali, mentre il regista muoveva a sua volontà gli attori, la comparseria alata, attingendo l'esca da un grosso cartoccio di cellophane, una confezione di mangime per colombi ad uso degli avicoltori. Tanto era il trambusto, il far vento delle ali poggianti per aria, che volteggiavano delle piume, una bianca, stupì Isidoro, e difatti, in mezzo al nereggiare plumbeo, ecco la colomba di Picasso e di Stalin. I piccioni impestati e neri adesso si potevano contare. Insensibili al richiamo del cibo, e posatasi la calca famelica, spiccavano isolati sullo sfondo. S'allineavano sopra le loro mensole, cioè i due appoggiatoi dello zoccolo, il listello e l'aggetto, assenti, straniti, alla base del piedestallo lordata dalle colature di guano bianco gessose e verde bile. Altri stazionavan qua e là sulla panchina, afflitti e imperturbabili. Isidoro trasecolò: uno di quei foschi geroglifici come sbalzati nel granito, là sul listello (strano che se n'accorgesse solo ora), assomigliava al piccione di quella notte. Anzi, era lui! La sua zampetta monca e paonazza era visibile da qui: lasciata spenzolare, esibitagli come segno di riconoscimento. Meravigliò Isidoro, che nemmeno per un istante congetturò un'allucinazione, la piana sobrietà del fatto portentoso, la sua normalità, benché sia un gioco di parole, e una freddura, pensarlo e dirlo, trattandosi di un evento paranormale. Per contro non si meravigliò che il piccione, a sua volta, lo avesse riconosciuto e lo fissasse con cieca insistenza. Nella sua postura patetica e scomoda, premuto il petto alla parete di pietra e voltosi di profilo faticosamente, il piccione guardava all’indietro. Lo scrutava col suo occhio scialbo e acuto: l'acuità vuota di uno sguardo proveniente da un altrove impensabile: dardeggiato dal Nulla.
Brano tratto dal racconto “Falconeria da camera”, contenuto in Mus utopicus, Ignazio Maria Gallino editore, Milano 1999
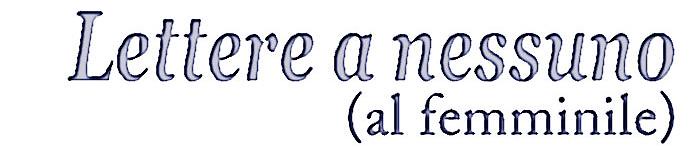
Nessun commento:
Posta un commento