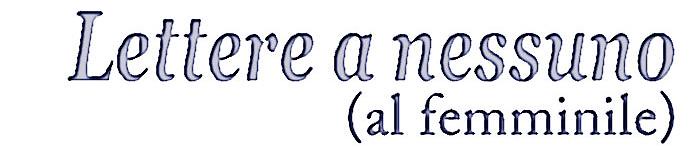Tecniche di basso livello (Gherardo Bortolotti, Lavieri, Caserta 2009): un titolo che, fra le altre cose, potrebbe alludere al "mestiere" di scrivere. Quali sono queste tecniche? Narrative forse?
Si procede per frammenti dall'ordine scomposto, i
cui numeri di riferimento non si presentano consequenziali: primo atto
d'insubordinazione verso la trama. Si nota subito anche l'anomalia dei
personaggi. I nomi propri iniziano con la lettera minuscola, sono nomi che
potrebbero appartenere a robot e risentono di un'impronta seriale, omologata. L'uomo di Marcuse, schiacciato su un'unica
dimensione e condannato a una passività appena pensierosa, abita queste pagine. L'orizzonte culturale appare circoscritto da
proposte dell'industria musicale e cinematografica o, per meglio dire, legate
alla produzione televisiva, alla pubblicità e alle serie, che pervadono ogni
angolo della coscienza e finiscono per dissolvere ogni tentativo di pensiero
autonomo e critico: "Impegnati in trame minori…", "abituati
al ruolo di comparsa…" si trova scritto, "ci eravamo allontanati dai
telegiornali, dalla lettura dei quotidiani, perché la realtà era un genere
sclerotizzato, una nicchia di mercato sempre più ristretta e lasciata agli
addetti ai lavori." (pag 17); "Lontani dagli abusi sui clandestini,
seguivamo le vicende della nostra serie preferita e ci preparavamo a esprimere
opinioni in merito al giorno d'oggi..." (pag 63); "La distanza tra lo
stato delle cose e la curva dei nostri progetti aumentavano il senso di una
conclusione incongrua (…) Senza morali da trarre, guardavamo il telegiornale,
affascinati dalle immagini in movimento." (pag 69).
Ritmi televisivi e abitudini sonnolente a parte,
la dimensione attiva della vita è impegnata nel lavoro, non gratificante ma, a
inizio anni 2000, ancora in grado di infondere una sensazione di stabilità e
sicurezza. Il Giano bifronte della condizione di lavoratori che riescono
persino a elevarsi a un discreto benessere è ben espresso da frasi contrapposte
come: "Le villette a schiera, i quartieri periferici ci parlavano di un
benessere continuo, di una forma socialdemocratica di eternità." (pag 11);
"A vantaggio di un futuro altrui, accettava l'orrore della sveglia e
l'allucinazione del salario, e rimandava alle ore della sera l'occasione di
pensare e di sentirsi vivo." (pag 54). Queste ultime tre righe riescono a
rendere in una sintesi efficace quanta parte della vita ci venga sottratta dal
lavoro, quanto di noi sia sottoposto alle dure leggi del capitale.
Tuttavia il lavoratore dei giorni nostri è anche e
soprattutto un consumatore:; "L'accessibilità della merce appariva come la
controparte di un accordo rispettabile. Le campagne promozionali in corso ci
procuravano una serenità più generale, quasi oggettiva." (pag 13)
"Dall'attesa della morte, ci distraevano le pubblicità delle agenzie di
viaggio. Come robot buoni, ci incamminavamo dentro lunghi vicoli ciechi…"
(pag 53). Si subisce il fascino di "modelli di vita diffusi dal marketing
di un prodotto di consumo (un dopobarba, un'automobile…)" (pag 61). E nel
riferimento al dopobarba non possiamo non cogliere un richiamo all'Aldo Nove di
Woobinda e del bagnoschiuma Vidal (Castelvecchi, Roma 1996). A inizio
2000 si viveva ancora nell'atmosfera degli anni Novanta in cui perduravano,
indisturbate, le esigenze pervasive e ottundenti della società dei consumi.
Benché
la potenza di Eros, cieca, arcaica, sia l’argomento principale di
Romanzetto estivo (Tic edizioni, Roma 2021), ben lontano quindi dai
desideri indotti artificialmente dalle esigenze di mercato e governabilità
presenti nelle Tecniche, persino in questa raccolta di poesie, o prose
poetiche, talvolta affiora l’immancabile effetto di straniamento del
personaggio che, in un modo o nell’altro, sente di non avere in mano il suo
destino: “… quello che mi /accade davvero accade sempre altrove… “ (pag 52).
In Tutte le camere d'albergo del mondo (Hopefulmonster, Torino
2022) si configura un orizzonte meno deterministico. Cosa rimane della
costruzione di Tecniche di basso livello? Accanto a ciascun titolo di
capitolo troviamo dei numeri, numeri un po' ambigui che non è chiaro che cosa
indichino: il primo numero di capitolo per esempio, anziché 1, è 1002. Ve ne
sono alcuni consecutivi ma a un certo punto si passa dal 1035 al 1040 oppure
dal 1057 al 1065. L'osservazione più banale è che i numeri dei capitoli
corrispondano a numeri di camera e che dimostrino semplicemente che alcune
camere sono occupate, altre no. Ma l'arbitrio numerico potrebbe anche
significare che certi capitoli sono rimasti mentre altri sono stati espunti dal
capriccio dell'autore. Qualcosa manca, insomma, qualcosa di vistoso che rimanda
a una forte volontà di elisione, di cancellazione. E in effetti anche le trame
imbastite per ogni stanza sono stralci di vita di persone che appena
s'intravedono, di cui non si conosce il passato e che non si sa cosa andranno a
fare.