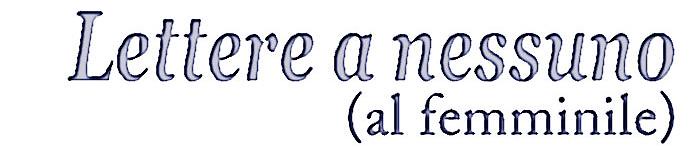Se l'io è una proliferazione immaginaria, come sostiene per
esempio Lacan, non si capisce fino a che punto siano giustificati tutti quei
romanzi così solidamente strutturati, dalle trame così compatte, che si
presentano come granitici monoliti. «Con questo libro,» vorrebbe dire un
editore o un libraio all’acquirente, porgendo il maneggevole blocco di cemento
armato, «puoi star sicuro che ti vendo un buon prodotto, tenuto insieme dal
rigore sintattico e da una logica ferrea. Sei sicuro che non ti si sfascerà fra
le mani privo di senso.» Il modello del cemento armato è probabilmente il
modello con cui sono costruiti questi parallelepipedi romanzeschi che
promettono la tenuta realistica di matrice ottocentesca, senza infiltrazioni o
bolle d'aria, cioè senza nulla che minacci la coesione interna, neanche un
piccolo dubbio. Blocchi pieni di parole tenute insieme con griglie d’acciaio,
forse per far fronte all'elevata competizione: si sa, un vaso di coccio non
viaggia bene in mezzo a vasi di ferro. Ecco, queste narrazioni in cui ogni
personaggio ha un suo carattere definito, un suo destino inscritto nel
carattere, o in cui entrano in relazione soltanto delle maschere sociali più o
meno stereotipate, ci dicono qualcosa di appena un po’ diverso da un saggio
sociologico. Un saggio di sociologia o di economia ha il vantaggio che può
entrare maggiormente nei dettagli, può fornire risposte più precise e
argomentate sul contesto sociale in cui viviamo. Ma perché anche nella prosa
d'immaginazione vengono proposti schemi rigidi, assertivi, convenzionali simili
a fortini inattaccabili? Come a dire: «Non ti vendo un libro, ti vendo un
piccolo fortino in cui trincerarti contro tutte le tue paure».
Visualizzazione post con etichetta jacques lacan. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta jacques lacan. Mostra tutti i post
lunedì 25 maggio 2020
lunedì 19 dicembre 2011
Re mago o re maschera?
Il capo è colui che elargisce favori, esaudisce desideri. Al super-capo, poi, si chiede pure l'impossibile, proprio lì sta il bello. Le sue prerogative hanno qualcosa d'inverosimile e in parte inspiegabile. Com'è possibile, per esempio, che sia così ricco? Eppure lo è. Da dove viene tutta quella ricchezza? Non si sa, la risposta fa parte della sua aura di mistero. Se gli manca l'immortalità, può contare tuttavia su una giovinezza intramontabile. Gli agi, il lusso, la mondanità, le occasioni, le cene ravvivano e allietano le sue giornate densissime d'impegni e d'imprese. Il super-capo non è mai stanco. Tiene a bada gli oppositori, espande la sua area d'influenza, accresce i tesori per sé e per i sudditi, soddisfa aspettative. Ed ecco che le donne si assiepano al suo passaggio… a decine, a centinaia lo circondano e corteggiano. Hanno una quantità di favori da chiedere per sé o per gli uomini che si celano dietro di loro in lunghe catene di aspettative. Se il capo riesce a soddisfare tutte quelle donne (simbolicamente tutte le donne), vuol dire che è certamente in grado di rendere felici tutti, no? Nei rapporti con il capo il desiderio circola in continuazione. Il capo mette in moto i desideri. A chi se non a lui si può chiedere di dirimere un'intricatissima storia di eredità e terreni contesi da generazioni, il permesso di edificare su spazi non edificabili oppure di sospendere un provvedimento già reso attuativo da varie sentenze? E' una fortuna che possieda in quantità smisurata tutto quello che tanti vorrebbero avere! Qualcuno con un bel po' di chance e con le entrature giuste seguirà le sue orme… il grande capo stimola fantasie di emulazione.
domenica 18 dicembre 2011
Zizek blues
Odia il prossimo tuo è certamente un titolo che attira l'attenzione: si tratta dell'ultimo libro apparso in Italia firmato da Slavoj Zizek (Transeuropa, Massa settembre 2009), che con Eric L. Santner s'interroga e interroga grandi pensatori del passato sul tema dell'altro. Il pensiero di Zizek è una festa dell'intelligenza e per l'intelligenza: le sue molte associazioni mentali e le citazioni di filosofi, psicanalisti, registi, scrittori, fenomeni vari di cultura di massa, rendono il ragionamento molto coinvolgente.
Chi è il nostro prossimo? Il prossimo, già nella tradizione giudaico-cristiana, non è il simile, il vicino, ma l'altro, il portatore di un nucleo traumatico estraneo, il sempre-diverso-anche-se-ci-sta-vicino. E' un soggetto diviso esattamente come noi, secondo la psicanalisi, quindi sostanzialmente estraneo anche a se stesso, segnato dall'impossibilità di capirsi totalmente. La conseguenza migliore di questo stato di cose potrebbe essere la solidarietà nell'umiltà: "questa presa di coscienza implica la dimensione di base del perdono e del tollerante vivi e lascia vivere: mai sarò in grado di spiegare me stesso all'Altro, perché io per primo non sono trasparente a me stesso e non otterrò mai dall'Altro una risposta completa alla domanda 'Chi sei tu?', perché anche l'Altro è per se stesso un mistero (…) Il riconoscimento reciproco di questo limite allora apre lo spazio alla socialità che è solidarietà nella vulnerabilità" (p. 94). Questo, nella migliore delle ipotesi.
sabato 17 dicembre 2011
Luigi Di Ruscio, "sprigionatore" di parole
Massimo Rizzante, nel saggio Non siamo gli ultimi (Effigie, Milano 2009), commenta un racconto di Asar Eppel' (della raccolta Via d'erba, Einaudi, Torino 2002), in cui dei ragazzi, durante l'avanzata tedesca verso Mosca, in uno dei momenti più drammatici della storia, si divertono a lanciare vasetti di senape contro una fontana. "E' la bellezza del presente ordinario," commenta Rizzante, "incastonato come un diamante nelle nefandezze del passato e della guerra."
In modo analogo nel romanzo Cristi polverizzati di Luigi Di Ruscio (Le Lettere, Firenze 2009), in un periodo di grande povertà e di massimo pericolo quale fu il 1943, dei ragazzini piceni, liberi di scorrazzare per i campi e largamente inconsapevoli di quello che sta accadendo intorno a loro, vanno in giro per giornate intere a nutrirsi di erbe e fiori, adottati da una natura feconda, trascurata dagli uomini. "Ai lati delle strade i cardi crescevano inesauribili, scoprivo sempre nuovi fiori mangerecci sfrondavo i rami più sottili e riempivo la bocca di fiori e foglie tenere, pascolavo su campi di sulla, solo le scorze degli alberi non facevano pasto… (…) Passava sui rami un'abbondanza esagerata: nelle case dei contadini c'erano solo donne e vecchi e quindi tutto era meno curato e sarà stato forse per queste mancanze di cure che tutto cresceva meglio… Godevo tutto…" (p. 38)
Passata la guerra, con la maturità, arriva la comprensione del proprio mondo, umile, emarginato e analfabeta, espropriato durante secoli duro lavoro, da una classe di ricchi proprietari fondiari e clericali.
Iscriviti a:
Post (Atom)