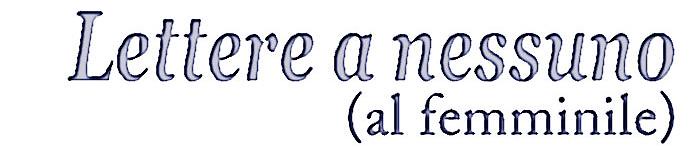Qui l'audio di parte del brano estratto da "Trilogia della scomparsa" e pubblicato nel post precedente, letto ad alta voce da Federico Nobili, attore e scrittore.
lunedì 23 novembre 2020
sabato 21 novembre 2020
Brano tratto dalla "Trilogia della scomparsa"
T'è mai capitato di mangiarti le mani? Io ho continuamente voglia di masticare qualcosa, qualunque cosa. Finito il pane e le sigarette, mi mangio le unghie, i capelli, le pellicine... Finiti i miei, vorrei passare ai tuoi. Ma dopotutto non credo affatto che staresti meglio senza tua madre. Nonostante tutto, ti sono necessaria. Qualcuno deve pur piangere sul latte versato! Tu saresti capace di sprecare persino l'olio senza fare una piega.
«Senti quello che dico?»
Mi fai blaterare e blaterare al vento. Dov'è quel disgraziato di tuo fratello? Non è colpa sua se non risponde. Sei tu che l'hai ridotto così.
È difficile per te immaginare una corsa per portare a qualcuno, da qualche parte, a qualcuno, un corpo freddo, bagnato, ferito, esanime, svenuto, trascinato correndo, prendendo in braccio un corpo morto, incespicando, sollevato ansimando, pesantissimo, caduto, cadendo a corpo morto, rialzandosi, facendosi aiutare da qualcuno sulla strada, forse dietro l'angolo, fuori dalla boscaglia, credendo che fosse un tuffo non un scivolata, mettendo male il piede, raddrizzandosi, il corpo di qualcuno respirante, gorgogliante però muto, assente, snodato, annegato, il corpo di un fiume, di un mare scivolato per sbaglio in una bocca, in una gola aperta, con i pesci che vogliono nuotare, saltare, respirare, il naso che vuole respirare, uscire tra le foglie, gli occhi chiusi che anelano alla luce oltre i rami, oltre la superficie delle foglie, ma la testa riversa, un braccio pesantissimo, il corpo molle, sciolto, libero di nuotare sbracciato, con la testa indietro, in giù, crollata, scrollando l'acqua, vomitando i pesci, la sabbia, le mie collane, nuotando, affogando, sbagliando strada, rifacendola a testa in giù, sott'acqua, ma respirando ancora, soffiando, senza dimenticare di saltare le onde, mangiare i pesci, passare sotto i rami, dandomi la spinta, ancora un colpo di reni, incrociando qualcuno, chiamando a gran voce, a grandi bracciate... È difficile immaginare le fatiche inutili, le corse controvento, il tempo perso per salvare qualcuno: per qualcuno che era già morto tanto tempo fa, a sedici anni: felice di esserlo, di sedici anni e morto per sempre.
lunedì 16 novembre 2020
Naufragare non è dolce
Mi ha messo sulle tracce di Naufraganti di Claudia Zaggia (Italic Pequod, Ancona 2015) una recensione trovata sulla rivista Leggendaria nel 2020: a significare quanto poco si sia parlato di questo libro interessante che per anni non ha avuto visibilità.
L'aspetto che sicuramente lo contraddistingue nettamente è il personaggio della narratrice intradiegetica che accosta capitoli del libro nel loro farsi ad aneddoti e riflessioni sulla sua vita, dando luogo a un diario che procede di pari passo con la stesura di un romanzo. Gli argomenti di entrambe le scritture sono simili: l'avvicinarsi della morte, l'inconsistenza della vita, la superficialità dei rapporti umani che in molti casi non riescono ad ancorarci più strettamente al vissuto e a dargli valore, l'inadeguatezza, l'incapacità di percepire appieno i segnali che la natura e gli altri esseri ci mandano.
Il romanzo si presenta quindi avvolto da un cappotto metanarrativo che lo rallenta, lo rende meno scattante, e appetibile come prodotto commerciale e per questo più significativo come documento dei tempi. La stesura del romanzo non si può considerare avulsa dal contesto di una società sfilacciata e degradata e quindi rimane impaludata nelle difficoltà esistenziali, comunicative e sociali dell'io narrante, che scrive in solitudine, non trova interlocutori o interlocutrici, rimane sconcertata o sconvolta le poche volte che ha un'occasione di scambio con critici e scrittori affermati. La decisione di lasciare lo scritto in una forma non del tutto finita, non limata, testimonia delle difficoltà di completare un lavoro difficile ancor più perché si prevede indesiderato, non letto: "A volte sto qui a ripensare una parola, la cambio, la sposto, la rimetto dov'era prima, poi mi sembra tutto una sciocchezza. Penso soprattutto che gli altri leggono frettolosamente e non si accorgono di nulla." pag 245; "Naufragi: mi affascina, io già naufragata, io sono quella che porta al naufragio. Ho spesso parlato di cose naufragate. Ho scritto, sto scrivendo, finisco e poi sempre riprendo a farlo. Dovrò lavorare molto a quest'opera, però sarà ancora una volta tutto insopportabilmente niente." pag 15. La scrittrice, suggestionata dai rifiuti accumulati, dubita spesso delle sue stesse capacità: "Mi sdraio, sono stanca, sto qui sdraiata e mi sembra possa essere per sempre, non ho alcun talento mi sento dire..." pag 242; "Dovrei andare a rivedere, rileggere queste note, ma non ho tempo, forse dopo, quando avrò finito di scrivere il romanzo, ma è poi un romanzo?" pag 48; "Adesso riprendo a scrivere prima che sia troppo tardi, devo andare avanti e finire, e dopo ci saranno i tempi lunghi della rilettura, della revisione, ho fastidio per quello che troverò." pag 187; "Non ho mai creduto di essere una scrittrice, non mi sono neppure mai presentata come una scrittrice, ho sempre scritto però. Scrivevo perché... adesso ho smesso, sto rileggendo qualcosa, ma faccio fatica. Mi chiedo quante menzogne anch'io mi sono raccontata per tirarmi un poco fuori dalla disperazione." pag 241.
lunedì 21 settembre 2020
Trilogia della scomparsa: una sintesi utile alla lettura
I romanzo della trilogia di Roberta Salardi
TITOLO Il
corpo della casa
Il corpo della casa è strutturato come
una piantina d’appartamento, presentando i capitoli come metafore delle varie
stanze: un corridoio stretto, una stanza da letto, un salotto e così via. In
ognuno di essi la protagonista Martina vive una situazione differente; per
esempio, in Letargo (la stanza da letto) è riportato il
dialogo con un artista suo ospite. Nell’ultimo capitolo, Sgabuzzino/Risposta
della casa, è la casa stessa che parla (ça parle, direbbe Lacan): emerge
l’inconscio nella voce delle pareti, dei tubi… che “rinfaccia” alla
narratrice-protagonista la sua storia, dopo averla triturata, frammentata,
stravolta nel delirio e reinterpretata in forme confuse e molteplici.
A dispetto dei
riferimenti spaziali della struttura, non manca un’evoluzione (o involuzione)
della storia, una trama con i suoi climax e i suoi colpi di scena, che tuttavia
ribadiscono una tendenza alla coazione a ripetere della protagonista. Tutto
comincia con un’esperienza di separazione e un grave lutto, seppure dai
contorni indefiniti e mutevoli; la trentacinquenne Martina deve trovare la
forza di tirare avanti. Pare farcela, tuttavia col puntello di divagazioni schizofreniche.
Improbabili impressioni e vaghe allucinazioni (nel suo caso “terapeutiche) in
qualche modo la sostengono finché un nuovo incontro/confronto con un uomo non
la mette alla prova in maniera dura come in passato. La breve convivenza con
l’artista malato Fulvio la inchioda a un senso d’impotenza e di aridità che la
spinge sempre più in un’area sensoriale-cognitiva diversa dal consueto. Ecco
che prende corpo la sua piccola mitologia domestica fatta di un figlio metà
animale metà vegetale, di voci materne che provengono dalle tubature ecc.
Finché nell’ultimo capitolo la narrazione esplode, così come la logica
razionale che finora in qualche modo ha tenuto insieme il filo del racconto, in
una serie di discorsi dei personaggi immaginari che abitano la sua mente. Nel
labirinto della Risposta della casa si riesce a individuare il filo d’Arianna
di una voce materna che continua a rimproverarla per tutte le scelte della sua
vita e il ricordo, rimosso, di traumi infantili.
giovedì 6 agosto 2020
Il percorso accidentato dell'infanzia nella sintassi di Leggenda privata di Michele Mari
martedì 30 giugno 2020
Greta Thunberg e il mondo che verrà
Un'asceta che in altri tempi sarebbe stata considerata una piccola santa? San Francesco in versione laica e moderna? Una novella Antigone che si appella a leggi non scritte le cui radici affondano in un sentimento di empatia e rispetto verso tutti gli esseri viventi?
Greta si discosta molto dal modello di attivista politico sessantottino, il
quale mirava allo sdoganamento di comportamenti repressi e di nuove libertà
individuali. "Vietato vietare" era uno dei motti liberatori
dell'epoca.
Il modo di porsi di Greta pare modellato su un altro tipo di morale. Si
percepisce motivato da un forte legame con la natura, che i popoli nordici
coltivano da sempre, come pure da una tradizione culturale e religiosa protestante,
che responsabilizza molto i singoli, che richiede fermamente coerenza e rigore.
Perché parlo di una tradizione religiosa? La sua attenzione è rivolta al
pianeta vivente, non unicamente alla società. Greta è anche vegana, per
esempio, probabilmente non solo per motivi strettamente ecologisti. Questi in
molti casi puntano a una semplice riduzione del consumo di carne e non
necessariamente a una rinuncia completa (vedi Greenpeace e altre associazioni).
Greta è una figura ascetica che potrebbe sembrare d'altri tempi. Ma
riproponendo l'antica questione del limite, dell’autocontrollo, particolarmente
avversata dalle società iperproduttive in cui viviamo, riporta sulla scena
abitudini improntate alla parsimonia che evidentemente non si possono dimenticare
o trascurare, in quanto favoriscono gli equilibri dell'ecosistema.
Per non compromettere il già difficile rapporto uomo-natura, il suo impegno
è esteso a tutto campo. Dice come è attenta nell’alimentazione, nei viaggi,
negli acquisti. La coerenza è una parte fondamentale della sua immagine e del
suo carisma: è grazie a questa coerenza inflessibile che riesce così
convincente.
lunedì 25 maggio 2020
Se l'io è una proliferazione immaginaria
martedì 17 marzo 2020
Relazioni coi fantasmi
Senza parere, avevo confessato una grande, disdicevole verità. Per certi versi trattavo Aguidi come una bella preda e la sfruttavo anche più di quanto avessero fatto probabilmente le sorelle. Le avevo trovato un'occupazione meno pesante e meglio remunerata di quella nella stireria dove la conobbi (e dove qualche volta andava ancora per arrotondare lo stipendio), ma nello stesso tempo mi facevo mantenere da lei. Io non avevo più voglia di lavorare. Avevo annullato quasi tutte le visite coi miei soliti pazienti, che trascinavano la terapia da anni senza risultato. Non avevo più la forza di portarne il peso e li avevo dirottati presso colleghi più in gamba di me. Anche le mie finanze ne avevano risentito. Ora era Aguidi che si occupava quasi di tutto, in casa e fuori.
venerdì 24 gennaio 2020
Sogni e sogni
domenica 22 dicembre 2019
Considerazione sui libri che parlano di scrittori
Mentre ha senso aspirare a veder pubblicati i frutti del proprio lavoro, meno senso ha pretendere una vera e propria carriera come per una qualsiasi altra professione. Non mi convince l'imborghesimento dell'arte.
Spostandoci sui contenuti, alle trame con il narcisismo dello scrittore in primo piano preferisco decisamente un romanzo come Memoriale di Volponi, dove si parla di un operaio che non riesce a fare l'operaio.
giovedì 5 dicembre 2019
Un buco nero di silenzio
Molti romanzi di donne sono introspettivi.
E' cosa da festeggiare, dal momento che capita frequentemente di sfogliare libri e bestseller che sembrano commissionati sulla base di regole troppo commerciali e riproducono quasi in serie note false o stonate; sembrano di plastica pure loro, come le tante merci che ci sommergono. In altre parole, sembrano ingiustificati. Tuttavia l'umanità continua a esistere, con le sue incertezze e sofferenze, e a formulare inquieti interrogativi sull'esistenza, forse timidamente, forse in maniera appena percettibile in mezzo al frastuono di forme mediatiche in altre faccende affaccendate. Ho l'impressione che questa voce sottile ma acuta, portatrice di amore per la verità, sia soprattutto incarnata da donne che scrivono. E' solamente un'impressione, poiché non sono in grado di leggere tutto ciò che si produce, ma ho alcuni riscontri.