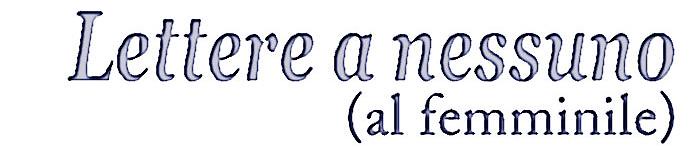1) Dai tuoi studi, dalle tue riflessioni su alcuni testi di poetesse del secondo Novecento emergono tre archetipi culturali, in qualche modo discendenti dall’unico mito di un’antica dea greca lunare dai molti nomi (Artemide, Ecate, Diana, Lucina…) dal doppio volto di protettrice delle fanciulle ma anche, talvolta, di persecutrice-vendicatrice. Mi piacerebbe che ti soffermassi su ognuna di queste sfaccettature che potevano connotare la figura della poetessa/scrittrice ancora fino a molto di recente. Iniziamo con il suo essere parthénos, termine che anticamente valeva per “nubile”, “non sposata” ma anche “lesbica”, “adolescente”, non destinata alle nozze. (Inciso mio: questo tema, peraltro, non appartiene esclusivamente al tempo passato: Ingeborg Bachman ancora nel 1989 sostiene che il matrimonio "è impossibile per una donna che lavora e che pensa e che vuole lei stessa essere qualche cosa."*). La necessità di separarsi dal destino comune delle donne e dai fortissimi limiti esistenziali, che la condizione femminile certamente comportava, per concentrarsi sulla scrittura, poteva avere pesanti ricadute sulla sua vita emotiva, affettiva… sulla sua vita tout court.
2) Da “diversa, lontana, distaccata” a “pazza” il passo è breve. Questo binomio, poetessa pazza, concretizzatosi così spesso, è in parte collegato, a mio parere, anche all’antica presenza nei miti e nei riti di pizie, sibille, “cassandre”, maghe, indovine le quali, in quanto donne (ipersensibili) considerate nei secoli meno razionali degli uomini, si ritenevano più vicine al mondo altro degli dei, dei segni, dei simboli. Tuttavia questa che sembrerebbe essere stata una separazione forzata, ingiustamente imposta, dei ruoli e delle possibilità intellettuali fra i sessi forse dopo la scoperta freudiana ha rivelato i suoi vantaggi: la donna poeta è stata tanto più accettata e apprezzata in quanto ritenuta particolarmente ricettiva dei segnali che manda l’inconscio e persino capace di parlare la lingua dell’inconscio, così come secoli fa era capace, nei vaticini, di parlare l’oscura lingua degli dei. Ci sarebbe naturalmente molto da dire sul legame tra follia e scrittura, che non riguarda solo le donne… Desideri mettere a fuoco qualcosa in merito, visto che ti sei occupata a lungo di Sylvia Plath, Anne Sexton, Amelia Rosselli?