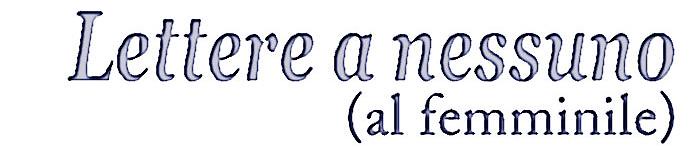Ezio Sinigaglia è un altro autore che ha patito un'esclusione: il suo corposo esordio nel 1985 da un piccolo editore milanese, Il pantarèi, romanzo-saggio ricco di spunti e riflessioni che ruotano intorno alle grandi innovazioni stilistiche del Novecento, non ebbe nessuna eco in un panorama culturale che si stava decisamente ricompattando intorno a forme narrative ottocentesche: un postmoderno definito da Sinigaglia stesso un ritorno al premoderno.
Salardi: All’inizio si pone una
questione di metodo. “Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi
una luce. Era inesplicabile a lui stesso. Eppure era il progetto più forte e
preciso che avesse mai formulato in vita sua.”: così l’incipit di Eclissi (Nutrimenti,
Roma 2016, pag 7). Allo stesso modo si potrebbe ipotizzare che Il
pantarèi (ora riproposto da TerraRossa edizioni, Bari
2019, a quasi trentacinque anni dalla prima edizione – SPS-Sapiens, Milano
1985) punti all’oscurità, alla complessità tipiche dei maggiori romanzi del
Novecento, per cogliervi un’indicazione su come proseguire il lavoro in questo
che diviene un genere completamente diverso nel secolo che ci precede: a pag 65
del Pantarèi si osserva che il romanzo
era sempre stato nei secoli “il genere letterario ‘leggero’, nel quale tradizionalmente i valori del mythos (i
fatti, l’azione, l’avventura, le fortune, le catastrofi) prevalgono su quelli
dell’ethos (la sfera morale dell’uomo, e dunque il
pensiero, il cuore, l’intelletto). Le innovazioni tecniche di cui si è parlato
sono tali da ribaltare completamente questo rapporto: nei romanzi del ’900 i
fatti sono generalmente ben poca cosa, ciò che conta è il libero serpeggiare
della coscienza intorno ad essi. Il romanzo viene ad assumere quasi un
aspetto ‘saggistico’ che
gli era prima completamente estraneo. Diviene, insomma, un nuovo genere
letterario”. L’excursus saggistico
sulla prosa più innovativa del secolo breve mira a ricavare un orientamento
addentrandosi nell’analisi e talora nel calco degli stili più densi e ricchi
che ci siano stati lasciati in eredità. Si fa tesoro qui della scoperta
proustiana (o freudiana o sveviana) secondo la quale è inutile affrontare
direttamente il vero poiché ci sfugge, viene rimosso e misconosciuto. Occorre aspettare
che la memoria involontaria ci venga in aiuto, aspettare l’attimo rivelatore.
Allontanarsi dalle abitudini, dai doveri, dalle frequentazioni quotidiane per
permettere che emergano verità profonde su noi stessi altrimenti offuscate,
nascoste dalle urgenze e dai condizionamenti che inghiottono la nostra vita
togliendole senso, per quanto riguarda il personaggio di Akron nell’Eclissi; allontanarsi dalle convenzioni e immergersi negli stili che hanno
senso per noi, aspettando che la propria voce emerga, pungolata dalle emozioni
e dagli accadimenti, per quanto riguarda l’aspirante scrittore…
Sinigaglia: Non
è certo arbitrario questo parallelo metodologico o, se vogliamo, progettuale
fra i miei due soli romanzi finora pubblicati. In più di un’occasione ho
lasciato capire che l’incipit di Eclissi,
“Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce”, appeso
lassù in cima alla prima pagina come un esergo, è anche una dichiarazione
d’intenti, una promessa fatta al lettore più attento, o viceversa un monito
rivolto a quello più frettoloso e meno disposto all’avventura. In questo senso,
dunque, il progetto di Akron, il protagonista, coincide con il progetto
dell’autore, ed è quindi lecito ipotizzare che non si tratti di un progetto
isolato, ma che per l’autore scrivere voglia dire proprio questo: tuffarsi
nelle tenebre per sfruttare la sorprendente potenza che una flebile luce può
assumere quando è circondata dall’oscurità più totale. Perché naturalmente la
luce che noi (intendo noi poveri artigiani della scrittura, che non osiamo più
nemmeno chiamarci artisti), la luce che noi, dicevo, nella migliore delle
ipotesi, riusciamo ad accendere è una fiammella davvero minuscola, come quella
di un cerino, e dunque può essere di qualche utilità soltanto nelle tenebre assolute.
Ma non credo che questo principio, nel quale adesso – a settant’anni – mi
sembra condensarsi il segreto stesso della letteratura, mi fosse così chiaro a
ventott’anni, quando concepii il progetto del Pantarèi e mi accinsi a realizzarlo. Il mio movente di allora era
piuttosto, come ho cercato di chiarire nella Prefazione a questa seconda
edizione, l’ambizione di dimostrare che il romanzo non era affatto morto.
Certo, per realizzare un simile progetto era necessario calarsi a fondo dentro
la vicenda del romanzo del Novecento e aprirsi una strada fra i cespugli dei
suoi apparenti paradossi fino a trovare un filo di coerenza da seguire. Il che
equivale forse a dire che occorreva inabissarsi nell’oscurità fino a cogliervi
una piccola luce. Di questo però non ero consapevole a quei tempi: credo di
essermi lasciato guidare dall’istinto o, se preferisce, dalla mia passione di
lettore, che era già forte e consolidata, e dalla mia vocazione di scrittore,
che cominciava ormai a palpitarmi sottopelle. In fondo il progetto del Pantarèi è nato nella mente di un
ragazzo che, fino ad allora, aveva avuto della letteratura un’esperienza
esclusivamente passiva: una mente ingenua e avventata, anche se
provvidenzialmente armata di senso critico e ironia. Eppure questo romanzo si
colloca così armoniosamente all’inizio del mio percorso, lungo e accidentato,
di scrittore, che si direbbe un esordio studiato a posteriori.
Salardi: A pagina 98 del Pantarèi in
un momento di esaltazione il narratore protagonista leva una preghiera a padre
Joyce: “Lode a te, organismo uno e trino. Gloria al padre intelletto, al cuore
figlio e alla santa spiritualità del corpaccio nostro gaudente e dolente. Padre
Joyce che sei nei cieli, posa i tuoi occhi sofferenti su di noi, proteggi il
tuo umile servo Stern, che elevando oggi a te l’ammirato canto della sua
devozione ha guadagnato il pane suo quotidiano con il sudore benedetto della
fronte sua. Proteggilo, e tieni lontana da lui ogni tentazione, ma sopra tutte
quella rovinosa della letteratura, che Satana con le sue arti malefiche tenta
già di insinuargli nel petto. Scrolla via dal capo del tuo umile servo, o padre
James, il peccato orribile della superbia. Ricordagli che, come tu hai
stabilito, non vi sarà altro romanzo dopo di te. Amen.” Se non bastasse questa
dichiarazione di poetica, Il pantarèi si dimostra nel
complesso joyciano: molte sono le parti di flusso di coscienza, le variazioni
stilistiche di capitolo in capitolo, i giochi di parole, i termini-macedonia
sintesi di più vocaboli, la radicale opposizione al linguaggio semplificato in
auge dell’attuale industria editoriale. Nel romanzo successivo, Eclissi,
è
stata invece rintracciata da vari commentatori soprattutto l’influenza di
Proust. Verso quali Maestri si sente in particolare debitore?