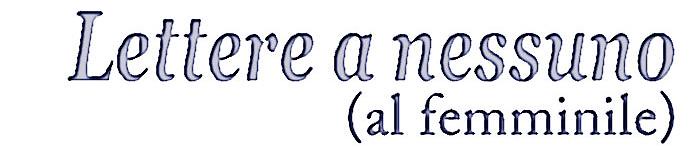... una cosa importante. Piace il "realistico consolatorio", scrive, dopo acute, amare considerazioni, degne di altre lettere a nessuno al femminile (come ho lasciato intendere nel post Naufragare non è dolce) la scrittrice Claudia Zaggia, una mia simile, nel suo Naufraganti (Italic Pequod 2015). Le parole precise sono queste alla pagina 43 del romanzo: "Ormai so che cosa piace a quelli che danno i premi, alle giurie piace il realistico consolatorio facilmente detto e con dei buoni propositi, i buoni propositi sono tutto nella cattiva letteratura." (pag 43).
Consolatoria o meno, cattiva o buona letteratura che sia, soffermiamoci ancora una volta sul realismo e limitiamoci a riconoscere che in Italia il realismo di stampo sociologico ha avuto una lunga stagione, che dura tuttora.* Anche alcuni romanzi da me citati e apprezzati sono nati nel suo alveo, l'ho ammesso, sebbene non abbia risparmiato attacchi alle sue forme più tradizionali a mio avviso superate (il narratore extradiegetico, il distacco pseudoscientifico).
Va però riconosciuta una valida giustificazione storico-sociale a questa scelta preminente degli scrittori di adesso: la storia italiana recente, come la nostra stessa contemporaneità, è piena di fatti criminosi riconducibili a importanti ed estese organizzazioni dal potere capillarmente diffuso e ben radicato nel territorio. Oltre ai numerosi traffici illeciti, agli scandali frequenti, che lambiscono ruoli e personalità di spicco del mondo politico-finanziario, oltre insomma alle note mafie che per certi aspetti ci rendono famosi nel mondo, non si possono non ricordare gli anni oscuri dei piani eversivi e delle stragi col relativo insabbiamento delle indagini e poi ancora processi legati a gravi reati (per esempio ambientali), che faticano ad arrivare a sentenza.