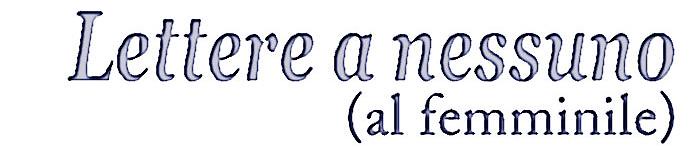Che
cos’hanno in comune testi tanto lontani nel tempo? L’elemento macroscopico è
che entrambi sono segnati dalla presenza di un diffuso maschilismo e
patriarcato duro a morire. Il racconto di De Stefani, presessantottino ma già
femminista, dipinge il quadro di una società patriarcale, contadina, in cui le
donne portano sulle spalle il peso dei parti, degli aborti clandestini, delle
gravidanze indesiderate, di amori più
o meno imposti come un destino cui non si può sfuggire, violentate o rudemente
sedotte per brevi avventure ancora molto giovani e sprovvedute, specie se di
classe inferiore. Il romanzo dell’esordiente Piccinni, in chiave più moderna, rimanda
a una gioventù postsessantottina ma ancora e sempre bruciata, che si macera
nell’immobilismo e nella saudade di un
Suditalia abbandonato a se stesso, rassegnato ai suoi mali inguaribili: è
ambientato a Taranto, dove si dà per scontato che nulla possa cambiare nella
situazione industriale e ambientale così come nella vita privata dei singoli,
mentre permangono antiche cerimonie religiose di celebrazione collettiva del
dolore. Alle ragazze anche più trasgressive, poco sottomesse a scuola e in
famiglia, che fumano e bevono birra coi loro coetanei fin da adolescenti, viene
riservato comunque un ruolo passivo: “Hai voluto fare parte di tre vite. Le hai
volute distruggere tutte e tre. Prima prendendo due donne e consumandole, poi
uccidendo me. Mi hai preso, anche se non ti ho voluto. Sei entrato nella mia
vita e, dall’interno, hai iniziato a scardinarmi. Hai dilaniato la mia vita e
mi hai fatto impazzire. Mi hai costretta a essere tua.” (pag 130).
sabato 29 giugno 2019
Diciottenni suicide
Nel
1963 Livia De Stefani dava voce all’angoscia di una servetta diciottenne
sedotta e abbandonata con le conseguenze del caso, cui la giovane fa fronte
maldestramente, nel panico, sopprimendo sul nascere il “frutto del peccato” e
avvicinandosi sempre più al suicidio nelle ore seguenti, narrate in Viaggio di una sconosciuta (Mondadori,
Milano 1963). Il lungo racconto, recentemente ristampato dalle edizioni Cliquot
(Roma 2018), è molto interessante per il flusso d’angoscia della protagonista
sullo sfondo di una Roma assolata e spietata; spietata a causa del quadro
sociale che lascia intravedere (ne parlo qui: https://voltandopagine.blogspot.com/search/label/livia%20de%20stefani ). A distanza di oltre quarant’anni Flavia
Piccinni col suo esordio Adesso tienimi
(Fandango 2007; Terrarossa, Bari 2019) accosta il tema analogo della seduzione
brutale di una ragazzina appena diciottenne o quasi, la quale, pur non avendo a
che fare con una gravidanza indesiderata, si trova a dover elaborare una dura
storia di amore malato, cui
inizialmente viene costretta da un suo insegnante, che a un certo punto
comincia a desiderare e che vede poi bruscamente interrotta dal suicidio di
lui, il quale non le lascia alcuna spiegazione (“Per me non avevi lasciato
niente, perché non ero niente.” Terrarossa ed., pag 161).
domenica 2 giugno 2019
L'esclusione esiste
Forse ho generato una certa antipatia e diffidenza intitolando questo sito-blog Lettere a nessuno (al femminile), con un calco evidente del titolo di un libro che suscitò discussioni. Quello era un libro; questo è un sito che finisce per contenere un po' di tutto, esposto a eventi, questioni di attualità, contaminazioni, incontri. Per la precisione sarebbe un blog, ma, per via dell'introversione dell'amministratrice, è vissuto quasi come un diario. Uno dei temi di fondo di questo diario pubblico resta l'esclusione, come anticipato appunto nel titolo preso in prestito.
Sappiamo che Antonio Moresco a un certo punto ha avuto fortuna e il suo isolamento dal mondo editoriale (che entra anche nella vicenda degli Esordi, non solamente nelle Lettere a nessuno) non è durato per sempre. Altri scriventi sono rimasti e continuano a restare ingiustamente nell'ombra. Colpa loro? Difficile dirlo.
Consideriamo gli scrittori Mariano Bargellini ed Ezio Sinigaglia, arrivati a un qualche riconoscimento dopo i sessant'anni.
Con Mus utopicus (Gallino, Milano 1999), La setta degli uccelli (Corbo, Ferrara 2010) e Giocare a mangiarsi (Effigie, Milano 2015) Bargellini (anno di nascita: 1936) ha elaborato una prosa densa (neobarocca, a suo dire) e trame fra l'onirico e il fantastico, restando uno scrittore di nicchia. Qualcuno potrebbe obiettare: ma il barocco è un vicolo cieco in questa società frenetica dominata da notizie-flash, slogan, tweet, small talk. E poi il fantastico ha una tradizione esile in Italia, dove in genere ha prevalso il realismo con le sue varianti (per motivi anche politico-sociali, a ben vedere: diffusa criminalità organizzata, scandali, politica corrotta, in cui la realtà sociale chiede da più parti di essere guardata in faccia e descritta senza reticenze; da qui il successo del giornalismo d'inchiesta e dei reportages narrativi tipo Gomorra).
Tuttavia Bargellini sostiene: "La mia scelta ha una lunga tradizione nel Novecento, pensate a Kafka o al Manganelli della Palude definitiva". E aggiunge: "Andate a leggere o rileggere Caos e bellezza di Omar Calabrese: capirete quanto può essere moderno il neobarocco".
Ezio Sinigaglia (anno di nascita: 1948), dopo un esordio intorno ai trent'anni passato inosservato con un corposo romanzo-saggio che s'interroga sulle principali innovazioni stilistiche del Novecento (Il pantarèi, SPS-Sapiens, Milano 1985), trascorre decenni di vita appartata dedicandosi alla stesura di testi rimasti nel cassetto, tranne un breve romanzo di stampo più tradizionale, pubblicato da una casa editrice che comincia a dargli visibilità (Eclissi, Nutrimenti, Roma 2016). Finalmente, con la ristampa di quel primo romanzo degli anni ottanta, ottiene molti apprezzamenti. Con questa nuova apparizione del Pantarèi nel 2019 (grazie alla coraggiosa casa editrice Terrarossa di Bari) è come appena nato nella società delle lettere.
Il suo caso è emblematico: più di trent'anni di sepoltura di un testo vivo e ricco che affronta un tema rimosso negli ultimi decenni, quello del confronto con la prosa più innovativa del Novecento. Nel cimentarsi con la sua opera d'esordio in un genere, quello del romanzo, considerato in crisi e da alcuni ormai dato per morto, il protagonista Stern, alter-ego dell'autore, attraversa e testa su di sé (su diverse parti della vicenda) gli stili che hanno rivoluzionato il modo di narrare dei secoli precedenti.
Scrive Angelo Di Liberto in una recensione al Pantarèi: "Viviamo nell'epoca del godimento che è sempre a scapito della responsabilità. Ciò che importa è la fruizione spicciola, l'illusione emotiva, la crosta sulfurea di un'epidermide sottoposta ad agenti esterni ad alta virulenza d'insignificanza. La coscienza nana ha sostituito la natura morale e intellettuale e a seppellire ogni guizzo creativo ci pensa il mercato delle classifiche. Perché nella quantità si esperisce lo scopo aziendale, dato che la qualità è indigesta speculazione al rialzo di consapevolezza. Ad aggiungersi alla consunzione vi è l'idea, ormai radicata, che la lettura abbia perso autorevolezza e centralità (...) I dati statistici sono emblema di un settore in disfacimento, senza transustanziazione del caso (...) A fare i conti con la situazione letteraria della sua giovinezza, dato che la prima pubblicazione del libro è della metà degli anni ottanta del secolo scorso, è un autore che instilla nuova linfa vitale alla quercia centenaria della letteratura, cimentandosi in un florilegio stilistico degno dei grandi autori passati alla posterità (...) Come un moderno Zeno si aggira per casa, vaga per le stanze e invoca i suoi fantasmi, attribuendo alla letteratura una funzione terapeutica così da restituire senso e valore alla vita." (Morte (e resurrezione) del romanzo, la Repubblica, Palermo 4.4.2019).
Sappiamo che Antonio Moresco a un certo punto ha avuto fortuna e il suo isolamento dal mondo editoriale (che entra anche nella vicenda degli Esordi, non solamente nelle Lettere a nessuno) non è durato per sempre. Altri scriventi sono rimasti e continuano a restare ingiustamente nell'ombra. Colpa loro? Difficile dirlo.
Consideriamo gli scrittori Mariano Bargellini ed Ezio Sinigaglia, arrivati a un qualche riconoscimento dopo i sessant'anni.
Con Mus utopicus (Gallino, Milano 1999), La setta degli uccelli (Corbo, Ferrara 2010) e Giocare a mangiarsi (Effigie, Milano 2015) Bargellini (anno di nascita: 1936) ha elaborato una prosa densa (neobarocca, a suo dire) e trame fra l'onirico e il fantastico, restando uno scrittore di nicchia. Qualcuno potrebbe obiettare: ma il barocco è un vicolo cieco in questa società frenetica dominata da notizie-flash, slogan, tweet, small talk. E poi il fantastico ha una tradizione esile in Italia, dove in genere ha prevalso il realismo con le sue varianti (per motivi anche politico-sociali, a ben vedere: diffusa criminalità organizzata, scandali, politica corrotta, in cui la realtà sociale chiede da più parti di essere guardata in faccia e descritta senza reticenze; da qui il successo del giornalismo d'inchiesta e dei reportages narrativi tipo Gomorra).
Tuttavia Bargellini sostiene: "La mia scelta ha una lunga tradizione nel Novecento, pensate a Kafka o al Manganelli della Palude definitiva". E aggiunge: "Andate a leggere o rileggere Caos e bellezza di Omar Calabrese: capirete quanto può essere moderno il neobarocco".
Ezio Sinigaglia (anno di nascita: 1948), dopo un esordio intorno ai trent'anni passato inosservato con un corposo romanzo-saggio che s'interroga sulle principali innovazioni stilistiche del Novecento (Il pantarèi, SPS-Sapiens, Milano 1985), trascorre decenni di vita appartata dedicandosi alla stesura di testi rimasti nel cassetto, tranne un breve romanzo di stampo più tradizionale, pubblicato da una casa editrice che comincia a dargli visibilità (Eclissi, Nutrimenti, Roma 2016). Finalmente, con la ristampa di quel primo romanzo degli anni ottanta, ottiene molti apprezzamenti. Con questa nuova apparizione del Pantarèi nel 2019 (grazie alla coraggiosa casa editrice Terrarossa di Bari) è come appena nato nella società delle lettere.
Il suo caso è emblematico: più di trent'anni di sepoltura di un testo vivo e ricco che affronta un tema rimosso negli ultimi decenni, quello del confronto con la prosa più innovativa del Novecento. Nel cimentarsi con la sua opera d'esordio in un genere, quello del romanzo, considerato in crisi e da alcuni ormai dato per morto, il protagonista Stern, alter-ego dell'autore, attraversa e testa su di sé (su diverse parti della vicenda) gli stili che hanno rivoluzionato il modo di narrare dei secoli precedenti.
Scrive Angelo Di Liberto in una recensione al Pantarèi: "Viviamo nell'epoca del godimento che è sempre a scapito della responsabilità. Ciò che importa è la fruizione spicciola, l'illusione emotiva, la crosta sulfurea di un'epidermide sottoposta ad agenti esterni ad alta virulenza d'insignificanza. La coscienza nana ha sostituito la natura morale e intellettuale e a seppellire ogni guizzo creativo ci pensa il mercato delle classifiche. Perché nella quantità si esperisce lo scopo aziendale, dato che la qualità è indigesta speculazione al rialzo di consapevolezza. Ad aggiungersi alla consunzione vi è l'idea, ormai radicata, che la lettura abbia perso autorevolezza e centralità (...) I dati statistici sono emblema di un settore in disfacimento, senza transustanziazione del caso (...) A fare i conti con la situazione letteraria della sua giovinezza, dato che la prima pubblicazione del libro è della metà degli anni ottanta del secolo scorso, è un autore che instilla nuova linfa vitale alla quercia centenaria della letteratura, cimentandosi in un florilegio stilistico degno dei grandi autori passati alla posterità (...) Come un moderno Zeno si aggira per casa, vaga per le stanze e invoca i suoi fantasmi, attribuendo alla letteratura una funzione terapeutica così da restituire senso e valore alla vita." (Morte (e resurrezione) del romanzo, la Repubblica, Palermo 4.4.2019).
giovedì 23 maggio 2019
Bruciare tutto tranne il Narratore onnisciente
Ho letto Bruciare tutto (Rizzoli, Milano 2017) di Walter Siti messa sulle sue tracce da un articolo di Matteo Marchesini, "Siti gnostico", a suo tempo pubblicato sul Foglio, adesso raccolto in Casa di carte (il Saggiatore, Milano 2019). Il romanzo ha molte frecce al suo arco, affrontando grandi temi come il senso della vita, il sentimento religioso, la perversione, il bene e il male. Non è permeato come altri romanzi di Siti dal mito dei culturisti, quindi l'ho letto con interesse.
Al centro si svolge il dramma di un giovane che scopre in sé fin da adolescente tendenze pedofile e fa grandi sforzi per dominarle, inizialmente da solo, senza riuscirvi. Cerca rifugio nel sacerdozio, suggestionato anche dalla convinzione (psicotica?) di sentire la voce di Dio: cerca di sublimare le sue pulsioni e scontare i suoi peccati con gesti di grande altruismo, che gli guadagnano la simpatia e l'ammirazione di tanti parrocchiani. Ma la sua vita mentale è torbida, il mondo esterno, che pur lo assedia da ogni parte con richieste continue d'aiuto, non riesce a soffocare fantasie devianti, cui il succube oppone una volontà ferrea e convinzioni talvolta fanatiche e allarmanti ("non esiste una religione moderata, se è moderata non è religione" pag 123). Date le premesse, questo romanzo sarebbe adatto all'introspezione: monologhi, sogni e persino esercizi spirituali degenerati (pagg 60-63) non mancano; ma la verità è fuori ("... la verità - se mai quaggiù può esserci verità - è più fuori che dentro di noi" pag 240): il personaggio Leo e lo scrittore Walter Siti ne sono convinti, quindi vi si buttano. A descriverci un ambiente straripante di segni è dunque un Narratore forte, che tutto coglie con una sensibilità iperesercitata, dal bisbiglio di una fontana, forse voce di Dio (pag 233) ai più vari parlati sociali. Ma le persone stanno nelle loro parole?
domenica 12 maggio 2019
Perché Dante
Il cammino ecologista e culturale di Repubblica nomade quest'anno (2019) mira a percorrere un cuore dell'Italia fatto dei valori di rettitudine,
sobrietà, solidarietà, lucidità di pensiero trasmessi nel tempo dalle
personalità fondatrici di Dante, Francesco d'Assisi e Leopardi.
Le celebrazioni di classici sempre a noi vicini sono più
che mai opportune. Pensiamo a Dante. Le sue parole, talvolta aspre e sferzanti,
continuano a risuonare cariche di significato in un Paese come il nostro
tutt'oggi ferito dalla piaga della corruzione, della trascuratezza e del
degrado (secondo le stime del 2018, l'Italia occupa tra i peggiori posti in
Europa e il 53° nel mondo per il problema della corruzione).
A distanza di secoli colpisce un senso della giustizia
che non fa sconti alla memoria di personaggi celebri e altolocati, d'arme e di
religione, spesso impegnati in terribili lotte per ricchezza e potere, aperte o
intestine, che insanguinarono l'Italia in un'epoca bassomedievale in cui l'egemonia
dell'Impero (rimpianto da Dante come la forza che favorì l'età d'oro della pax
romana e un'idealizzata età feudale-cavalleresca) era ormai fortemente
contrastata dal sorgere di ricchi feudi, signorie e comuni continuamente
impegnati nel fronteggiarsi a vicenda. Accanto alla feudalità agraria, si
andava sviluppando un ceto arricchito dalle vivaci attività commerciali e
artigianali fiorenti all'interno di numerose città: la situazione era instabile
e caratterizzata da sempre nuove alleanze e contrasti interni alle città-stato
o relativi ai rapporti con le maggiori dinastie europee. Lo stesso Dante pagò
con l'esilio la partecipazione alla vita politica della sua Firenze, "nido
di malizia tanta" (Inferno XV,
v 78). Ma se la violenza e l'inganno sono puniti nei gironi più bassi
dell'Inferno, il non parteggiare per nessuno, proprio degli ignavi, ottiene dal
poeta il massimo disprezzo alle porte degli inferi, là dove un folto numero di
anime indifferenti e vili, che mai non
fur vive, perché non furono animate da impegno e partecipazione, non
vengono considerate né da Dio né dagli uomini, che non serbano di loro alcuna
memoria (III, vv 22-69). La turba
degli indifferenti è uno sfondo che vale per tutti i tempi tuttavia l'età dei
comuni fu tutt'altro che amorfa e monotona. Nel breve frammento qui riportato
della celebre apostrofe all'Italia (Purgatorio
VI, vv 76-151) essa appare lacerata da insanabili discordie e da fazioni ferocemente
avverse persino all'interno delle stesse mura cittadine: "Ahi serva
Italia, di dolore ostello (…) ora in te non stanno sanza guerra/ li vivi tuoi,
e l'un l'altro si rode/ di quei ch'un muro e una fossa serra" (vv 76-84). L'inganno
e il tradimento, tramati senza sosta, possono tendere agguati mortali e
determinare la caduta d'intere città: i traditori sono puniti nel fondo
dell'Inferno, là dove pur brilla l'intelligenza di Ulisse (Inferno XXVI), capace di spingere lui e i compagni alla scoperta
dell'ignoto, di superare ogni limite, ma anche di divenire strumento per
ingannare e colpire l'avversario. Il canto di Ulisse non contiene solo una
verità ma più di una verità: le capacità umane destano in noi orgoglio e ammirazione
ma possono rapidamente portare alla rovina.
I mali degli uomini derivano nella maggior parte dei casi
dalla brama di ricchezze. Strali contro l'avidità attraversano tutto il poema.
Fin dal I canto dell'Inferno la lupa è la fiera che più
spaventa Dante e lo respingerebbe indietro nella selva oscura se non
intervenisse Virgilio; nel XXVII
canto del Paradiso (vv 19-67), non lontano
dall'Empireo, San Pietro tuona contro la corruzione del papato, tema anticipato
già nel canto XVII della stessa
cantica, ove si dice che Roma è il luogo "dove Cristo tutto dì si
merca" (v 51). Nello stesso canto XVII
(vv 124-142) l'antenato Cacciaguida esorta Dante a non tacere le iniquità né i
nomi dei malfattori altolocati e delle loro potenti famiglie, considerata la
funzione esemplare e altamente morale del suo ruolo di scrittore: "Ma
nondimen, rimossa ogne menzogna,/ tutta tua vision fa manifesta;/ e lascia pur
grattar dov'è la rogna" (vv 127-129). Nel canto XI del Paradiso viene esaltata,
per contrasto, l'unione tra San Francesco e Madonna Povertà (28-117) mentre gli
usurai (oggi li chiameremmo semplicemente banchieri), coloro che traggono denaro
da denaro, offendono la bontà divina poiché non vivono del prodotto del loro
lavoro o dei frutti della natura, secondo la legge biblica, bensì degli
interessi sul prestito. Nell'XI
canto dell'Inferno (vv 97-111) è ben
specificato che il lavoro non è da intendersi soltanto come condanna e fatica
ma anche come forma di avvicinamento all'opera di Dio: così come Dio ha creato
il mondo l'essere umano inventa continuamente le proprie attività e produce le
cose di cui ha bisogno. Voler guadagnare senza passare attraverso l'attività e
la creatività è un peccato.
giovedì 7 febbraio 2019
Conversazione con Ezio Sinigaglia
Ezio Sinigaglia è un altro autore che ha patito un'esclusione: il suo corposo esordio nel 1985 da un piccolo editore milanese, Il pantarèi, romanzo-saggio ricco di spunti e riflessioni che ruotano intorno alle grandi innovazioni stilistiche del Novecento, non ebbe nessuna eco in un panorama culturale che si stava decisamente ricompattando intorno a forme narrative ottocentesche: un postmoderno definito da Sinigaglia stesso un ritorno al premoderno.
Salardi: All’inizio si pone una questione di metodo. “Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce. Era inesplicabile a lui stesso. Eppure era il progetto più forte e preciso che avesse mai formulato in vita sua.”: così l’incipit di Eclissi (Nutrimenti, Roma 2016, pag 7). Allo stesso modo si potrebbe ipotizzare che Il pantarèi (ora riproposto da TerraRossa edizioni, Bari 2019, a quasi trentacinque anni dalla prima edizione – SPS-Sapiens, Milano 1985) punti all’oscurità, alla complessità tipiche dei maggiori romanzi del Novecento, per cogliervi un’indicazione su come proseguire il lavoro in questo che diviene un genere completamente diverso nel secolo che ci precede: a pag 65 del Pantarèi si osserva che il romanzo era sempre stato nei secoli “il genere letterario ‘leggero’, nel quale tradizionalmente i valori del mythos (i fatti, l’azione, l’avventura, le fortune, le catastrofi) prevalgono su quelli dell’ethos (la sfera morale dell’uomo, e dunque il pensiero, il cuore, l’intelletto). Le innovazioni tecniche di cui si è parlato sono tali da ribaltare completamente questo rapporto: nei romanzi del ’900 i fatti sono generalmente ben poca cosa, ciò che conta è il libero serpeggiare della coscienza intorno ad essi. Il romanzo viene ad assumere quasi un aspetto ‘saggistico’ che gli era prima completamente estraneo. Diviene, insomma, un nuovo genere letterario”. L’excursus saggistico sulla prosa più innovativa del secolo breve mira a ricavare un orientamento addentrandosi nell’analisi e talora nel calco degli stili più densi e ricchi che ci siano stati lasciati in eredità. Si fa tesoro qui della scoperta proustiana (o freudiana o sveviana) secondo la quale è inutile affrontare direttamente il vero poiché ci sfugge, viene rimosso e misconosciuto. Occorre aspettare che la memoria involontaria ci venga in aiuto, aspettare l’attimo rivelatore. Allontanarsi dalle abitudini, dai doveri, dalle frequentazioni quotidiane per permettere che emergano verità profonde su noi stessi altrimenti offuscate, nascoste dalle urgenze e dai condizionamenti che inghiottono la nostra vita togliendole senso, per quanto riguarda il personaggio di Akron nell’Eclissi; allontanarsi dalle convenzioni e immergersi negli stili che hanno senso per noi, aspettando che la propria voce emerga, pungolata dalle emozioni e dagli accadimenti, per quanto riguarda l’aspirante scrittore…
Salardi: All’inizio si pone una questione di metodo. “Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce. Era inesplicabile a lui stesso. Eppure era il progetto più forte e preciso che avesse mai formulato in vita sua.”: così l’incipit di Eclissi (Nutrimenti, Roma 2016, pag 7). Allo stesso modo si potrebbe ipotizzare che Il pantarèi (ora riproposto da TerraRossa edizioni, Bari 2019, a quasi trentacinque anni dalla prima edizione – SPS-Sapiens, Milano 1985) punti all’oscurità, alla complessità tipiche dei maggiori romanzi del Novecento, per cogliervi un’indicazione su come proseguire il lavoro in questo che diviene un genere completamente diverso nel secolo che ci precede: a pag 65 del Pantarèi si osserva che il romanzo era sempre stato nei secoli “il genere letterario ‘leggero’, nel quale tradizionalmente i valori del mythos (i fatti, l’azione, l’avventura, le fortune, le catastrofi) prevalgono su quelli dell’ethos (la sfera morale dell’uomo, e dunque il pensiero, il cuore, l’intelletto). Le innovazioni tecniche di cui si è parlato sono tali da ribaltare completamente questo rapporto: nei romanzi del ’900 i fatti sono generalmente ben poca cosa, ciò che conta è il libero serpeggiare della coscienza intorno ad essi. Il romanzo viene ad assumere quasi un aspetto ‘saggistico’ che gli era prima completamente estraneo. Diviene, insomma, un nuovo genere letterario”. L’excursus saggistico sulla prosa più innovativa del secolo breve mira a ricavare un orientamento addentrandosi nell’analisi e talora nel calco degli stili più densi e ricchi che ci siano stati lasciati in eredità. Si fa tesoro qui della scoperta proustiana (o freudiana o sveviana) secondo la quale è inutile affrontare direttamente il vero poiché ci sfugge, viene rimosso e misconosciuto. Occorre aspettare che la memoria involontaria ci venga in aiuto, aspettare l’attimo rivelatore. Allontanarsi dalle abitudini, dai doveri, dalle frequentazioni quotidiane per permettere che emergano verità profonde su noi stessi altrimenti offuscate, nascoste dalle urgenze e dai condizionamenti che inghiottono la nostra vita togliendole senso, per quanto riguarda il personaggio di Akron nell’Eclissi; allontanarsi dalle convenzioni e immergersi negli stili che hanno senso per noi, aspettando che la propria voce emerga, pungolata dalle emozioni e dagli accadimenti, per quanto riguarda l’aspirante scrittore…
Sinigaglia: Non
è certo arbitrario questo parallelo metodologico o, se vogliamo, progettuale
fra i miei due soli romanzi finora pubblicati. In più di un’occasione ho
lasciato capire che l’incipit di Eclissi,
“Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce”, appeso
lassù in cima alla prima pagina come un esergo, è anche una dichiarazione
d’intenti, una promessa fatta al lettore più attento, o viceversa un monito
rivolto a quello più frettoloso e meno disposto all’avventura. In questo senso,
dunque, il progetto di Akron, il protagonista, coincide con il progetto
dell’autore, ed è quindi lecito ipotizzare che non si tratti di un progetto
isolato, ma che per l’autore scrivere voglia dire proprio questo: tuffarsi
nelle tenebre per sfruttare la sorprendente potenza che una flebile luce può
assumere quando è circondata dall’oscurità più totale. Perché naturalmente la
luce che noi (intendo noi poveri artigiani della scrittura, che non osiamo più
nemmeno chiamarci artisti), la luce che noi, dicevo, nella migliore delle
ipotesi, riusciamo ad accendere è una fiammella davvero minuscola, come quella
di un cerino, e dunque può essere di qualche utilità soltanto nelle tenebre assolute.
Ma non credo che questo principio, nel quale adesso – a settant’anni – mi
sembra condensarsi il segreto stesso della letteratura, mi fosse così chiaro a
ventott’anni, quando concepii il progetto del Pantarèi e mi accinsi a realizzarlo. Il mio movente di allora era
piuttosto, come ho cercato di chiarire nella Prefazione a questa seconda
edizione, l’ambizione di dimostrare che il romanzo non era affatto morto.
Certo, per realizzare un simile progetto era necessario calarsi a fondo dentro
la vicenda del romanzo del Novecento e aprirsi una strada fra i cespugli dei
suoi apparenti paradossi fino a trovare un filo di coerenza da seguire. Il che
equivale forse a dire che occorreva inabissarsi nell’oscurità fino a cogliervi
una piccola luce. Di questo però non ero consapevole a quei tempi: credo di
essermi lasciato guidare dall’istinto o, se preferisce, dalla mia passione di
lettore, che era già forte e consolidata, e dalla mia vocazione di scrittore,
che cominciava ormai a palpitarmi sottopelle. In fondo il progetto del Pantarèi è nato nella mente di un
ragazzo che, fino ad allora, aveva avuto della letteratura un’esperienza
esclusivamente passiva: una mente ingenua e avventata, anche se
provvidenzialmente armata di senso critico e ironia. Eppure questo romanzo si
colloca così armoniosamente all’inizio del mio percorso, lungo e accidentato,
di scrittore, che si direbbe un esordio studiato a posteriori.
Salardi: A pagina 98 del Pantarèi in
un momento di esaltazione il narratore protagonista leva una preghiera a padre
Joyce: “Lode a te, organismo uno e trino. Gloria al padre intelletto, al cuore
figlio e alla santa spiritualità del corpaccio nostro gaudente e dolente. Padre
Joyce che sei nei cieli, posa i tuoi occhi sofferenti su di noi, proteggi il
tuo umile servo Stern, che elevando oggi a te l’ammirato canto della sua
devozione ha guadagnato il pane suo quotidiano con il sudore benedetto della
fronte sua. Proteggilo, e tieni lontana da lui ogni tentazione, ma sopra tutte
quella rovinosa della letteratura, che Satana con le sue arti malefiche tenta
già di insinuargli nel petto. Scrolla via dal capo del tuo umile servo, o padre
James, il peccato orribile della superbia. Ricordagli che, come tu hai
stabilito, non vi sarà altro romanzo dopo di te. Amen.” Se non bastasse questa
dichiarazione di poetica, Il pantarèi si dimostra nel
complesso joyciano: molte sono le parti di flusso di coscienza, le variazioni
stilistiche di capitolo in capitolo, i giochi di parole, i termini-macedonia
sintesi di più vocaboli, la radicale opposizione al linguaggio semplificato in
auge dell’attuale industria editoriale. Nel romanzo successivo, Eclissi,
è
stata invece rintracciata da vari commentatori soprattutto l’influenza di
Proust. Verso quali Maestri si sente in particolare debitore?
sullo scaffale
ezio sinigaglia,
giuseppe berto,
italo svevo,
james joyce,
luciano bianciardi,
marcel proust
sabato 26 gennaio 2019
Bio in spiccioli
Ho voluto scrivere poco, considerati anche gli inediti. Ho voluto aspettare che le idee maturassero entrando in incubazione per un certo tempo, dimostrassero di resistere agli attacchi di forze contrarie, come distrazioni o pigrizia, ed eventualmente si arricchissero di nutrimenti vari prima di venire alla luce. Questo per una legge di natura, si potrebbe facilmente affermare: solo qualcosa che possiede una discreta carica libidica, una sua energia, può riuscire a vivere. Accanto a questa motivazione ne scorgo subito un'altra abbastanza aggressiva: ho evitato di soggiacere alla coazione a produrre tipica del meccanismo industriale che ci è familiare nonché a stampare qualunque frase o pensiero passasse per il capo come se un mondo di seguaci o amici facebook fosse sempre lì ad attendere montagne di parole vuote come oro colato. Mi è piaciuto essere libera di scrivere quel che volevo quando volevo. Ho svolto un lavoro impiegatizio in un altro campo, in cui avevo l'impressione di vendere capacità meno preziose per me di quanto non fosse la scrittura. Un sacrificio c'è sempre, perché la società chiede qualcosa in cambio di quello che offre. Si è arrivati a un accomodamento fra le mie ambizioni personali e le esigenze sociali così ho venduto buona parte del mio tempo per svolgere compiti abbastanza lontani dai miei interessi ma non del tutto alieni. Avrebbe potuto anche andar peggio e qualcuno in effetti è costretto a sacrifici ben maggiori dei miei per stare al mondo. Senza allargare troppo il discorso, resta il fatto che il lavoro è conflittuale e la conflittualità del lavoro non so se a qualcuno è risparmiata.
E' giusto comunque che uno scrittore/scrittrice, un/una artista faccia esperienza di questo aspetto importante della vita degli uomini nel loro stare insieme: il lavoro. Il quale, se regolamentato e opportunamente ridotto nei suoi tempi e ritmi, è comunque a mio parere migliore dell'ozio. L'ozio è molto vicino al vuoto e all'angoscia del nulla. A meno che non diventi otium filisoficum, che però è tutt'altra cosa, è studio; non mi pare paragonabile all'ozio vero e proprio.
Quindi, dovendo fare una scaletta: ozio peggio di lavoro; lavoro peggio di studio-ozio filosofico-arte. Ma l'arte è un privilegio, seppur pagato a caro prezzo, con la sua buona dose di sacrifici.
Quindi, dovendo fare una scaletta: ozio peggio di lavoro; lavoro peggio di studio-ozio filosofico-arte. Ma l'arte è un privilegio, seppur pagato a caro prezzo, con la sua buona dose di sacrifici.
domenica 20 gennaio 2019
Conversazione con alcuni antispecisti
Fra gli oppressi oggi rientrano a pieno titolo anche gli
animali e le piante. Il conflitto tra uomo e uomo, che sembra meno cruento
nell’Occidente benestante o limitato ad aree circoscritte del pianeta o tenuto
in qualche maniera a bassa intensità, si è spostato col suo enorme potenziale
tecnico sulla natura, gravemente e pericolosamente depauperata. Sono
drammatici, per esempio, i numeri relativi alla riduzione della biodiversità o
alle macellazioni di animali d’allevamento, la cui alimentazione richiede
taglio di foreste ed enorme quantità d’acqua, con pesanti conseguenze sulla
vita vegetale, animale e umana.
Roberta:
E’ da poco trascorso il Natale, festa religiosa trasformata in festa dei grandi
consumi. In rapporto all’equilibrio delle forme viventi e delle risorse sul
pianeta, quali consumi secondo voi dovremmo soprattutto contenere?
Ornella: E' il consumismo in sé, pratica promossa dal
capitalismo e dal neoliberismo, che dovremmo abbattere, Natale o meno.
Gigia: E il natale ne è l'apoteosi... ma direi soprattutto
consumi alimentari, visto che periodi come questo sono caratterizzati dalle
grandi abbuffate, e i soliti ne fanno le spese...
Aldo: La domanda stessa è regressiva rispetto a quanto già
è acquisito. Ogni antispecista sa già come regolarsi individualmente, ma sa
anche che "normativizzare" e dare indicazioni a altri è praticamente
inutile.
Ale: si dovrebbe iniziare a fare il contrario di quel che
si fa di solito. Se a natale, invece di regalar oggetti, ognuno facesse un NON
regalo (si facesse dare dall'amico un oggetto inutile di cui sbarazzarsi) ci
accorgeremmo di quanta inutilità siamo circondati.
Fabio: A livello dei singoli andrebbe adottato uno
stile di vita più “parco” riducendo il più possibile le spese superflue come,
ad esempio, il cambio del telefonino ogni 6 mesi, comprare dei vestiti quando
veramente servono, convertire i regali di Natale con versamenti ad associazioni
che operano nel sociale o meglio animaliste impegnate a diffondere l’antispecismo
e la tutela degli animali salvati e da salvare. Per quanto riguarda l’aspetto
sociale più ampio, penso che il sistema non arretrerà di neanche un millimetro
sulla scia d’imporre alla popolazione elevati consumi. Forse, un amministratore
comunale “illuminato” potrebbe adottare politiche locali all’insegna del
risparmio e della riduzione degli sprechi (dal problema dei rifiuti a quello
delle sacche d’inefficienza, ecc…).
Roberta
Il movimento antispecista è intrecciato alla questione ambientale e all’emergenza
inquinamento?
Ornella: Il movimento antispecista si dovrebbe muovere, in
maniera intersezionale, per evidenziare e quindi analizzare i livelli di forza
e di oppressione che riguardano lo sfruttamento e la presa
antropocentrica sui viventi e sulla terra. E' l'antropocentrismo la causa
principale della devastazione ambientale e di messa a morte dei corpi che non
contano.
Gigia: Si può parlare di corpi e non del loro spazio
vitale?
Aldo: Se si parla di corpi è d'obbligo parlare dello spazio
vitale. Quindi, direi di sì, ma forse bisognerebbe ripensare anche la questione
ambientale secondo una prospettiva che non sia quella oggi diffusa.
Ale: Dipende da che punto di vista si guarda alla faccenda.
Se si considera l'inquinamento causato dagli allevamenti intensivi innanzitutto
un danno per l'ambiente (e non si considera principalmente la inimmaginabile
sofferenza animale) la questione ambientale e l'inquinamento hanno poco o nulla
a che fare con il movimento antispecista. Viceversa, se si considera la
tragedia che gli animali subiscono nella distruzione degli habitat, il tema è
centrale anche per l'antispecismo.
Fabio:
Purtroppo no e a mio avviso lo dovrebbe essere
con molta forza e determinazione. Sembra che il movimento antispecismo in
generale non colga lo stretto collegamento tra presenza (numerica e
tecnologica) dell’essere umano sul pianeta terra, insieme agli altri viventi.
Vuol dire cercare di mettere la nostra specie al nostro posto calcolando la
capacità portante e osservando la nostra impronta ecologica, per determinare e
decidere quali e quanti spazi utilizzare per la nostra specie e rimettere in
discussione la riproduzione della nostra società con tutto ciò che essa
comporta. Pur essendo antispecisti, alcuni, non colgono il loro stesso
atteggiamento antropocentrico (frutto di millenni di educazione e insito nel
nostro DNA); non si rendono ancora conto che una società pacificata ed in
armonia con gli altri viventi, può realizzarsi solo attraverso pesanti
trasformazioni sociali e, parallelamente, attraverso un rivolgimento interiore
che gran parte di noi ancora non vogliono accettare.
mercoledì 12 dicembre 2018
Esempi di cammino sociale e turismo sostenibile
Intervista a Maria
Luisa Guidi
Secondo il saggio
sull'età del turismo di Marco d'Eramo Il selfie del mondo (Feltrinelli,
Milano 2017) il turismo è la prima industria del pianeta nel secolo che stiamo
vivendo. E' un'industria pesante che muove i capitali e le masse, produce
ricchezza ma anche consumo di suolo e inquinamento.
Il cammino sociale
o social walking può offrire un'alternativa a forme di turismo più distruttive.
A questo proposito ho intervistato Maria Luisa Guidi, membro di Repubblica
nomade e di altre associazioni, che ha attraversato a piedi anche vasti
territori, lanciando in varie occasioni un messaggio ecologista, sociale e
politico.
R Ciao, Maria
Luisa, a inizio estate hai fatto un lungo percorso a piedi con un gruppo di
camminatori: dalla Puglia alla Bosnia attraverso la Grecìa salentina e la
Grecia. Da dove siete partiti esattamente e dove siete arrivati?
M Sono partita con la mia cara amica di Genova Laura Cignoli il 24 maggio 2018 con un treno notturno che da Milano Centrale ci ha depositato a Bari Centrale dove abbiamo incontrato un altro amico, Alberto Papi di Livorno. Ci siamo così incamminati sulla “Via Francigena del Sud” con l’obiettivo di arrivare a Lecce il 1° giugno per incontrare i compagni di Repubblica nomade, circa cinquanta persone, con i quali ci siamo recati, in treno, a Melpignano che è uno dei 9 comuni raggruppati nella Grecìa salentina, ossia il territorio nel quale si parla un dialetto denominato griko direttamente derivato dalla lingua greca ma scritto in caratteri latini. Abbiamo camminato per questo territorio visitando paesi e monumenti molto belli ed entrando in contatto con le realtà locali; me ne vengono in mente due: il Festival dell’inutile al Castello di Corigliano d’Otranto e la Chiesa di Santo Stefano a Soleto. Abbiamo poi raggiunto a piedi la stupenda Lecce e da lì siamo andati in treno a Brindisi, dove alla sera del 4 giugno ci siamo imbarcati per il porto greco di Igoumenitsa, da dove abbiamo raggiunto Delphi, luogo d'inizio della parte greca del cammino. Qui, per per prima cosa, ci siamo recati all’impressionante sito archeologico, dove abbiamo interrogato l’oracolo ponendo questa domanda: che fine farà l’Europa? Da lì abbiamo camminato sino ad Atene passando in luoghi storici molto importanti, per esempio Tebe e Eleufesina. Il percorso è stato bellissimo, molto agreste e punteggiato da piccoli centri. Non è stato facile il contatto con le realtà locali soprattutto per le difficoltà linguistiche. Nei paesi agricoli più remoti gli abitanti erano soprattutto persone anziane, mentre una cosa che ho notato è stato il fatto che abbiamo incontrato diverse persone che parlavano l’italiano perché avevano fatto l’università in Italia (mi vengono in mente gli incontri con una farmacista, un veterinario e un medico). Siamo poi rimasti quattro giorni ad Atene, dove siamo stati ospitati in una chiesa armena in cui si dava asilo anche a dei rifugiati siriani. Quotidianamente abbiamo camminato attraverso la città recandoci in tre realtà nate e funzionanti a causa della crisi: l’hotel occupato City Plaza Atene, un ristorante solidale nei pressi dell’Università di Atene e l’ambulatorio sociale e solidale di Elleniko.
R All’arrivo in Bosnia che
ricorrenza veniva celebrata?
mercoledì 28 novembre 2018
Una scrittrice ingiustamente dimenticata: Livia De Stefani
Caduta nel dimenticatoio per più di cinquant'anni, autrice di un racconto sperimentale fra i più riusciti del dopoguerra, Viaggio di una sconosciuta, mai ristampato fra il 1963 e il 2018, viene finalmente riscoperta dalle edizioni Cliquot con una raccolta di racconti e poesie che prende il nome appunto dal testo sunnominato (Roma 2018).
Scrive Giulia Caminito nell’introduzione che Livia De Stefani ha una scrittura “articolata e sperimentale” e “una capacità di usare la lingua e le immagini che ogni nuovo autore contemporaneo dovrebbe avere”.
Si tratta di un'autrice che ha il gusto di sperimentare e non lo fa astrattamente o freddamente come altri autori degli anni Sessanta bensì mettendosi in relazione empatica coi drammi umani, adeguando l'espressività o la duttilità della sintassi ai sentimenti forti di angoscia, disperazione, frustrazione, impotenza. Il viaggio della sconosciuta è una camminata per Roma di una diciottenne sedotta e abbandonata, che porta in una valigia per chilometri sotto il sole d'agosto, indebolita e mezzo dissanguata dal parto fatto in casa da sola di nascosto, il corpicino del bimbo che ha messo al mondo come "le pecore, le cavalle" e soffocato sul nascere. Al bimbo concepito con un bellimbusto arrogante che l'ha ingannata, offesa e umiliata fintanto che è rimasto con lei, si rivolge ancora dolcemente, fantasticando come avrebbe potuto essere. Riuscirà a liberarsi del peso della fatica e della colpa solo quando giungerà al fiume e s'inabisserà col suo piccino, "per non lasciarlo solo, in quel buio". Fino a quel momento non mancano spaventi, rimorsi, brutti ricordi di violenze subite quasi da tutte le persone che la circondano, compreso il molestatore che la segue sperando di trarne qualche vantaggio sessuale, intuito il suo stato di grave difficoltà. Poiché questi s'accorge che la ragazza non vuole mollare la valigia, l'accompagna e ricatta fino a che non riesce a ottenere un rapporto sessuale da lei che pure aveva cercato di allontanarlo in ogni modo.
Nella narrazione si alternano a stretto giro di frase la prima e la terza persona, in uno scambio serrato che mette a fuoco ora l'interiorità alterata e confusa della protagonista ora il paesaggio urbano deserto sotto un sole schiacciante, le comparse dei passanti che non capiscono la situazione, i flashback sul mondo contadino di provenienza, sulla pesantezza del lavoro a servizio di una famiglia agiata e sulla storia d'amore col seduttore prepotente. I tempi verbali cambiano in maniera poco realistica e talvolta passato e presente sembrano fusi insieme. La situazione della ragazza risulta ancora più schiacciata in un destino senza via uscita.
Lo stile è talmente vicino a noi che mi ha ricordato Schooling di Heather McGowan (traduzione italiana nell'edizione Nutrimenti, Roma 2007), una giovane scrittrice sperimentale. Lì il flusso di coscienza interrotto dall'osservazione dei dettagli del mondo esterno in terza persona mostra brillantemente la lezione joyciana.
venerdì 23 novembre 2018
Una poesia di Antonella Doria
Millant'anni di corruzione...
Da Metro Polis
Correva l'età dell'oro...
Correvano duchi cavalieri valvassini
e paolotti
Correva ciclone complicità
compiacenze connessioni
(palla al centro) la Città
moda modale tuttadabere
di questo grande pappamondo
la Città
illuminata maggioranza
silenziosa paludosa...
Imbuti d'oro mani
marmellata appiccicata
d'unguenti invischiata
infetta
balsami blasfèmi
fetòre
esala il pentolame
malaffare
Da Millantanni, edizioni del Verri, Milano 2015
Da Metro Polis
Correva l'età dell'oro...
Correvano duchi cavalieri valvassini
e paolotti
Correva ciclone complicità
compiacenze connessioni
(palla al centro) la Città
moda modale tuttadabere
di questo grande pappamondo
la Città
illuminata maggioranza
silenziosa paludosa...
Imbuti d'oro mani
marmellata appiccicata
d'unguenti invischiata
infetta
balsami blasfèmi
fetòre
esala il pentolame
malaffare
Da Millantanni, edizioni del Verri, Milano 2015
martedì 9 ottobre 2018
Intervista a Viola Lo Moro della libreria Tuba di Roma
Viola è una delle organizzatrici di Inquiete, festival di
scrittrici a Roma, al suo secondo anno.
In
una giornata ventosa, mutevole, che si addice al titolo di questo festival di
scritture, venerdì 5 ottobre 2018, domando a Viola…
-
Perché Inquiete?
-
L’inquietudine è la condizione
generatrice sia della scrittura sia della lettura. E’ un momento generatore di
possibilità. Il termine ‘inquiete’ fa riferimento all’irrequietezza ma contiene
in sé anche la quiete. Si può leggere pure così: in-quiete. La quiete non è al
di fuori del discorso. E’ uno degli esiti possibili.
-
Mi pare che abbiate cercato di
mantenere, come l’anno scorso, una certa attenzione alla varietà degli editori,
grandi, medi e piccoli. Accanto a Mondadori ed Einaudi compaiono anche Chiarelettere,
definito medio, o Jacobelli, piccolo.
-
C’è molta Einaudi, ce ne siamo accorte
strada facendo… Sì, comunque abbiamo cercato di considerare anche i medi e i
piccoli. La questione dei medi editori è che spesso sono assorbiti dai grandi e
fanno parte pure loro di grandi gruppi. In ogni caso abbiamo cercato di
compensare la preponderanza dei medio-grandi con tre sezioni dedicate alle
esordienti. La scelta e la preparazione dei momenti incentrati sugli esordi è
avvenuta grazie alla collaborazione fra SIL (Società Italiana delle Letterate)
e la libreria Tuba.
Iscriviti a:
Post (Atom)