Ezio Sinigaglia è un altro autore che ha patito un'esclusione: il suo corposo esordio nel 1985 da un piccolo editore milanese, Il pantarèi, romanzo-saggio ricco di spunti e riflessioni che ruotano intorno alle grandi innovazioni stilistiche del Novecento, non ebbe nessuna eco in un panorama culturale che si stava decisamente ricompattando intorno a forme narrative ottocentesche: un postmoderno definito da Sinigaglia stesso un ritorno al premoderno.
Salardi: All’inizio si pone una questione di metodo. “Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce. Era inesplicabile a lui stesso. Eppure era il progetto più forte e preciso che avesse mai formulato in vita sua.”: così l’incipit di Eclissi (Nutrimenti, Roma 2016, pag 7). Allo stesso modo si potrebbe ipotizzare che Il pantarèi (ora riproposto da TerraRossa edizioni, Bari 2019, a quasi trentacinque anni dalla prima edizione – SPS-Sapiens, Milano 1985) punti all’oscurità, alla complessità tipiche dei maggiori romanzi del Novecento, per cogliervi un’indicazione su come proseguire il lavoro in questo che diviene un genere completamente diverso nel secolo che ci precede: a pag 65 del Pantarèi si osserva che il romanzo era sempre stato nei secoli “il genere letterario ‘leggero’, nel quale tradizionalmente i valori del mythos (i fatti, l’azione, l’avventura, le fortune, le catastrofi) prevalgono su quelli dell’ethos (la sfera morale dell’uomo, e dunque il pensiero, il cuore, l’intelletto). Le innovazioni tecniche di cui si è parlato sono tali da ribaltare completamente questo rapporto: nei romanzi del ’900 i fatti sono generalmente ben poca cosa, ciò che conta è il libero serpeggiare della coscienza intorno ad essi. Il romanzo viene ad assumere quasi un aspetto ‘saggistico’ che gli era prima completamente estraneo. Diviene, insomma, un nuovo genere letterario”. L’excursus saggistico sulla prosa più innovativa del secolo breve mira a ricavare un orientamento addentrandosi nell’analisi e talora nel calco degli stili più densi e ricchi che ci siano stati lasciati in eredità. Si fa tesoro qui della scoperta proustiana (o freudiana o sveviana) secondo la quale è inutile affrontare direttamente il vero poiché ci sfugge, viene rimosso e misconosciuto. Occorre aspettare che la memoria involontaria ci venga in aiuto, aspettare l’attimo rivelatore. Allontanarsi dalle abitudini, dai doveri, dalle frequentazioni quotidiane per permettere che emergano verità profonde su noi stessi altrimenti offuscate, nascoste dalle urgenze e dai condizionamenti che inghiottono la nostra vita togliendole senso, per quanto riguarda il personaggio di Akron nell’Eclissi; allontanarsi dalle convenzioni e immergersi negli stili che hanno senso per noi, aspettando che la propria voce emerga, pungolata dalle emozioni e dagli accadimenti, per quanto riguarda l’aspirante scrittore…
Salardi: All’inizio si pone una questione di metodo. “Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce. Era inesplicabile a lui stesso. Eppure era il progetto più forte e preciso che avesse mai formulato in vita sua.”: così l’incipit di Eclissi (Nutrimenti, Roma 2016, pag 7). Allo stesso modo si potrebbe ipotizzare che Il pantarèi (ora riproposto da TerraRossa edizioni, Bari 2019, a quasi trentacinque anni dalla prima edizione – SPS-Sapiens, Milano 1985) punti all’oscurità, alla complessità tipiche dei maggiori romanzi del Novecento, per cogliervi un’indicazione su come proseguire il lavoro in questo che diviene un genere completamente diverso nel secolo che ci precede: a pag 65 del Pantarèi si osserva che il romanzo era sempre stato nei secoli “il genere letterario ‘leggero’, nel quale tradizionalmente i valori del mythos (i fatti, l’azione, l’avventura, le fortune, le catastrofi) prevalgono su quelli dell’ethos (la sfera morale dell’uomo, e dunque il pensiero, il cuore, l’intelletto). Le innovazioni tecniche di cui si è parlato sono tali da ribaltare completamente questo rapporto: nei romanzi del ’900 i fatti sono generalmente ben poca cosa, ciò che conta è il libero serpeggiare della coscienza intorno ad essi. Il romanzo viene ad assumere quasi un aspetto ‘saggistico’ che gli era prima completamente estraneo. Diviene, insomma, un nuovo genere letterario”. L’excursus saggistico sulla prosa più innovativa del secolo breve mira a ricavare un orientamento addentrandosi nell’analisi e talora nel calco degli stili più densi e ricchi che ci siano stati lasciati in eredità. Si fa tesoro qui della scoperta proustiana (o freudiana o sveviana) secondo la quale è inutile affrontare direttamente il vero poiché ci sfugge, viene rimosso e misconosciuto. Occorre aspettare che la memoria involontaria ci venga in aiuto, aspettare l’attimo rivelatore. Allontanarsi dalle abitudini, dai doveri, dalle frequentazioni quotidiane per permettere che emergano verità profonde su noi stessi altrimenti offuscate, nascoste dalle urgenze e dai condizionamenti che inghiottono la nostra vita togliendole senso, per quanto riguarda il personaggio di Akron nell’Eclissi; allontanarsi dalle convenzioni e immergersi negli stili che hanno senso per noi, aspettando che la propria voce emerga, pungolata dalle emozioni e dagli accadimenti, per quanto riguarda l’aspirante scrittore…
Sinigaglia: Non
è certo arbitrario questo parallelo metodologico o, se vogliamo, progettuale
fra i miei due soli romanzi finora pubblicati. In più di un’occasione ho
lasciato capire che l’incipit di Eclissi,
“Il suo progetto puntava dritto all’oscurità per cogliervi una luce”, appeso
lassù in cima alla prima pagina come un esergo, è anche una dichiarazione
d’intenti, una promessa fatta al lettore più attento, o viceversa un monito
rivolto a quello più frettoloso e meno disposto all’avventura. In questo senso,
dunque, il progetto di Akron, il protagonista, coincide con il progetto
dell’autore, ed è quindi lecito ipotizzare che non si tratti di un progetto
isolato, ma che per l’autore scrivere voglia dire proprio questo: tuffarsi
nelle tenebre per sfruttare la sorprendente potenza che una flebile luce può
assumere quando è circondata dall’oscurità più totale. Perché naturalmente la
luce che noi (intendo noi poveri artigiani della scrittura, che non osiamo più
nemmeno chiamarci artisti), la luce che noi, dicevo, nella migliore delle
ipotesi, riusciamo ad accendere è una fiammella davvero minuscola, come quella
di un cerino, e dunque può essere di qualche utilità soltanto nelle tenebre assolute.
Ma non credo che questo principio, nel quale adesso – a settant’anni – mi
sembra condensarsi il segreto stesso della letteratura, mi fosse così chiaro a
ventott’anni, quando concepii il progetto del Pantarèi e mi accinsi a realizzarlo. Il mio movente di allora era
piuttosto, come ho cercato di chiarire nella Prefazione a questa seconda
edizione, l’ambizione di dimostrare che il romanzo non era affatto morto.
Certo, per realizzare un simile progetto era necessario calarsi a fondo dentro
la vicenda del romanzo del Novecento e aprirsi una strada fra i cespugli dei
suoi apparenti paradossi fino a trovare un filo di coerenza da seguire. Il che
equivale forse a dire che occorreva inabissarsi nell’oscurità fino a cogliervi
una piccola luce. Di questo però non ero consapevole a quei tempi: credo di
essermi lasciato guidare dall’istinto o, se preferisce, dalla mia passione di
lettore, che era già forte e consolidata, e dalla mia vocazione di scrittore,
che cominciava ormai a palpitarmi sottopelle. In fondo il progetto del Pantarèi è nato nella mente di un
ragazzo che, fino ad allora, aveva avuto della letteratura un’esperienza
esclusivamente passiva: una mente ingenua e avventata, anche se
provvidenzialmente armata di senso critico e ironia. Eppure questo romanzo si
colloca così armoniosamente all’inizio del mio percorso, lungo e accidentato,
di scrittore, che si direbbe un esordio studiato a posteriori.
Salardi: A pagina 98 del Pantarèi in
un momento di esaltazione il narratore protagonista leva una preghiera a padre
Joyce: “Lode a te, organismo uno e trino. Gloria al padre intelletto, al cuore
figlio e alla santa spiritualità del corpaccio nostro gaudente e dolente. Padre
Joyce che sei nei cieli, posa i tuoi occhi sofferenti su di noi, proteggi il
tuo umile servo Stern, che elevando oggi a te l’ammirato canto della sua
devozione ha guadagnato il pane suo quotidiano con il sudore benedetto della
fronte sua. Proteggilo, e tieni lontana da lui ogni tentazione, ma sopra tutte
quella rovinosa della letteratura, che Satana con le sue arti malefiche tenta
già di insinuargli nel petto. Scrolla via dal capo del tuo umile servo, o padre
James, il peccato orribile della superbia. Ricordagli che, come tu hai
stabilito, non vi sarà altro romanzo dopo di te. Amen.” Se non bastasse questa
dichiarazione di poetica, Il pantarèi si dimostra nel
complesso joyciano: molte sono le parti di flusso di coscienza, le variazioni
stilistiche di capitolo in capitolo, i giochi di parole, i termini-macedonia
sintesi di più vocaboli, la radicale opposizione al linguaggio semplificato in
auge dell’attuale industria editoriale. Nel romanzo successivo, Eclissi,
è
stata invece rintracciata da vari commentatori soprattutto l’influenza di
Proust. Verso quali Maestri si sente in particolare debitore?
Sinigaglia: I
due autori che lei cita, Joyce e Proust, costituiscono in effetti,
con Svevo, la mia personale trinità letteraria: sono cioè i tre
grandi sulle cui pagine mi sono formato come romanziere. Di
conseguenza rappresentavano anche, per me, a quel tempo, tre padri,
tre ingombranti modelli dai quali era necessario che mi allontanassi
se volevo conquistare una mia autonoma personalità di scrittore. Il
pantarèi mi ha
offerto la preziosa occasione di separarmene mentre rendevo loro
omaggio. Di separarmi da tutti loro simultaneamente, e anche da un
piccolo drappello di figure paterne di rincalzo, come Musil, Kafka e
diversi altri. Ciò detto, non posso negare che Joyce abbia nel
Pantarèi
un ruolo privilegiato, che sia una sorta di primus
inter pares. E la
buffa preghiera che Stern gli rivolge ne è la prova. La conferma
viene da questa frase rivelatrice: “Ricordagli che, come tu hai
stabilito, non vi sarà altro romanzo dopo di te.” Insomma, l’ho
dichiarato esplicitamente: la mia intenzione di dimostrare che il
romanzo non era morto, che al contrario aveva ancora un futuro, era
principalmente una sfida a Joyce. Mi sono servito di tutti i trucchi
di Joyce, di tutta la sua ironia, di tutte le sue invenzioni tecniche
e linguistiche, di tutte le sue discontinuità e i suoi cambi di
passo, in una parola di tutti i suoi multiformi, innumerevoli stili
per scrivere un romanzo che andasse contro il suo comandamento: “non
ci sarà altro romanzo dopo di me”. Era una sfida ad armi impari,
si capisce, ed era anche una dichiarazione d’amore. Ma, proprio
come il mio protagonista Stern, io rifuggo, in ogni campo, dalle
unioni monogamiche. Perciò l’amore da me portato a Joyce in quella
mia stagione non esclude affatto, e neppure ridimensiona, l’amore
per gli altri miei modelli. Il
pantarèi è tutto
un gioco a rimpiattino fra discorso esplicito sul romanzo del
Novecento e discorso nascosto, crittografato, sullo stesso tema.
Ciascuno degli otto autori trattati nel romanzo ha a sua disposizione
un capitolo in cui si parla di lui nella parte saggistica e si
celebra qualcosa di suo nella parte narrativa. La cosa è tutt’altro
che scoperta, anzi, spesso è ben celata, ma chi ha pazienza (e una
buona conoscenza degli autori in questione) se ne può sincerare.
Ora, la maggior parte degli autori compare soltanto nel suo capitolo
“di pertinenza”, Svevo e Proust affiorano invece in vari luoghi,
anche – per così dire – in casa d’altri, e per finire Joyce
mette lo zampino un po’ dappertutto. Posso aggiungere che il
progetto del Pantarèi,
che già accarezzavo da diversi anni, si fece più concreto grazie a
una memorabile rilettura dell’Ulisse,
durante una vacanza fuori stagione in Liguria, fra il settembre e
l’ottobre del 1976. Quindi: sì, è vero, nel Pantarèi
Joyce è primus inter
pares. La stessa
cosa accade, a ruoli in parte rovesciati, in Eclissi,
dove il nume tutelare è Proust (la svolta irreversibile della
narrazione è legata a un’irruzione violentissima di un ricordo
involontario nella coscienza del protagonista), ma anche Joyce e
Svevo ricevono i loro debiti omaggi, grazie all’occhieggiare
continuo, dal passato, di Trieste e del suo dialetto (che Svevo
parlava ogni giorno e che Joyce ha consacrato, facendone una delle
tessere del mosaico linguistico di Finnegans
Wake).
Salardi: La
questione della fine o della continua mutazione del romanzo, che
s’insinua dappertutto e in particolare emerge nei profili di Musil
e di Robbe-Grillet, rischia di essere scoraggiante e persino
annichilente per qualunque scrittore di oggi che non ambisca a essere
semplicemente un grafomane o un pennivendolo. Per molti anni dopo Il
pantarèi lei
stesso non ha più pubblicato. Il romanzo si può considerare ancora
un genere prolifico?
Sinigaglia: Senza
alcun dubbio Il
pantarèi nasceva
proprio dalla necessità di trovare una risposta a queste due domande
(che poi non sono che le due facce di una stessa domanda): (1) Il
romanzo è morto? (2) Ammesso che non lo sia, ha ancora senso, oggi,
scrivere romanzi? Domande che mi inquietavano perché sembravano
mettere in forse, se non addirittura in ridicolo, la mia nascente
vocazione di romanziere. Domande dunque che riguardavano in primo
luogo me stesso e il mio destino letterario. Ora, benché Il
pantarèi venisse a
rispondere, alla fine, in modo incoraggiante a tutt’e due i quesiti
(“No” al primo e “Sì” al secondo), non poteva però dare per
il momento alcuna risposta alla terza domanda che premeva dietro la
seconda: Quale
romanzo scrivere, dopo Joyce e Proust, dopo Musil e Robbe-Grillet? E,
nella mia personale prospettiva, dopo Il
pantarèi? Negli
anni immediatamente successivi alla fine della stesura del romanzo,
mentre Il pantarèi
esplorava il mondo dell’editoria italiana in cerca di una via di
pubblicazione che trovava sistematicamente sbarrata (parlo dei
primissimi anni, quando ancora sembrava sussistere qualche speranza
di farcela: 1980, 1981, 1982), pensai di rispondere a questa domanda
esasperando i tratti sperimentali che già affioravano qua e là nel
Pantarèi.
Bisognava andare oltre,
mi dicevo, anche se andare oltre non era poi così facile. Intanto,
mentre Il pantarèi
non usciva, uscivano altri romanzi importanti, come, tanto per fare
un paio di esempi cronologicamente appropriati, Il
nome della rosa o I
figli della mezzanotte,
che sembravano indicare la strada opposta: tornare a un romanzo
pre-modernista, che in seguito si sarebbe chiamato, un po’
paradossalmente, post-moderno. Ben presto mi fu chiaro che (1) gli
editori italiani vedevano il romanzo sperimentale come il fumo negli
occhi e (2) per il romanzo apertamente sperimentale la campana a
morto era davvero suonata, e non solo in Italia. Da allora mi sono
impegnato a sperimentare in modo diverso, attraversando a modo mio
vari generi antichi e moderni (la novella licenziosa, il
Bildungsroman, il romanzo-mondo, l’autofiction,
il romanzo di viaggio, il giallo, ecc.) e cercando sempre di offrirne
una rilettura ironica o “scandalosa”. Per la verità non ho mai
smesso di scrivere, ho smesso solo di pubblicare. Dirò di più: dopo
l’esperienza della mancata pubblicazione del Pantarèi,
e della sua successiva uscita, passata comunque inosservata, presso
un editore coraggioso e minuscolo (Luciano Conosciani di SPS), ho
smesso di cercare
la pubblicazione. Ho pensato che ne andasse della mia stessa
sopravvivenza.
Tornando
invece alla sua domanda sull’attuale buona salute del romanzo,
risponderei così: il romanzo, oggi, è fin troppo prolifico. E sono
fin troppo prolifici molti, moltissimi autori. Non è raro il caso di
scrittori di quaranta-quarantacinque anni che sono già al loro
quindicesimo o ventesimo romanzo. Ora, è vero che sono esistiti
autori come Balzac, Dickens o, più vicino a noi, Simenon, capaci di
scrivere decine e decine, o addirittura centinaia di romanzi quasi
tutti di grande qualità. Ma si tratta di casi rarissimi e per di
più, tolto quello di Simenon, maturati in un passato ormai
abbastanza remoto. Penso di poter dire che, in linea di massima, per
scrivere qualcosa di buono bisogna scrivere poco. Ma il vero problema
non è neppure quello della cattiva qualità media dei romanzi che
escono nel mondo. Il vero problema sta nel fatto che nemmeno i
romanzi di ottima qualità, che pure ancora esistono, nemmeno quelli
più celebrati, e giustamente celebrati, sembrano andare verso un
orizzonte nuovo. Ci siamo arenati nella pre-modernità del
post-moderno come in una pescosissima palude.
Salardi: Uno
dei più pesanti attacchi alla struttura del romanzo positivista da
parte del romanzo moderno è quello al narratore onnisciente: “…
l’autore cessa di essere l’onnisciente ordinatore della materia
romanzesca, specie di divinità esterna alla materia narrata, che, in
quanto creatore, conosce le proprie creature, le loro storie
individuali, le interconnessioni fra queste storie, al di là delle
possibilità conoscitive di ogni singolo personaggio. L’autore,
ora, si cala nei suoi personaggi, perlopiù in uno solo di essi o,
per meglio dire, nella sua coscienza, e si limita a riportare, a
trascrivere, gli stimoli che la attraversano (tale tecnica viene
infatti definita ‘monologo
interiore’ o
‘flusso di
coscienza’)”
(Il pantarèi,
pag 63). Tuttavia Eclissi è
interamente scritto in terza persona, nonostante l’abbondante uso
dell’indiretto libero, e Il
pantarèi in
parte: come mai questa fedeltà alla terza persona?
Sinigaglia: Il
ricorso alla terza persona non esclude affatto il sovvertimento della
regola ottocentesca del narratore onnisciente. Un esempio mirabile di
romanzo scritto in terza persona e dove nondimeno tutto è raccontato
esclusivamente dall’interno della coscienza dei personaggi è Mrs
Dalloway di Virginia
Woolf, grandissima scrittrice che non figura nel canone del Pantarèi
soltanto perché, nella particolarissima prospettiva critica del mio
romanzo-saggio, ho inevitabilmente privilegiato il tema della
destrutturazione del genere romanzo rispetto a ogni altro (non è il
caso di affrontare qui il problema di come è costruito il canone del
Pantarèi;
tuttavia posso almeno sottolineare che non risponde soltanto al
criterio delle preferenze personali, ma anche alla necessità di
adeguarsi alla finzione narrativa: le quaranta cartelle
dattiloscritte, la scaletta della redattrice Ghiotti, l’obbligo di
attenersi alla regola ferrea “Poche nozioni, ma chiare” – p. 27
– e così via). Mrs
Dalloway non è il
solo esempio di questo tipo nella produzione di Woolf. Tutt’altro.
Lo scelgo perché le sue modalità di scrittura sono facilmente
descrivibili e l’effetto di novità (il romanzo, uscito nel 1925, è
di soli tre anni posteriore all’Ulisse
di Joyce) macroscopico. Qui abbiamo una voce narrante che dobbiamo
per forza definire “esterna”, visto che non appartiene a nessuno
dei personaggi del romanzo. Ma il suo modo di essere “esterna” è
davvero curioso. Basta gettare gli occhi sulle prime due pagine del
romanzo, che cito nella traduzione italiana di Nadia Fusini (La
signora Dalloway,
Feltrinelli, Milano 1996), per farsene un’idea. All’inizio del
romanzo Clarissa Dalloway sta uscendo di casa. La prima frase che
leggiamo (“La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe
comperati lei.”) non ci dice nulla di quel che sarà di questa
terza persona, delle sue trasformazioni repentine e infinite. Ma già
dopo sette-otto righe cominciamo ad averne un assaggio: “Che gioia!
Che terrore! Sempre aveva avuto questa impressione, quando con un
leggero cigolio dei cardini, lo stesso che sentì proprio ora, a
Bourton spalancava le persiane e si tuffava nell’aria aperta.
Com’era fresca, calma, più ferma di qui, naturalmente, l’aria la
mattina presto, pareva il tocco di un’onda, il bacio di un’onda
…”. La voce narrante è entrata nella testa della protagonista e
ne sfoglia i pensieri, i ricordi, ne capta le sensazioni di gioia, di
freddo, il piacere tattile dell’aria che la tocca, che la bacia
come un’onda. Se poi voltiamo pagina e ci accontentiamo
semplicemente di leggere le prime righe della seconda, possiamo
cogliere con poco sforzo qualcosa di veramente nuovo: “Si irrigidì
appena sul marciapiede, aspettando che passasse il furgone di
Durtnall. Una donna affascinante, pensò di lei Scrope Purvis (che la
conosceva come ci si conosce tra vicini a Westminster); somigliava a
un uccello, a una gazza verde-azzurra, esile, vivace, malgrado avesse
più di cinquant’anni, e le fossero venuti tanti capelli bianchi
dopo la malattia. Se ne stava posata lì, senza neppure vederlo, in
attesa di attraversare la strada, ben diritta.” Non è meravigliosa
questa mossa che un uso nuovo della terza persona consente a Virginia
Woolf? Quelle notizie banali, eppure preziose, forse indispensabili,
che uno scrittore fornisce solitamente circa l’aspetto fisico del
suo personaggio ci vengono trasmesse, in virtù di un invisibile
gioco di prestigio, attraverso i pensieri di un altro personaggio, un
personaggio minimo, che di lì a poco uscirà di scena, ma il cui
cervello è stato visitato per un istante dal microbo della voce
narrante come per un misterioso contagio. Questo micro-organismo
continuerà a saltare di cervello in cervello per tutto il romanzo,
incarnandosi via via in una serie di personaggi dei quali il lettore
verrà a conoscere il pensiero dall’interno.
Ecco perché dico che la scelta della prima o della terza persona
diventa indifferente, una volta che si è fatta, a monte, la scelta
ben più radicale di un punto di vista interno alle coscienze. L’una
e l’altra, prima e terza persona, hanno i loro vantaggi e i loro
limiti. Lo stesso Joyce, nell’Ulisse,
non sceglie la prima persona, ma una terza instabile, mobilissima,
che tende a trasformarsi di continuo in prima: per un istante, come
accade spesso, o per un intero capitolo, come nel celebre monologo
finale di Molly Bloom. Dei romanzi di cui si parla nel Pantarèi
soltanto tre (la Recherche
proustiana – con l’importante anomalia di Un
amore di Swann –,
La coscienza di Zeno
di Italo Svevo e Morte
a credito di Céline)
presentano un Narratore in prima persona che è anche il protagonista
della storia. Perciò non c’è nulla di strano nel fatto che Il
pantarèi, sorta di
beffardo “estratto Liebig” del romanzo del Novecento, sia scritto
prevalentemente in terza persona, con frequenti scivolamenti nella
prima. L’uso della terza persona mi offriva fra l’altro il grande
vantaggio di poter mettere in scena un gioco di specchi fra me
stesso, il mio sdoppiamento in autore del romanzo, la figura di Stern
come eventuale doppio dell’autore, l’autore dei saggi come doppio
di Stern, e ancora Sax – protagonista del romanzo incompiuto di
Stern – come altro doppio di Stern lontano anni luce dal primo, e
di insinuare così nell’aria del libro un altro dei temi cruciali
del romanzo del Novecento: il problema dell’identità, sul quale
s’impernia l’intera opera di un grande autore come Max Frisch che
– pur non potendo a sua volta figurare nel canone del Pantarèi
– meritava certo di essere evocato. La prima persona l’ho usata
in un inedito che mi sta particolarmente a cuore, Sciofì,
Fifì e l’Amor,
perché lì mi era indispensabile. Eclissi
è un romanzo per il quale ho scelto una voce narrante
ingannevolmente tradizionale, che è classica nella forma e si lascia
credere onnisciente nella natura, ma che viene a tal punto intaccata
e incrinata dal multilinguismo dei personaggi (ci sono cinque lingue
diverse in quel piccolo libro) da trasformarsi nell’officina stessa
della mia sperimentazione letteraria.
Salardi: Il
protagonista di Eclissi,
nel suo breve soggiorno in un’isola sperduta del Nordeuropa, è
alla ricerca di una domanda più che di una risposta: “Quel viaggio
era il regalo che Akron aveva deciso di concedersi, con oltre sei
mesi di anticipo, per il suo settantesimo compleanno: l’ultimo vero
viaggio, si era detto, l’ultima occasione di estrarre dalla
reticenza del mondo una domanda.” (pag 8). Trovata la domanda che
gli premeva trovare, formulatala nel modo corretto, sarebbe
immediatamente scaturita la risposta. La prima che gli verrà in
mente durante il soggiorno sarà “Sono guarito?” in relazione al
lutto per la morte della moglie (pagg 10-11). L’ultima: “Ergo
l’ho ucciso?” in relazione a un’incomprensione gravida di
conseguenze fra lui e un amico morto giovanissimo (pag 106). In mezzo
ce ne stanno altre, per esempio se l’umanità abbia un senso
nell’immensità dell’universo, che talvolta pare regolata da
leggi armoniche talvolta nient’affatto, come di fronte ai ruderi di
una chiesa scoperchiata (“Non c’era una terra emersa, in quella
direzione, per migliaia di miglia, di modo che la cattedrale sembrava
interrogare l’elusiva lontananza di Dio, la sua tenace resistenza a
mostrarsi, nella sua proiezione verso il vuoto orizzonte non meno che
nel suo gotico slancio verso un cielo raramente sereno: cioè, per
così dire, lungo il deserto totale delle ascisse così come lungo il
silenzio assoluto delle ordinate.” pag 65). Molte domande affollano
la sua mente rigenerata dalla vacanza. A me pare che in tutto questo
interrogarsi a un certo punto affiori una grande risposta: “Era la
mancanza di passione, ecco, chissà perché, eppure era certissimo,
era la mancanza di passione il ventre malato che covava e partoriva
le tragedie.” (pag 61). È così?
Sinigaglia: Credo
che l’autore non debba mai fornire al lettore risposte univoche in
merito agli enigmi piccoli o grandi che si nascondono in un romanzo.
Ciò che posso fare, senza svelare nulla ma semplicemente additando
quel che il testo dichiara di per sé in modo esplicito, è riportare
qui la frase che precede immediatamente questa che lei cita. Ecco
qui: “almeno [Mrs Wilson] era una donna appassionata. Si disse che,
avesse potuto dimezzarne gli anni, l’avrebbe scambiata volentieri
con suo figlio, avesse potuto aggiungergliene venticinque l’avrebbe
scambiata volentieri con suo padre. Era la mancanza di passione ...”,
eccetera eccetera. Dunque la mancanza di passione, seme di ogni
tragedia, non è una malattia che riguardi altri e da cui Akron si
consideri immune: è al contrario una malattia di famiglia, di cui
soffriva il padre di Eugenio, Tito senior, e di cui soffre il figlio,
Tito junior. Una grave malattia che (per usare un’espressione di
moda, ormai piuttosto trita, ma in questo caso, perlomeno,
appropriata) è nel suo DNA. Questo, certamente, qualcosa deve voler
dire.
Salardi: Il
segreto sta nello sbilanciamento verso l’altro, mi pare. E nel
linguaggio dell’Eclissi troviamo
un modo per realizzare questo sbilanciamento. Dai personaggi viene
inventato il gioco di parlare la lingua dell’altro: “A nostrja
ità giuoco è iutjile come per bambini. Così io dicco: parjliamo
lingua di altrjo: lei inglesi, io italiano. È amiusante, e facciamo
exercizzio.” (pag 18). La lingua è reinventata da tutti i parlanti
con sfumature diverse: qualche parola di dialetto triestino, inglese
pronunciato da norvegesi, inglese vero e proprio, italiano
pronunciato da un’americana. Questa lingua meticcia, intarsiata,
nel suo prodursi dialogico, filtra anche nelle parti diegetiche
attraverso l’indiretto libero (pag 20): “A Roma l’eclipsi non
era totale, ma un loro fellow aveva organizzato il viaggio a Firenze
per tutto il loro piccolo gruppo. Poi, da Firenze, quella mattina
erano saliti a Fìsole. Si erano dovuti alzare prestissimo, a notte
fonda, perché era inverno, metà februarjio, e il finòmino era
atteso per le otto. Un livatacci! La parola italiana, così bella e
colorata, le era rimasta impressa per sempre nella memoria da quel
giorno: livatacci. Ma il tempo era magnifico, il cielo bliù: e poi
nero, of course, tutto affollato con stelle. Che fantastica
imozione!”. L’impressione è quella di una lingua fresca,
ringiovanita grazie alla creatività di adulti-bambini…
Sinigaglia: Be’,
in effetti l’idea di Mrs Wilson (quella di proporre ad Akron lo
scambio delle lingue materne) è stata un colpo d’ala di cui le
sono immensamente grato... È vero che già prima di questa bella
trovata del mio personaggio il multilinguismo aveva cominciato a
mettere il naso nel racconto grazie all’inglese fortemente
germanizzato degli isolani, ma è da questo preciso momento in poi
che le lingue, nel loro creativo disordine, prendono il sopravvento
su o, almeno, ingaggiano battaglia con l’ordine che, da principio,
era stato impresso alla storia dalla voce narrante. È da questo
momento, soprattutto, che un registro umoristico si insinua nel clima
della narrazione, affiancandosi al registro elegiaco che sembrava
destinato a prevalere. Lei parla di “lingua fresca”: è un
aggettivo ben scelto. Questa freschezza, che si sprigiona appunto
dall’invenzione di Mrs Wilson, invade il parlato, tracimando anche
sull’indiretto libero e più in generale sull’intero romanzo.
Ecco una conferma di una legge cui ho sempre creduto: quando si
comincia a scrivere un testo narrativo, ci si fonda su
un’idea-scaturigine che può essere più o meno brillante; ma ad
essere decisive sono le idee che nascono dopo, mentre
si scrive, le idee che germinano per così dire dal brodo di coltura
della narrazione; sono queste a modellare lo scafo della piccola
imbarcazione di cui lo scrittore è il nocchiero, a decretarne la
felice navigazione o il naufragio. In Eclissi
ci sono anche altre idee che intervengono a imprimere svolte
fortunate alla rotta, ma certo quella di Mrs Wilson rimane la più
provvidenziale.
Salardi: Il protagonista Stern del Pantarèi è un collaboratore editoriale che svolge vari tipi di lavori redazionali, fra cui, per ultimo, la stesura di un capitolo sul romanzo del Novecento per un’enciclopedia, che sostanzia buona parte di questo scritto. Il capitolo iniziale e quello finale vedono la comparsa della direttrice editoriale, del custode-Minosse del Palazzo dell’Ingegno, ovvero dell’edificio della casa editrice, sulla scena di stanze insonorizzate, di corridoi vuoti percorsi da moquette grigio topo, con riferimenti tipici alla realtà aziendale. Oltre ai grandi Maestri, di cui si deve nutrire la formazione di un bravo scrittore, Il pantarèi vanta anche una parentela (minore) con La vita agra di Luciano Bianciardi? O piuttosto, fra gli italiani, occorre citare soltanto Italo Svevo e Giuseppe Berto per Il male oscuro?
Sinigaglia: I
due autori che lei cita per ultimi (Svevo e Berto) sono stati
senz’altro, fra gli italiani, gli scrittori decisivi
nell’orientarmi, dapprima – sia ben chiaro – soltanto come
lettore, verso quel romanzo modernista la cui esistenza mi era
rimasta tenacemente celata fino ai sedici anni. Ciò non significa
che non ci siano altri connazionali contemporanei che ho letto con
avidità e ammirazione: Gadda, Calvino, Primo Levi, per citare
soltanto i maggiori. Buzzati, aggiungerei, specie nell’adolescenza.
Bianciardi, con la sua ironia dilagante e, anche, amara, non poteva
certo lasciarmi indifferente. Conservo tuttora (in una biblioteca non
vastissima, e che ha inoltre sopportato, trasloco dopo trasloco,
innumerevoli perdite) due suoi romanzi: La
vita agra e
L’integrazione,
per il quale ultimo nutro una predilezione forse sorprendente. La
satira del mondo editoriale è in entrambi riuscitissima, ma con
effetti comici particolarmente esilaranti nel secondo. Tuttavia credo
di poter dire che la prospettiva ironica con cui si guarda alla Casa
Editrice nel Pantarèi
(“Tempio della Sapienza. Fabbrica instancabile di Cultura…
Palazzo dell’Ingegno”) deriva quasi esclusivamente dalla mia
esperienza personale, che a ventott’anni, quando cominciai a
scrivere il romanzo, era già piuttosto ricca e varia.
Salardi: “Le
cose troppo nuove non si vendono” si legge a pag 27 del Pantarèi.
“Riesco a trovare un editore ogni trent’anni,” ha dichiarato
lei stesso in un’intervista. L’imminente ristampa
del Pantarèi vuole
essere anche una provocazione nei confronti dell’industria
culturale? E il periodare frammentato, con frasi nominali, che
compone il capitolo iniziale e l’epilogo dell’opera è un’ironia
sullo stile minimal-editoriale attualmente in voga?
Sinigaglia: A
posteriori, quella frase che ho messo in bocca all’immaginaria
redattrice Ghiotti (“Le cose troppo nuove non si vendono”) prende
un sapore ironicamente profetico, pensando alla sorte del Pantarèi,
un romanzo che si presentava proprio come “una cosa troppo nuova”
e che i maggiori editori italiani dell’epoca (i “templi della
sapienza”, le “fabbriche instancabili di cultura”) preferirono
rifiutare. Poi, come ho già ricordato, il romanzo fu pubblicato nel
1985 (quando cioè come manoscritto compiuto esisteva da ben cinque
anni) da una piccola casa editrice, SPS, a sua volta all’esordio, e
riuscì a raggranellare uno sparuto gruppo di lettori. La principale
ragione per cui desideravo riproporlo era appunto questa: Il
pantarèi è un
romanzo che merita senz’altro di essere letto da una cerchia di
lettori più nutrita. Inoltre, per riassumere la mia posizione in una
battuta abbastanza innocua nel suo status di luogo comune,
un’espressione che può fare il paio con “le cose troppo nuove
non si vendono”, Il
pantarèi “è un
boccone che mi è andato di traverso”: di qui la tentazione di
rimasticarlo, avviandolo sperabilmente a una migliore digestione.
Queste sono motivazioni personali, si capisce. Ma ci sono anche
ottime motivazioni letterarie. Il
pantarèi, benché
sia stato scritto circa quarant’anni fa (e pubblicato quasi sette
lustri or sono), è ancora “troppo nuovo”, esattamente com’era
allora, visto che il romanzo ha preso strade ben diverse da quelle
che là si auspicavano: assai più che andare “al di là di Joyce”,
è tornato indietro, a formule ottocentesche, per di più spessissimo
svilite da una scrittura sciatta e anonima, quasi primordiale. In un
contesto come quello odierno, il mio vecchio Pantarèi
rischia di rifulgere come una novità sensazionale. Purché sia
letto, naturalmente. All’ultima parte della sua domanda, tuttavia,
devo rispondere di no: “il periodare frammentato, con frasi
nominali”, che caratterizza il Prologo, l’Epilogo e certi brevi
inserti in tondo che si alternano al corsivo nelle pagine saggistiche
del romanzo, non è una parodia dello stile minimalista. È invece un
esempio di quello che chiamerei “monologo interiore in terza
persona”: una terza persona che inevitabilmente, in questo tipo di
tecnica, scivola spesso e volentieri nella prima (basti leggere
l’incipit del romanzo: la prima parola, “Eccoci”, sembra
suggerire una prima persona plurale; il primo verbo, “sarò”, la
prima singolare; il secondo verbo, “sospinse”, la terza). Scelsi
questo stile, se così lo posso chiamare, perché mi suonava molto
joyciano e quindi particolarmente adatto a un romanzo sul romanzo del
Novecento. Nello stesso tempo, per joyciano che fosse, quello stile,
dal punto di vista teorico, mi accorsi ben presto che riuscivo a
infondergli un sapore personale, originale, assolutamente non
imitativo. E ancora: questa forma di monologo interiore era
particolarmente congeniale al mio tipo di umorismo. Si tratta
peraltro di una scrittura che, pur nella sua essenzialità, nella
brevità delle sue frasi, non ha nulla di minimalista, perché non
rinuncia né alla ricchezza lessicale né alla sottigliezza analitica
e psicologica. A mio giudizio questa prosa potrebbe essere portata ad
esempio del fatto che, contrariamente a quanto si crede, semplicità,
in letteratura, non significa necessariamente povertà. Come, del
resto, complessità non significa necessariamente ricchezza. Nel
Pantarèi
ci sono esempi di prosa di un’estrema semplicità e altri di prosa
di un’estrema complessità, ma non credo ci siano esempi di miseria
linguistica o narrativa.
Parzialmente pubblicata su Nazione indiana il 1° febbraio 2019. Seguirà pubblicazione sulla rivista di critica letteraria Lettera zero.
Parzialmente pubblicata su Nazione indiana il 1° febbraio 2019. Seguirà pubblicazione sulla rivista di critica letteraria Lettera zero.
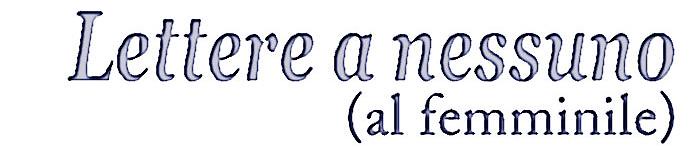
Nessun commento:
Posta un commento