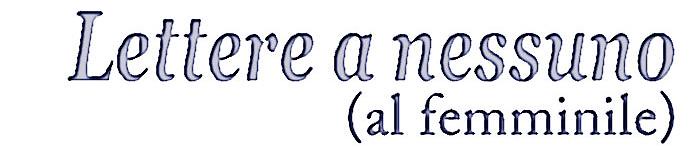Ho voluto scrivere poco, considerati anche gli inediti. Ho voluto aspettare che le idee maturassero entrando in incubazione per un certo tempo, dimostrassero di resistere agli attacchi di forze contrarie, come distrazioni o pigrizia, ed eventualmente si arricchissero di nutrimenti vari prima di venire alla luce. Questo per una legge di natura, si potrebbe facilmente affermare: solo qualcosa che possiede una discreta carica libidica, una sua energia, può riuscire a vivere. Accanto a questa motivazione ne scorgo subito un'altra abbastanza aggressiva: ho evitato di soggiacere alla coazione a produrre tipica del meccanismo industriale che ci è familiare nonché a stampare qualunque frase o pensiero passasse per il capo come se un mondo di seguaci o amici facebook fosse sempre lì ad attendere montagne di parole vuote come oro colato. Mi è piaciuto essere libera di scrivere quel che volevo quando volevo. Ho svolto un lavoro impiegatizio in un altro campo, in cui avevo l'impressione di vendere capacità meno preziose per me di quanto non fosse la scrittura. Un sacrificio c'è sempre, perché la società chiede qualcosa in cambio di quello che offre. Si è arrivati a un accomodamento fra le mie ambizioni personali e le esigenze sociali così ho venduto buona parte del mio tempo per svolgere compiti abbastanza lontani dai miei interessi ma non del tutto alieni. Avrebbe potuto anche andar peggio e qualcuno in effetti è costretto a sacrifici ben maggiori dei miei per stare al mondo. Senza allargare troppo il discorso, resta il fatto che il lavoro è conflittuale e la conflittualità del lavoro non so se a qualcuno è risparmiata.
E' giusto comunque che uno scrittore/scrittrice, un/una artista faccia esperienza di questo aspetto importante della vita degli uomini nel loro stare insieme: il lavoro. Il quale, se regolamentato e opportunamente ridotto nei suoi tempi e ritmi, è comunque a mio parere migliore dell'ozio. L'ozio è molto vicino al vuoto e all'angoscia del nulla. A meno che non diventi otium filisoficum, che però è tutt'altra cosa, è studio; non mi pare paragonabile all'ozio vero e proprio.
Quindi, dovendo fare una scaletta: ozio peggio di lavoro; lavoro peggio di studio-ozio filosofico-arte. Ma l'arte è un privilegio, seppur pagato a caro prezzo, con la sua buona dose di sacrifici.
Quindi, dovendo fare una scaletta: ozio peggio di lavoro; lavoro peggio di studio-ozio filosofico-arte. Ma l'arte è un privilegio, seppur pagato a caro prezzo, con la sua buona dose di sacrifici.