Intervista
a Mariano Bargellini
- So che stai lavorando a un nuovo romanzo. Vuoi dire qualcosa
su questo testo che definisci puzzle game?
- L’oggetto
infinito è un romanzo puzzle game.
In senso metaforico e letterale. Anche alla lettera, in quanto che il
fabulatore e personaggio della storia, a seguito di un escamotage si direbbe
onirico, e dell’annuncio recatogli da Antony Charon, lo scimpanzé sapiente
della televisione, il teledivo dell’aperitivo, quasi stesse sognando cade nella
trappola di un puzzle game, di cui
ignora le regole i meccanismi le leggi. Si trova di colpo, forse prigioniero,
in una casa del Sonno e del Silenzio, che lui riconosce: è la casa-labirinto
della fanciullezza, arredata come allora e con vestigia recenti degli antichi
inquilini, ma deserta e semibuia. L’intero palazzo, oggi assediato da una
nebbia fittissima, parrebbe disabitato. E la città stessa, deserta: una
Milano-fantasma. Egli s’aggira, ombra di sogno, anzi persona di puntini
elettronici, ente digitale, avatar del giocatore sconosciuto alla console per
corridoi e stanze di un Labirinto senza uscita, e senza Minotauro. Salvo che il
Minotauro, cioè l’avversario computerizzato di questo videogioco, non sia lo
scimpanzé parlante, il testimonial dell’aperitivo: Toni Caronte, il suo
contubernale di reclusorio-incantesimo. Il quale, sorta di Frégoli, cambia
d’abito e di ruolo per tre volte. Di teologo e in veste talare, per esempio, si
cambia in predicatore della rivoluzione neofuturista, vestito alla futurBalla.
Oltre a questi due personaggi, e ai loro dialoghi subito declamati e voltatisi
in controversia, dialoghi da teatro della sorpresa del grottesco e dell’assurdo,
risuona talvolta nel teatro vuoto e quasi buio la voce del giocatore e
fabulatore invisibile seduto alla console. Continui i colpi di scena. L’ultimo,
a suo modo risolutivo, conclude brutalmente L’oggetto infinito, romanzo
labirintico neo-novecentista.
-
Converrà prendere le mosse dalla recensione di Giuliano Gramigna a Mus
utopicus (I. M. Gallino editore, Milano 1999) sul Corriere della sera del
13 gennaio 2000: “Racconti fantastici, fabulosi, anticipatori? Per fortuna
qualcosa di meglio, e di più peculiare. Bargellini gestisce con outrance il
suo manierismo, ostentandolo anziché schermarlo, rifiutandosi di ammettere che
una narrazione (almeno la sua narrazione!) sia qualcosa d’altro che una cosa
scritta. Ne è un esempio il testo che battezza il volume [ … ]:
linguisticamente mescolanza di forme fintonobili, gerghi tecnici, latinismi, macheronea di italiano e milanese, costruttivamente,
una sintassi vuoi tacitiana, vuoi ingrovigliata. La beffa convive continuamente
con severe, astruse combinazioni di lessico: metafore barocche, come le
palpebre bianche «mascherina di cartapecora del sonno», costeggiano il
lombardismo «stremiti»; e i piccioni morituri sono «morfemi di Thànatos». Il
lettore piluccherà a suo piacimento e divertimento. Ma non si tratta di pura
esibizione di virtuosismo. Il racconto più lungo, e impegnativo, «Falconeria da
camera», mette in folle non solo la lingua ma le regole narrative, anzi,
dell’esistere, con l’omonimia proditoria di narratore e personaggio, e con il
piccione ominoso, forse compagno degli uccelli del presidente Schreber (vedi
Freud) o messaggero d’Averno o del quiz televisivo… Mi trattengo dal fare nomi
di patroni eccellenti per Bargellini: Gadda, Landolfi, magari Dossi. Questo non
è il libro di un ingegnoso adepto – di cui si sa ben poco: nato a Torino,
vivente a Milano, decorato ora del Bagutta-Opera prima. Non è demandata al
recensore la funzione d’astrologo: ma scommetterei di buon grado sul futuro di
narratore di Bargellini.”
E
dopo? Dopo Giuliano Gramigna? Il silenzio. Il silenzio dei favoreggiatori degli scrittori-senza. La loro
distrazione dolosa riguardo a Bargellini. E i boicottaggi (sì, anche i
boicottaggi!) mondano-mafiosi del Luna-Park della Vanità e dei suoi teatri
d’automi, avversatori velenosi (e truffaldini) del Barigildo. Ma ha che fare,
tutto questo, con la letteratura? No, certo. Allora non parliamone.
- Una delle caratteristiche salienti
del tuo stile è l'associazione fra tematiche ultramoderne (per esempio la
realtà virtuale) e un linguaggio molto elaborato, talvolta arcaicizzante e
barocco. Come mai questa associazione, che può suonare stridente?
- La felice contradizione è nata per caso. Il forgiarsi della
mia prosa si completa negli anni Settanta. Operette morali è il lontano
ma ben presente modello. E si tira dietro i modelli secenteschi a cui guardava
Leopardi: Daniello Bartoli, il Magalotti, il Ségneri… Del resto, il racconto
fantastico italiano parte di là, da Operette morali. Si legga quel che
dice Cortellessa nella raccolta di saggi sul Leopardi delle Operette morali (Le Operette morali e il Novecento italiano, Bulzoni, Roma 2000). Io
ho schifato, d’istinto e criticamente, la lingua slombata della comunicazione;
e ho scelto “la nostra ricca favella” (Landolfi). Trent’anni più tardi mi ha
attraversato l’immaginazione questa metafora e allegoria, di estrema attualità,
e gnostica: il computer game. L’uso della lingua letteraria, e ad alta densità
retorica, fa che preponderi, forse, il lato metafisico e gnostico nei miei due
romanzi puzzle game.
-
Recentemente hai scritto due romanzi, ancora inediti, incentrati intorno a due
giochi elettronici, Giocare a mangiarsi e L'oggetto infinito. Che cosa ti ha
affascinato di quelle situazioni? Ci sono degli elementi comuni? Quali invece
le differenze?
- I rimandi alla realtà nuova, detta “virtuale”, e d’altra
parte il lancio vertiginoso oltre le frontiere della modernità, indietro nei
secoli, fino alla Gnosi: ecco, suppongo, la causa principale della
fascinazione; e dell’avere scritto Giocare a mangiarsi, all’inizio del
Duemila, e poi L’oggetto infinito. Nel primo romanzo l’Io narrante, il
fabulatore, è alle prese con un computer game che, subdolamente, straripa fuori
dallo schermo. Nel secondo la situazione si estremizza: il
personaggio-narratore, ente digitale, un quidam fatto di pura informazione, un
Perelà di puntini elettronici, s’aggira perso in un puzzle game, caduto in non
si sa che trappola.
-
Che cosa pensi del postmoderno?
- Il romanzo postmoderno è un gioco di società. Scrivere un
romanzo è sì un gioco, un gioco aleatorio, ma: lusus serius, iocus severus.
-
Il tuo grande nemico è il mercato editoriale?
- Una grande casa editrice, nell’anno 1979, commissionò alla
Doxa una ricerca di mercato fra le lettrici di novellistica rosa della fascia
medio-bassa. Io ho avuto la fortuna di leggerla. Quella ormai lontana ricerca,
si sappia, contiene una sorta di precettistica del romanzo da supermarket
impostosi in questi anni. (O meglio: imposto quasi per legge.) Il
precetto-base, ricavato dal sondaggio, è il seguente: abolire lo stile.
Infatti, dalle interpellate, si considera lo stile ‘un diaframma’ (naturalmente
insopportabile) che si frappone al godimento di una storia. Oggi non si sente
dire, da gente del mestiere, che lo stile viene spalmato, da certi autori malati d’estetismo, sulla storia? Hanno
esultato i (ri)cantastorie, storielle e storiacce. Ma se le cose stanno così, è
d’obbligo essere nemici del mercato editoriale.
- Ti ho
sentito diverse volte citare la frase di Proust riferita al testo letterario in
quanto scritto apparentemente in una lingua
straniera.
- Les beaux
livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Questa sentenza di Proust, è singolare
e meraviglioso, la incontriamo anche nello Zibaldone, e fu espressa
anche da Kafka. Kafka dice che lui, quando parla, usa la lingua materna, quando
scrive, una lingua straniera. Eppure è sempre il tedesco! Leopardi, nell’investigare
la lingua di Daniello Bartoli, giunge a questa conclusione: le sue parole,
tutte, appartengono al tesoro della lingua italiana, e sono note a un filologo.
Ciò nondimeno, abbiamo l’impressione di leggere una lingua straniera, ma
conosciuta perfettamente da noi, benché non sapremmo scriverla, noi; e che
sembra la nostra: è l’italiano di Bartoli. Deleuze, a proposito della frase di
Proust, afferma che l’unicità di uno stile e quel suo non sai che di straniero,
di non udito prima d’ora, è la sua sintassi, non già l’elocuzione; di Proust,
per esempio.
-
Ti ho sentito anche citare spesso il Nouveau roman, in particolare
Robbe-Grillet sia come romanziere sia come teorico della letteratura. Che cosa
ha da insegnarci secondo te?
- Il procedere labirintico della fabula, rotatorio come
l’orbita di un pianeta. Non più lineare, ma circonvoluto, labirintico, appunto.
È stato detto da qualcuno che tale è la caratteristica del romanzo schiettamente novecentesco: procede, la
sua fabula, quasi a spirale. Con degli avvolgimenti e dei ritorni da labirinto.
Così i romanzi di Robbe-Grillet.
-
E Kafka per la dimensione fantastica…
- Le storie di Kafka, α) divergono all’infinito, non si
chiudono in un significato univoco, letterale; β) si ritraggono dal piano della
realtà e subiscono un processo di volatilizatio, diventano mentali; γ) il
personaggio, spesso, emerge da un passato nebuloso, quasi non ha un passato
anzi, ed è gettato subito in un mondo sconosciuto eppure familiare. Il
paradigma, sia dei suoi personaggi sia delle sue storie, è il sogno. Una
indicazione da seguire, o di cui tenere conto, certo. Purché, dall’inventore di
storie fantastiche, non ci si fermi alle suggestioni kafkiane…
- Ci sono altri scrittori che consideri
tuoi maestri? Perché?
- Leopardi, d’Annunzio, Pirandello, Landolfi, e, con alcune
riserve, Manganelli. Di altre letterature: Kafka, Beckett, e Robbe-Grillet.
Tale scelta minima (parecchi scrittori dell’Ottocento e del Novecento dovrei
aggiungere all’elenco striminzito) riguarda, è ovvio, me scrittore, non me
lettore. Le ragioni? Per ciascuno di loro ne dovrei addurre di particolari.
Discorso troppo lungo. Ma ti risponderò ugualmente, in breve. Però, scusami,
solo in parte. Manganelli: perché è il paradossologo numero uno della narrativa
italiana. Ammirevole il suo romanzo postumo: La palude definitiva.
Pirandello: perché ogni sua storia mi pare l’esemplificazione di un’idea,
sempre spiazzante, paradossale, o meglio la sua ipostasi dal mondo iperuranio
al nostro mondo sublunare; e per la teatralità senechiana (?!), quasi da Lettere
a Lucilio, della sua prosa franta. D’Annunzio: un brindisi al musico e
antiquario della prosa italiana moderna. Il suo romanzo Forse che sì forse
che no (1910), attraversato da una ventata futurista, rimane una delle
punte più avanzate del romanzo sperimentale italiano del Novecento. Qualche "intendente di letteratura" se ne sarà reso conto?
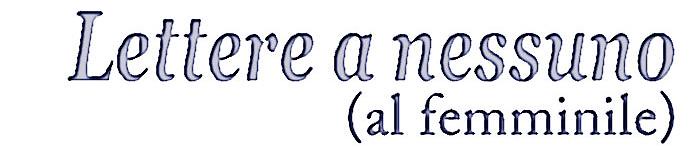
Nessun commento:
Posta un commento