A tre
anni dalla morte dell'autore, i romanzi di Luigi Di Ruscio approdano finalmente
a un editore importante, Feltrinelli, che raccoglie in un'unica edizione i
maggiori testi in prosa, Di Ruscio.
Romanzi (Milano 2014).
Fin dal
titolo, Neve nera (ancora più
esplicito nella prima edizione, Ediesse 2010: La neve nera di Oslo), il
terzo romanzo contenuto nel volume si
presenta come il libro in prosa che maggiormente dovrebbe essere incentrato sul
tema del lavoro in fabbrica, luogo dove lo scrittore effettivamente fu occupato
per trentasette anni dopo l'emigrazione in Norvegia. Lo è ma con scatti e
puntualizzazioni anche ribelli, di chi capisce di non poter essere incasellato
o inumato in una posizione troppo circoscritta, com'era già avvenuto in passato
per le poesie neorealiste: "Catalogato come ero tra i poeti operai però
sono anche bipede, sono anche cerebrale avendo anche un cervello, sono
planetario abitando un pianeta galattico, abitando in una galassia e sono
l'operaio più circondato da barattoli Cirio di tutta la storia della
rivoluzione industriale del mondo intero." (p 400)
Così
come non può essere definito romanziere nel senso più canonicamente narrativo o
soltanto poeta-operaio o soltanto poeta, Di Ruscio con la consueta onestà e
lucidità rifiuta e aggira il giudizio tipicamente borghese che ti definisce per
il lavoro o professione svolti, che ti inchioda, qualunque cosa tu faccia, al
tuo destino sociale. Sottolinea più volte che egli è anche e soprattutto un
essere umano, un abitante del pianeta, con tutta l'enormità e complessità che
la cosa comporta. Come in quell'osservazione che si trova in Cristi polverizzati, ripetuta in seguito
con lievi varianti dell'universo che guarda se stesso: "Questo universo
neppure sapeva di esserci, c'era solo un grande spasimo, alla fine fu creato
l'occhio umano e dopo tanti spasimi finalmente l'universo si è visto e lo
spettacolo non è stato lieto, un universo spaventoso che non sapeva di esserci,
un universo spaventoso che sovrasta la nostra capacità di sopportarlo." (p
374). Un orrore che è naturale e sociale insieme. Tuttavia in Neve nera si legge: "Oltre
all'orrore di essere caduto nella trappola sociale c'è anche la gioia di essere
al mondo, c'è anche la gioia di poter affrontare la belva con armi
esclusivamente immaginarie, guardo fuori un sole luminosissimo sulla neve
fresca, quindici gradi sotto zero un chiarore immenso, non sperare in vita
eterna è già tanto che certi scemi sono riusciti a nascere…" (pp 411-412).
In alcuni punti affiora la gioia di chi non ha mai posseduto alcun potere
quindi è veramente libero: "… la totale mancanza di potere crea in me uno
stato di irresponsabilità e leggerezza quando liberamente cammino per le
strade, quando vado in bicicletta nessuno mi ammazza e dall'altra parte le
ville corazzate, circondati dai cani feroci, custoditi dalle guardie come
fossero una cassaforte viaggiante, non è strano che siano soggetti ad alto
consumo della cocaina, la mia cocaina è essere lontano da loro, sfuggirgli,
costruire i regni dove loro non esistono e la mancanza totale di potere che
rende possibile questi pensierini gentili, il non dover rendere conto a nessuno
di quello che scrivo, l'essere sottoposti a tutti i poteri invece ci
imbestialisce…" (pp 413- 414). Perfino i cattolici, lontani, qui in
Norvegia, dal luogo del potere secolare della Chiesa, paiono miti e simpatici,
tanto da guadagnarsi il nome di "gattolici".
Pur
nella contemplazione della natura e degli straordinari tramonti dei paesaggi
nordici, non viene dimenticata la lettura razionale, scientifica, della
situazione: non è il sole che tramonta, siamo noi che tramontiamo. La
precisazione astronomica offre l'occasione per ricordare Giordano Bruno, una
delle figure intellettuali di riferimento. Come il pensatore martire preilluminista,
anticipatore del pensiero moderno perseguitato dalla Chiesa, pure Di Ruscio
testimonia nei suoi scritti di essere stato emarginato e costretto
all'emigrazione da una società contadina arretrata, ancora feudale e dominata
dal potere pure temporale della Chiesa: "Comunista e disoccupato quando
per trovare lavoro in fabbrica occorreva lettera di presentazione
dell'arcivescovo e principe agrario…" (p 441); "Se i democristiani mi
avessero dato anche un posto da scopino sarei rimasto in Italia, sarei rimasto
anche se con una raccomandazione dell'arcivescovo di Fermo mi avessero assunto
in una fabbrica italiana. Cose tutte impossibili per un comunista e poeta
blasferico, per salvare tutta la mia italianitudine sono dovuto emigrare, per
non traviare l'anima mia." (p 455).
Un
altro paragone è quello con Thomas Mann, costretto all'esilio al tempo del
nazismo: "… l'universo linguistico è l'anima mia, le anime trapassano le
frontiere come niente fosse. Thomas Mann quando i nazisti gli tolsero la
cittadinanza tedesca dichiarò in una intervista che dove era lui era anche la
Germania. Dove è il sottoscritto è anche tutta la nostra italianitudine."
(p 455).
Lo
sguardo sull'Italia dal luogo della sua condizione emigrata e "spatriata"
giudica con amarezza: "… forse è vera la questione delle due Italie, una
maggioranza sanfedista e reazionaria rotta a tutte le corruzioni, l'altra
Italia, quella avanzata, illuminata che in certe epoche è una minoranza
ristrettissima, la prima mi diventa sempre più insopportabile e schifosa più la
seconda diventa numericamente insignificante." (p 445).
Non
manca una frecciata rivolta agli ambienti letterari: "… amo l'ordine e la
pulizia mi scrisse un Italo Calvino, non venire da me e vai dagli informali con
le tue scritture periodiche e in quel periodo gli informali erano per me una
specie particolarmente misteriosa e per fare parte della corrente non basta
essere rigorosamente informali ma occorre essere invitati, per essere invitato
alla festa degli italiani di Oslo non basta essere italiano occorre che
l'ambasciatore ti inviti e non inviterà certo il sottoscritto che non partecipa
all'italianità ma all'italianitudine scravattato e male sbarbato come si
ritrova, non mi aggruppo anche perché non mi fanno aggruppare (…) le macchine
che mi hanno lavorato tutti i giorni me le sognavo di notte, intanto immaginavo
nuova corrente letteraria, nuovo manifesto…" (p 442). Quando Di Ruscio
parla del suo specifico lavoro in fabbrica, usa il verbo lavorare nella forma
passiva: lui era lavorato dalle
trafilatrici presso le quali era situata la sua postazione. Noi lavoratori,
ancora in larga parte legati alla civiltà industriale, siamo lavorati dalle macchine, non siamo noi
che propriamente lavoriamo godendo il frutto del nostro lavoro, non apparteniamo
a un mondo libero di indipendenti creativi artefici del loro destino. Estendendo
il concetto all'intera società dei consumi potremmo dire, memori del discorso
marxista sull'alienazione e sul feticismo della merce: non siamo noi che
compriamo le cose, sono le cose che ci comprano.
Già in Palmiro, il primo romanzo (1986), lo
straniamento rispetto alla società era forte: "Dovrebbero finire i giorni
che è come se la gente si muove dentro una grande scena, e mettersi tra la
gente è come diventare una comparsa con una parte rigorosamente programmata e
mi ritrovo in una rappresentazione di cui non ho imparato niente. Per forza
recito male una parte se la commedia la considero particolarmente schifosa (…)
Ogni tanto vedo un gesto non completamente programmato, il miracolo è
possibile. Ad ogni modo per essere fuori dalla scena occorre un rigore pauroso,
come quando sul biliardo viene lanciata dal campione la palla d'avorio più bella."
(p 119).
Maggiori
considerazioni sugli altri romanzi di Di Ruscio e sul suo particolare uso della
lingua si possono trovare in un mio precedente articolo sull'autore: http://www.ilprimoamore.com/blogNEW/blogDATA/spip.php?article397
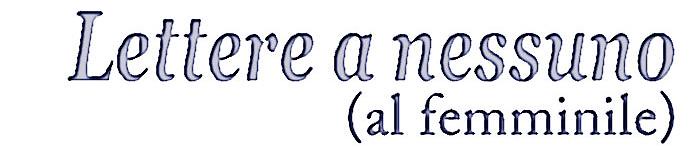
Nessun commento:
Posta un commento