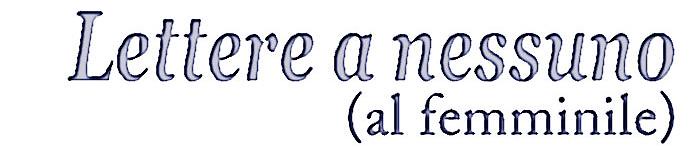Dopo il saggio Senza trauma di Daniele Giglioli del 2011. ripubblicato da Quodlibet nel 2022, ci sono state una pandemia, una guerra in Europa che dura da quasi quattro anni e non accenna a finire, un'escalation militare nella Ue con evocazione di guerra nucleare, un genocidio sulla costa orientale del Mediterraneo nella zona incandescente del Medio Oriente non ancora pacificata. Gli capitavano in mano da commentare più che altro testi di occidentali benestanti, di una borghesia pasciuta che al massimo guardava bombardamenti lontani alla televisione.
venerdì 19 dicembre 2025
venerdì 10 ottobre 2025
Una donna che riesce a non essere triste
Un bel libro di un piccolo editore indipendente (Exòrma) passato quasi inosservato: La donna che pensava di essere triste di Marita Bartolazzi (Roma, 2017). Il testo onirico e fiabesco è stato paragonato, nelle poche recensioni ricevute, ad Alice nel paese delle meraviglie, ma a me pare vicino a una fiaba moderna, che ha sullo sfondo una società alienata cui la protagonista cerca di sottrarsi non inserendosi in contesti definiti, non riferendosi mai a nulla di concreto, e rifugiandosi in un mondo immaginario e protetto. I personaggi con cui si relaziona, sebbene fantastici come gli animali parlanti, evocano figure di un mondo domestico che potrebbe appartenere a tutti: figli che qui appaiono e scompaiono lasciati a giocare al Supermercato; un Monumento che potrebbe somigliare a un fidanzato, perché si prende il tè con lui e vorrebbe trasferirsi a casa della donna; una Venditrice di liquerizia dell'infanzia; un Sarto che tiene comizi e inaugura un museo, il quale sottolinea la necessità di passare all'età adulta con il proprio corredo di abiti da lavoro. Nel discorso del Sarto nelle pagine finali del libro, in questo richiamo alla realtà, mi pare percepibile un'ironia che allude ai limiti molto marcati dei nostri sogni.
La "donna che pensava di essere triste", per tentare di attenuare la sua tristezza, un po' come facciamo noi nel mondo reale, fa un viaggio, sogna altri viaggi, va al Supermercato essenzialmente per comprare sogni, cerca altre sé stessa perse e talvolta dimenticate, ha un Gatto serafico e saggio che le parla e riesce a consolarla senza alcuno sforzo.
mercoledì 10 settembre 2025
Il narratore che indaga su sé stesso...
... è quello che m’interessa precipuamente in un romanzo. Lo trovo qui nel Sillabario all'incontrario di Ezio Sinigaglia (Terrarossa, Bari 2023). Pure l’indicazione “all’incontrario” è spia del fatto che ci troviamo in un campo diverso dal solito (un campo minato? Vedremo). Non avremo a che fare con dei personaggi, generalmente visti dall'esterno (almeno, non solo con dei personaggi), ma con un io, con una persona ovvero il personaggio-uomo (come si espresse un celebre critico* a proposito dei più significativi romanzi che edificarono la letteratura novecentesca). È sotto i riflettori l’essere umano che cerca di comprendere sé stesso.
“All’incontrario”: dichiarazione esplicita di sovversione. Quale, per esempio? Il testo è più che narrativo, analitico; più che sviluppato in orizzontale, sviluppato in profondità; più che svolgimento di fatti, considerazione di parole-chiave.
L’oscurità, la zona d’ombra su cui s’indaga è la depressione, al cui vortice centrale si cerca di avvicinarsi attraverso le sonde delle parole-chiave, che in effetti sono calamite di significati, risonanze, reminiscenze, simili ai densi elementi del sogno.
A questa struttura romanzesca predisposta alla meditazione, all’approfondimento, all’analisi, infonde ritmo il tambureggiare della punteggiatura. Anch’essa si presenta anomala, trasgressiva. La briosa cadenza dei due punti fa pensare a un mare increspato, un mare in apparenza abbastanza tranquillo ma le cui piccole onde incalzanti mandano sott'acqua i nuotatori senza che neppure se ne accorgano. Sono poche le pause vere e proprie, i punti fermi. Si naviga su un mare inquieto, continuamente mutevole. Infatti, quando il narratore sfida il lettore apertamente a trovare una bussola, un sicuro orientamento, il lettore capisce al volo di trovarsi difficoltà. Deve mettere alla prova la sua intelligenza, la sua intuitività, il suo istinto per comprendere la materia affascinante ma sfuggente.
Tuttavia, completato l’alfabeto, seppur rovesciato e trasgredito in più punti (non per rendere le cose difficili, per puro gusto provocatorio e sottilmente maligno, ma perché le cose sono in effetti difficili), la mia risposta di lettrice all’enigma proposto dall’autore è che le cause nascoste dello stato presente siano celate soprattutto nei capitoli Narcosi, Eros, Dilazione, Bambini. S’intravede la terribile ombra del sacrificio, ma nel mare increspato, a volte tumultuoso, di questa navigazione complicata, le certezze sfuggono rapidamente, le immagini si disfano in un batter d’occhio; si è inoltre distratti dalle piacevoli digressioni dettate dall’ironia, dalle intemperanze, dal fluire della vita, che nella sua maniera inaspettata, totalmente gratuita, persino in alcuni momenti difficili, è capace di doni generosi, tali da ribaltare tutto.
* Giacomo Debenedetti
martedì 25 marzo 2025
Renitente alla leva dei romanzieri (convenzionali): Gherardo Bortolotti
Tecniche di basso livello (Gherardo Bortolotti, Lavieri, Caserta 2009): un titolo che, fra le altre cose, potrebbe alludere al "mestiere" di scrivere. Quali sono queste tecniche? Narrative forse?
Si procede per frammenti dall'ordine scomposto, i
cui numeri di riferimento non si presentano consequenziali: primo atto
d'insubordinazione verso la trama. Si nota subito anche l'anomalia dei
personaggi. I nomi propri iniziano con la lettera minuscola, sono nomi che
potrebbero appartenere a robot e risentono di un'impronta seriale, omologata. L'uomo di Marcuse, schiacciato su un'unica
dimensione e condannato a una passività appena pensierosa, abita queste pagine. L'orizzonte culturale appare circoscritto da
proposte dell'industria musicale e cinematografica o, per meglio dire, legate
alla produzione televisiva, alla pubblicità e alle serie, che pervadono ogni
angolo della coscienza e finiscono per dissolvere ogni tentativo di pensiero
autonomo e critico: "Impegnati in trame minori…", "abituati
al ruolo di comparsa…" si trova scritto, "ci eravamo allontanati dai
telegiornali, dalla lettura dei quotidiani, perché la realtà era un genere
sclerotizzato, una nicchia di mercato sempre più ristretta e lasciata agli
addetti ai lavori." (pag 17); "Lontani dagli abusi sui clandestini,
seguivamo le vicende della nostra serie preferita e ci preparavamo a esprimere
opinioni in merito al giorno d'oggi..." (pag 63); "La distanza tra lo
stato delle cose e la curva dei nostri progetti aumentavano il senso di una
conclusione incongrua (…) Senza morali da trarre, guardavamo il telegiornale,
affascinati dalle immagini in movimento." (pag 69).
Ritmi televisivi e abitudini sonnolente a parte,
la dimensione attiva della vita è impegnata nel lavoro, non gratificante ma, a
inizio anni 2000, ancora in grado di infondere una sensazione di stabilità e
sicurezza. Il Giano bifronte della condizione di lavoratori che riescono
persino a elevarsi a un discreto benessere è ben espresso da frasi contrapposte
come: "Le villette a schiera, i quartieri periferici ci parlavano di un
benessere continuo, di una forma socialdemocratica di eternità." (pag 11);
"A vantaggio di un futuro altrui, accettava l'orrore della sveglia e
l'allucinazione del salario, e rimandava alle ore della sera l'occasione di
pensare e di sentirsi vivo." (pag 54). Queste ultime tre righe riescono a
rendere in una sintesi efficace quanta parte della vita ci venga sottratta dal
lavoro, quanto di noi sia sottoposto alle dure leggi del capitale.
Tuttavia il lavoratore dei giorni nostri è anche e
soprattutto un consumatore:; "L'accessibilità della merce appariva come la
controparte di un accordo rispettabile. Le campagne promozionali in corso ci
procuravano una serenità più generale, quasi oggettiva." (pag 13)
"Dall'attesa della morte, ci distraevano le pubblicità delle agenzie di
viaggio. Come robot buoni, ci incamminavamo dentro lunghi vicoli ciechi…"
(pag 53). Si subisce il fascino di "modelli di vita diffusi dal marketing
di un prodotto di consumo (un dopobarba, un'automobile…)" (pag 61). E nel
riferimento al dopobarba non possiamo non cogliere un richiamo all'Aldo Nove di
Woobinda e del bagnoschiuma Vidal (Castelvecchi, Roma 1996). A inizio
2000 si viveva ancora nell'atmosfera degli anni Novanta in cui perduravano,
indisturbate, le esigenze pervasive e ottundenti della società dei consumi.
Benché
la potenza di Eros, cieca, arcaica, sia l’argomento principale di
Romanzetto estivo (Tic edizioni, Roma 2021), ben lontano quindi dai
desideri indotti artificialmente dalle esigenze di mercato e governabilità
presenti nelle Tecniche, persino in questa raccolta di poesie, o prose
poetiche, talvolta affiora l’immancabile effetto di straniamento del
personaggio che, in un modo o nell’altro, sente di non avere in mano il suo
destino: “… quello che mi /accade davvero accade sempre altrove… “ (pag 52).
In Tutte le camere d'albergo del mondo (Hopefulmonster, Torino
2022) si configura un orizzonte meno deterministico. Cosa rimane della
costruzione di Tecniche di basso livello? Accanto a ciascun titolo di
capitolo troviamo dei numeri, numeri un po' ambigui che non è chiaro che cosa
indichino: il primo numero di capitolo per esempio, anziché 1, è 1002. Ve ne
sono alcuni consecutivi ma a un certo punto si passa dal 1035 al 1040 oppure
dal 1057 al 1065. L'osservazione più banale è che i numeri dei capitoli
corrispondano a numeri di camera e che dimostrino semplicemente che alcune
camere sono occupate, altre no. Ma l'arbitrio numerico potrebbe anche
significare che certi capitoli sono rimasti mentre altri sono stati espunti dal
capriccio dell'autore. Qualcosa manca, insomma, qualcosa di vistoso che rimanda
a una forte volontà di elisione, di cancellazione. E in effetti anche le trame
imbastite per ogni stanza sono stralci di vita di persone che appena
s'intravedono, di cui non si conosce il passato e che non si sa cosa andranno a
fare.
domenica 23 febbraio 2025
Il male oscuro
Il male oscuro (Rizzoli, Milano 1964) di Giuseppe Berto rappresenta uno degli esperimenti romanzeschi più riusciti degli anni Sessanta. L'autore si concede di lasciarsi andare a un flusso ininterrotto quasi senza punteggiatura sul suo stato d'ansia solo parzialmente spiegabile. Mentre si può riscontrare, a distanza dall'effetto sorpresa del 1963, un certo manierismo in alcuni romanzi dei Novissimi, constatiamo la piena ragion d'essere e modernità del Male oscuro. Il legame con Svevo è dichiarato a pag 314 dell'edizione Neri Pozza (Vicenza 2016). Ma è presente già nel riferimento al nome Augusta per la figlia (moglie di Zeno nella Coscienza) e, per esempio, nel gioco con sé stesso che fa il protagonista di Berto nel rimandare a più riprese la stesura del quarto capitolo della sua opera, così come Zeno rimandava continuamente il momento in cui avrebbe smesso di fumare. "... il capolavoro per dirla francamente era una specie di gioco a rimpiattino tra me e le mie disgrazie, ossia tre capitoli bene o male ero riuscito a scriverli e forse neanche tanto male ma poi la faccenda era rimasta lì ed era anche del tutto improbabile che andasse avanti inquantoché della speranza di andare avanti io avevo bisogno come della salute con la quale in fin dei conti era tutta una cosa..." (pag 317). Giocare a nascondino con le proprie tentazioni (la sigaretta) o illusioni (il capolavoro)... Giuseppe Berto capisce che sia Zeno sia il suo personaggio prendono in giro sé stessi, che la loro nevrosi li prende in giro, quindi occorre cercare una cura. I malati meglio avviati sulla strada della guarigione sono senz'altro quelli curiosi nei confronti dei loro malesseri.
Solo che proprio quando le cose sembrano essersi messe a posto, il protagonista del Male oscuro acquisisce fiducia in sé stesso e persino il suo analista lo congeda dicendogli che è guarito, la vita gli fa uno sgambetto, lo mette alla prova con un'inattesa separazione della moglie e lui riprecipita in uno stato di debolezza. Troppo facile un lieto fine.
lunedì 5 agosto 2024
Un esperimento di fabbrica-laboratorio sociale: GKN
Seconda parte del Cammino dell’acqua
Da
un certo punto in poi il Cammino dell’acqua dell’associazione culturale
Repubblica nomade si trasforma in una marcia di solidarietà alla GKN di Campi
Bisenzio. Il percorso attraverso le terre romagnole e toscane che furono
alluvionate nella primavera e nell’autunno 2023, fra il 16 e il 29 giugno di
quest’anno non è mai stato una flânerie anzi il contrario, per motivi
organizzativi e d’impulso attivista; diventa comunque decisamente più arduo
sull’appennino tosco-emiliano, soprattutto per motivi climatici. Un
sorprendente nubifragio contrassegnato da allarme meteo si abbatte anche sui
camminanti, ma non impedisce la continuazione a un drappello dei più
determinati. Passata la burrasca, in prossimità dell’arrivo, il gruppo si
ricompatta e si amplia. Vi si aggiungono altre e altri solidali con la lotta
degli occupanti e si arriva davanti ai cancelli la mattina del 29 giugno.
Dal
18 maggio gli ex operai avevano iniziato una tendata di protesta sotto la
Regione, in quanto da sei mesi erano stati lasciati senza stipendio né
ammortizzatori sociali, sempre in attesa di risposte chiare a domande semplici.
La tendata è poi durata 35 giorni con 13 giorni di sciopero della fame. In
tutti questi anni ai lavoratori non sono mancate la forza di volontà,
l’inventiva, la determinazione. Ben presto, a breve distanza da quel 9 luglio
2021, da quando tutti i 500 lavoratori GKN si ritrovarono licenziati dal fondo
britannico Melrose con un semplice sms, insieme con ingegneri ed economisti
solidali si iniziò a pensare a un piano di reindustrializzazione dal basso:
così leggiamo nel libro di Valentina Baronti (una degli attivisti di supporto
esterno), La fabbrica dei sogni, che ripercorre con chiarezza le varie
tappe di un percorso complesso e accidentato. Si cercò di allargare l’orizzonte
e di coinvolgere nella lotta il maggior numero di soggetti possibile. Questa
era una pratica già nota agli operai molto sindacalizzati della fabbrica ex
Fiat (il colosso GKN aveva rilevato il complesso dalla Fiat negli anni ’90, un
colosso aveva inglobato un altro colosso); in seguito continuò a essere
utilizzata e incrementata con sempre nuove trovate, per l’esigenza di tener
viva l’attenzione su una questione anno dopo anno mai risolta. Un’intera
comunità “ora è chiamata a farsi intelligenza collettiva, per uscire dal
calcolo solito con cui si chiudono le fabbriche: un ammortizzatore sociale che
serve solo a coprire, con soldi pubblici, la fuga della multinazionale o del
fondo finanziario, la nomina di un advisor che deve trovare un
reindustrializzatore, che però non arriverà mai e piano piano la vertenza si
spegne, i lavoratori si licenziano alla spicciolata, lo stabilimento si svuota
e rimane uno scheletro industriale su cui avviare una speculazione edilizia”:
osserva Valentina Baronti (cit., pag 40). Del resto, si trova scritto poco più
avanti, “quando ti compra un fondo finanziario, lo sai che prima o poi chiudi.
Comprano per ristrutturare, dicono loro, che in realtà vuol dire
licenziare e poi rivendere, guadagnando in borsa”. GKN fu acquistata dal fondo
Melrose nel 2018; non si dovette attendere molto perché si concretizzasse ciò
che un po’ si temeva fin dall’inizio. Diverse volte, fra il 2021 e la fine del
2023, i giornali cantarono vittoria annunciando una svolta decisiva a favore
dei lavoratori, ma le speranze vennero puntualmente frustrate. Si rispose
cercando di lanciare la palla sempre più lontano: fu organizzato, anche con
l’apporto di sindacati e associazioni straniere, un Festival di letteratura
working class a inizio aprile 2023, cui perfino il regista Ken Loach fece
pervenire un forte messaggio di sostegno; nello stesso anno si promosse una
consultazione popolare e si raccolsero 17000 firme che esprimevano il desiderio
di una fabbrica pubblica e aperta alla società. Tanti giovani di diverse
associazioni, fra cui Fridays for future, manifestano per un nuovo tipo di
fabbrica che vuole avviare una produzione sostenibile. Scrive un autore fra i
partecipanti al Festival di letteratura working class: “Siamo le seconde
generazioni della classe operaia. Spesso siamo i primi in famiglia che sono
andati all’università. Scriviamo sulle spalle dei nostri vecchi, a volte con un
inquietante senso di colpa, pensando ai sacrifici che hanno fatto per farci
studiare. Non di rado con le nostre scritture cerchiamo una sorta di giustizia
poetica che possa in qualche modo compensare tardivamente la durezza della
vita dei nostri genitori.” (Alberto Prunetti, Non è un pranzo di gala.
Indagine sulla letteratura working class). Giustizia sociale e giustizia
climatica che diventano giustizia poetica… una bella sintesi di tutto
ciò che si vorrebbe nello slogan Abbiamo fame di un mondo nuovo… Si
forma e si estende sempre più quel progetto di “fabbrica socialmente integrata”
di cui parlano i volantini e che si propone come tema centrale anche alla
festa-ricorrenza del 12 luglio 2024 a Firenze. Intanto si progettano e si
cominciano a costruire prototipi di pannelli solari e cargo bike, biciclette
per il trasporto ecosostenibile.
sabato 20 luglio 2024
Costeggiando un terreno franoso
Prima parte: un esperimento di agricoltura sostenibile, la comunità Terrestra
“Attenti alla macchina!”. All’uscita da Ravenna
percorriamo chilometri su asfalto statale e provinciale, a tratti senza
marciapiede. Paolo Pileri (ordinario di pianificazione territoriale e
ambientale al Politecnico di Milano), che ci accompagna per un lungo tratto, ci
segnala le varie brutture, tecnologiche e no, che si sarebbero potute evitare o
mascherare meglio (armadi tecnologici, ex capannoni, aree dismesse recintate e
incolte, mancanza di siepi, soste degli autobus senza marciapiede), ma deve spesso
interrompersi perché dobbiamo soprattutto prestare attenzione alle auto, che
possono sorprenderci alle spalle in qualsiasi momento, persino in qualche via
laterale. Benché Guido Viale abbia scritto Vita e morte dell’automobile,
con una certa fiducia in una svolta decisiva, nel lontano 2007, eccoci ancora
completamente circondati… La vettura privata con motore a scoppio è dura a
morire, purtroppo lo constatiamo giorno dopo giorno. Ma qui siamo solo
all’inizio di un percorso che vuole portarci fuori dal tessuto urbano in pieno
ambiente rurale.
Turismo di prossimità, agroecologia, visita solidale a
realtà alternative e a una fabbrica occupata… il cammino di quest’anno di
Repubblica nomade si preannuncia particolarmente denso di eventi e significati.
Di chi stiamo parlando? Parafrasando alcune parole di
Moresco, contenute nella prefazione a Stella d’Italia, potremmo dire che
Repubblica nomade (che a quel tempo era ancora in germe, ma molto desiderosa di
nascere) non è qualcosa di puramente culturale, anche se si denomina
“associazione culturale” e c’è dentro una forte spinta culturale e ancor più
poetica; non è qualcosa di puramente politico, anche se c’è dentro una forte
spinta politica e una trascendenza civile; non è qualcosa di puramente
atletico, anche se ha comportato per molti partecipanti un superamento delle
possibilità fisiche individuali. In parole più povere, prive di tutte le
sfumature sopra accennate, Repubblica nomade è un’associazione che organizza
cammini, in Italia e in Europa, caratterizzati da una forte connotazione
simbolica e politica (non partitica, dal momento che le idee sono varie e le
scelte in cabina elettorale pure). Inevitabile, il notevole impegno fisico, dal
momento che è proprio il passaggio dal pensiero all’azione (dalla passività
abitudinaria del nostro tran tran quotidiano all’attivarsi per qualcosa di
socialmente significativo) che si desidera, sebbene in modo giocoso,
incentivare. Perché, invece delle solite vacanze organizzate o familiari o di
consumo (nel distruttivo turismo transcontinentale), non utilizzare parte dei
nostri giorni liberi dell’anno per un’esperienza di turismo di prossimità, che
ci faccia riscoprire una vita in comune con altri, ci faccia incontrare persone
anche molto diverse da quelle del nostro ambiente, ci porti,
gambe-cervello-cuore, a contatto con realtà di cui magari si è sentito parlare,
si è letto fuggevolmente qualcosa ma non si sono mai viste né conosciute,
benché fossero qui a due passi, a qualche centinaio di passi… prendendo il
treno subito raggiunte, da poter vedere e conoscere camminandoci dentro.
sabato 8 giugno 2024
Dolores e il buio del passato
Mi sono molto identificata in alcune asserzioni di Dolores Prato relative all'infanzia: "“… l’infanzia è un vuoto immenso dove precipitano le cose…” (in una lettera). In Giù la piazza non c’è nessuno: “Quel poco che ho studiato è scomparso nel buco nero che ho al posto della memoria, equivalente di ignoranza totale. Quel che pare ricordo, è tatuaggio, incisione, cicatrice: io leggo i segni.” (Dolores prato, Giù la piazza non c’è nessuno, Quodlibet, Macerata 2009, pag 102).
Anch’io devo avere un difetto della memoria che m’induce a colmare continuamente le mie lacune smisurate: curiosità d’imparare altrettanto smisurata.
lunedì 3 giugno 2024
Quando si vuole il thriller a ogni costo
Un romanzo sulla maternità scritto come un thriller, in uno stile concitato pieno di suspense. Una scelta che non convince: Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi (Einaudi, Torino 2023). Non è una questione di giudizio morale dal momento che neppure so come va a finire la storia, non avendo voluto assecondare la curiosità tipica dei lettori di gialli che mi pare fortemente alimentata; è fastidio per lo stile ad alta tensione "da thriller", che in me suscita l'impressione di venire manipolata e costretta a leggere per sapere come va a finire.
lunedì 8 gennaio 2024
Un tesoro (sperimentale) ritrovato
Giuliano Gramigna, Marcel ritrovato, Il ramo e la foglia, Roma 2023
“Passai portandomi dietro quel segnale di marrone e azzurro. Il mio cuore aveva accelerato, addirittura extrasistoli, ma era una specie di dilatazione euforica come quando ci si mette a correre, poi manca il fiato e ci si sente bene, si sta per scoppiare e ci si sente ancora meglio con energie intatte. Galoppavo a cavallo della mia nevrosi: sindromi spastiche dell’apparato digerente, neurosi splancnica, stipsi spastica, neurosi cardiaca e vasale, instabilità circolatoria, vertigini, distonie funzionali degli ipotesi, iperemesi, vertigini labirintali, mal di mare, affezioni del sistema nervoso extrapiramidale, colangiopatie, disfagie esofagee, vomito, acroasfissia, acroparesia, claudicazione intermittente (…) travaglio di parto eccetera, a cavallo non guarito ma in certo senso esultante. Anch’io avevo avuto quei capelli castani sulla fronte, la pelle nuova con la peluria bionda dietro le mandibole scampata al primo, ostinato rasoio; naturalmente senza rimpianto, però come mi erano piaciuti nei primi dieci, trenta secondi che li avevo incrociati. Neppure Marcello era sempre stato il manichino-a-successo del Tennis Club: per non dire niente altro, oltre le guance giovani, i muscoli elastici, l’aria di cuccioli, eccetera, c’erano state anche le speranze del ’45. Un momento di eccitazione non romantica ma proprio fisica, un’estasi corporale, una scossa elettrica data dalle cose, come inspirando nel momento che scrivo di me e di Marcello l’aria limpida, sottozero di Milano 8 gennaio 1967, dove sembra di stare quasi a Irkutsk.” (pag 266)
Nel romanzo circola l’aria libera, frizzante e innovativa degli anni Sessanta. Uno dei primi segnali che ci avvisano di trovarci di fronte a uno scrivente alla ricerca di un proprio stile fuori dalle convenzioni è lo scivolamento dalla terza alla prima persona; prima persona, quella del protagonista Bruno, dubitativa, inquieta e dispettosa.
domenica 3 dicembre 2023
Bookcity
Olio di gomito
per pulire gli elementi della cucina, poi di corsa a un evento pomeridiano di Bookcity.
Quest'anno forse riesco a seguirne due o tre, anche se me ne ero prefissa
cinque o sei.
Nel grande
teatro del centro la sala principale è dedicata alla presentazione di un
romanzo storico-rosa che sta spopolando. È difficile
entrare per la ressa: una moltitudine di ragazze in coda per farsi firmare le
copie dall'autrice ostacola non poco l'accesso alle altre sale che ospitano diversi
eventi. Il mio è al primo piano: Mappe nel caos della poesia contemporanea.
I relatori cercano di dire qualcosa su un mondo corporativo e autoreferenziale
(sic! qualcuno così sussurra e persino afferma a voce un po' più alta), quello della poesia contemporanea che cita e ordina sé stessa,
consegnandosi alla posterità già confezionata in alcune antologie e mappe
orientative.
La saletta non è
proprio vuota, anzi più piena del solito, perché, a differenza dei tre-quattro
ascoltatori che abitualmente costituiscono il fedelissimo pubblico dei reading,
qui si stanno concentrando una decina di persone, forse qualcuna in più, delle
quali soltanto alcune si salutano, altre è la prima volta che si vedono: e
questa sì che è una gran differenza rispetto alle solite letture pubbliche di
poesia, dove i pochi convenuti si conoscono, si sono già letti e ascoltati (se
la cantano e se la suonerebbero pure se trovassero una cetra da qualche parte), comunque contenti di ascoltarsi e auscultarsi vicendevolmente.
I lettori di poesia sono i poeti stessi, si diceva qualche tempo fa; ora si può
aggiungere che i poeti stessi sono anche i critici della poesia. Un relatore
osa di più: per un certo periodo i veri e propri critici (quelli non poetanti?)
hanno avuto paura a pronunciarsi sulla poesia attuale.