Ho partecipato all'acquisto di alcuni libri in
vendita solidale seguita all'incendio doloso che ha avuto come oggetto, nella
notte fra il 30 e il 31 dicembre 2012 a Pavia, la casa dell'editore giornalista saggista Giovanni Giovannetti. Nel rogo sono andati in fumo molti libri del
magazzino. Quell'incendio secondo gli inquirenti è da mettere in relazione con
altre azioni intimidatorie compiute nell'ultimo periodo ai danni di attivisti
politici che si battono contro la criminalità organizzata, la
speculazione edilizia e il consumo del territorio nell'area pavese e lombarda.
Uno dei libri bruciacchiati, salvati e ritornati
nel circolo delle letture grazie all'iniziativa della vendita solidale, è Accusata di Mariella Mehr (Effigie,
Milano 2008), autrice svizzera d'origine zingara dalla vita travagliata e
traumatica. Nella prima infanzia fu infatti strappata alla madre e affidata a
famiglie diverse e orfanotrofi, per via di una legge tesa alla
sedentarizzazione forzata che restò in vigore in Svizzera fra il 1926 e il
1972. Ci troviamo di fronte a un'autrice che è stata traumatizzata e
psichiatrizzata.
Per combinazione, questo libro parla di una
piromane, di una psicotica che fa il resoconto dei suoi delitti a un giudice
istruttore e ad altri carcerieri/carceriere. Un monologo talvolta frastagliato
che in alcune parti drammatiche diventa flusso di coscienza senza
punteggiatura, altrove, seppur raramente, puro delirio.
Nell'incipit il delirio è lucido, espresso in
forma razionale e comprensibile, perfino saggia (di una sua propria forma di
saggezza che deriva dalla profondità delle esperienze vissute): "Sono in
stato di grazia. Uccido. Dunque sono.
Se riduco la mia vita a questa formula breve,
posso considerarla pienamente riuscita. Come un'opera d'arte compiuta, cui non
manca nessuna sfumatura e che è perfetta sotto ogni punto di vista. Che Lei ci
creda o no, vi sono contenuti perfino i colori dell'amore. Persone come me sono
considerate incapaci d'amare, com'è noto. A torto o a ragione, dipende dal modo
da cui si guarda una vita.
Non si lasci ingannare dal mio aspetto giovanile.
La mia vera età sta nelle azioni compiute. A sommare le mie azioni, anche solo
quelle protocollate dal cancelliere, ne verrebbe un numero cospicuo, pari a
qualche centinaio di anni di vita." (p 7).
Qui invece il discorso si fa lirico, deragliante,
ancora comprensibile ma carico di sensi impliciti e multipli: "Se disturbavo
mia madre digrignando i denti, lei mi legava una benda intorno alla testa. Come
fossi morta e non dovessi essere sepolta con la bocca aperta.
Ma quando la bocca si ribellava lei me le suonava.
A volte mi sorprendo a parlare da sola.
La bocca di Kari, morta, dico io, Iokari e Io.
Lei. Io. Lei. Chi?
La mia testa torna dentro alla benda. A casa, dice
la testa, e subito sono morta di nuovo. Eppure ci provo, dice la testa, con me
attraverso la benda…
Il cuoio capelluto si lacera, dico. Il sangue mi
scorre tra i capelli e nell'incavo che si forma tra il collo e la spalla, ma la
benda rimane bianca.
Dice la testa.
Soltanto la parete della cella ha una macchia
scura in più.
Lei viene da fuori. Là fuori in questo periodo
dell'anno fioriscono la gattaia e l'erba di san Giovanni. Dicono. Io me lo
ricordo appena. Vedo le pareti bianche. Bianche come il materiale artificiale
che c'è nella mia bocca.
Sulle mura intorno all'Istituto hanno messo da
poco del filo spinato. Dicono. Forse una di noi ha tagliato la corda, chissà.
Tutte le fantasie che traboccano da queste mura
segano via la vita, come fosse un ramo sul quale ci si è seduti molto tempo
prima e solo per sbaglio.
Preferisco prendermi quel pezzetto di blu dalla
finestra. Lo mastico a morte." (p 20).
Mentre in queste righe il puro delirio,
incomprensibile, è chiaramente rappresentato: "Sul lato della facciata
trecce scure, capelli anche sul cornicione capelli, un edificio peloso,
trasandato, anche se dentro tutto puzzava terribilmente di ordine.
Ma fuori si vedeva perfettamente tutto il
disordine, che aveva qualcosa di audace, che non quadrava con il resto, che si
sarebbe dovuto radere via. Un furore peloso che cadeva a ciocche sulla facciata
della casa e sulla tettoia di plexiglas." (p 86).
Il fuoco che mangia i libri, parole che mangiano
parole e il loro senso, Kari che mangia l'azzurro del cielo intravisto dalla
sua cella. Ciò che si desidera si distrugge in un gioco mortale di
sopraffazione.
In questa logica di dolorosa ma inevitabile
contrapposizione all'altro, l'unica amica è una figura immaginaria, Malik, che
continuamente viene rievocata come compagna d'avventure inafferrabile.
L'identità persino dei forti, degli assassini è seriamente compromessa,
frammentata. Qui come negli altri volumi della trilogia.
Anche nel Marchio
(Tufani, Ferrara 2001) la realtà di fatti crudeli è rievocata con un linguaggio
a tratti onirico e smembrato, da incubo. E anche qui l'unico elemento positivo
sembra essere l'amicizia/amore, nata nell'emarginazione, fra due ragazze, una zingara
e un'ebrea. Violenza sulle donne, violenza sui bambini, violenza contro gli
emarginati, violenza dei genitori contro i figli, ma anche violenza restituita,
identificazione con l'aggressore. Violenza come circolo vizioso da cui non si
scappa.
Uno dei tratti originali del libro è il passaggio
della voce narrante dalla prima alla terza persona, quasi che l'autrice con
l'assunzione parziale della terza persona voglia creare un maggior distacco dal
materiale doloroso di cui tratta, quasi uno schizzare improvviso, durante la
narrazione, in un'altra identità che non sia quella delle protagonista di
sventure ma di un semplice osservatore. Due esempi:
"Sono Anna. Anna Priska Kreuz.
La morte.
La morte non cessa di stupirmi. Non mi abbandona
mai. Mi accompagna nei miei vagabondaggi attraverso la serra. Guarda con i miei
occhi l'allegra attività di cattura dei meravigliosi ibridi." (p 10);
"Il dolore trovava la sua occasione. Tentava
con ogni mezzo di dare una mano ad Anna. Guarda bene, bisbigliava, e le metteva
sotto il naso la foto incorniciata. Spesso, Anna, le cose sono completamente
diverse. Eccomi qua, il tuo dolore, rideva il dolore, lasciati guidare, non
precipitarti incontro alle pallottole come un animale braccato." (p 32).
L'identità risulta in conflitto con se stessa
oltre che con gli altri, amici o nemici che siano:
"Un tempo era più facile mettere Anna contro
Anna. Adesso lei prende sempre più il sopravvento. E quanto più penetrerà in
me, tanto più sarò sola. Non mi tratta certo con delicatezza. A suo tempo non
trattò con delicatezza nemmeno Franziska. E tanto meno chiese il mio
parere." (p 79)
"Naturalmente sono in conflitto con me
stessa. Mi guardo per così dire da sopra le spalle e vedo un'Anna che vorrebbe
occuparsi di Franziska. Ma contemporaneamente sto alle calcagna di Lodermann,
prendo la strada che lui ha imboccato." (p 101).
Ma torniamo ai volumi pubblicati dalla casa
editrice Effigie.
Un altro grande ustionato (e già ustionante di per
sé per il contenuto) nell'incendio del magazzino di Effigie, sempre della
stessa autrice, è Labambina (Effigie,
Milano 2006), parte anch'esso della "trilogia della violenza". Inizia
così il romanzo: "Non ha nome, Labambina. Viene chiamata Labambina. O
ragazzino, anche se è una ragazzina. Viene chiamata ragazzino, o monello, con
tenerezza se le donne del villaggio ne hanno voglia. Anche monello insolente,
se Labambina avanza delle pretese, o Accidentidiunabambina, puttanella,
Sudiciamarmocchia." (p 7). Un altro dei suoi nomi è Poverabambina: "…
Poverabambina, Poverabambina, così persa. Di chi sarà Labamina, chiedono"
una notte che la trovano in un campo. "Ma lei rimane muta e beve il latte.
Si scalda appoggiata al grande seno della contadina. Non salta oltre
l'abisso-parola, per arrivare, finalmente, a trovare un ordine. Labambina
rimane senza casa nonostante il calore del locale e nonostante il latte, non è
accessibile a nessuna tentazione, Labambina." (p 72). I pochi attimi di
tenerezza che la piccola riesce a risvegliare nel villaggio, anch'esso senza
nome, sono largamente sommersi da una violenza diffusa, che appartiene a tutti
e pare l'unica forma di relazione, pure fra bambini.
Le ultime parole del romanzo sono queste:
"Corre Labambina e passa sopra il corpo piegato del sagrestano, nasconde
veloce e senza far rumore la fionda dietro il masso erratico rosso, accanto
all'entrata posteriore della casa, passa tranquillamente accanto al roseto
diretta verso il lato sud dello chalet, dove l'orto in questa stagione è a
maggese, privo di protezione sotto le foglie secche e senza l'amarezza delle
impietose giornate estive. Sopra il fianco orientale del Poggio ricoperto di
abeti si aggira stridendo uno stormo di taccole, quelle strida attraversano
l'orbita del silenzio.
Labambina ha trovato una pace.
Sorride di nuovo, Labambina." (p 149).
A volte uno scrittore un poeta, si riconosce per
la scelta di un solo vocabolo. Qui mi pare notevole l'espressione una pace. Ha trovato una pace, non la pace. Non la pace
banale, qualunque che è alla portata di tutti. Una pace possibile, più modesta,
più personale, più difficile appunto perché è una, è unica, la sua unica possibile pace.
(30-3-2013, Direfarebaciare)
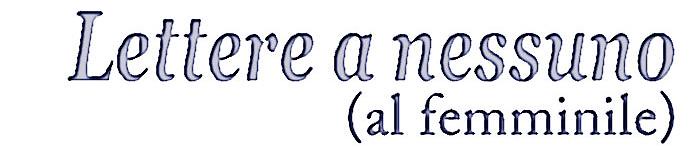
Nessun commento:
Posta un commento