Ci
troviamo fra i numerosi corridoi intersecantesi di una grande casalbergo alla
periferia di Mosca negli anni di transizione fra il passato sovietico e la
Perestrojka, in un periodo di carenza abitativa e di passaggio alle
privatizzazioni di spazi, come questo, fino ad allora almeno in parte
considerato riparo per senzatetto e gente di passaggio: corridoi che, nella
dilatazione della loro immagine, diventano immagine
del mondo intero (p 28). “Attualmente ho il dono di percepire, anche
attraverso le porte, l’odore robusto che si spande, che stilla dai fragranti
metri abitativi e il viceversa debole, e ahimé effimero segnale, che dalla loro
superficie promana la sostanza uomo. (…) Io li
vedo. Li percepisco (i metri quadri) al di là del muro e della porta: avverto i
loro odori. Li aspiro e li riconosco.
Odorosi metri abitativi, sono essi ormai a costituire per me il volto
sfaccettato del mondo.” (p 30-31)
Il
narratore-protagonista dal nome dimezzato, solo patronimico, Petrovic, di Underground ovvero un eroe del nostro tempo
(traduzione italiana Jaca Book, Milano 2012), capolavoro dell’autore russo
Vladimir Makanin recentemente scomparso, è uno scrittore che ha smesso di
scrivere non essendo mai stato pubblicato, ritiratosi ai margini della società
come semialcolizzato clochard filosofo, che sbarca il lunario rendendosi utile
nella grande casalbergo in qualità di guardiano ora di questo ora di
quell’appartamento lasciato vuoto temporaneamente dai proprietari. Nella sua
posizione di saltuario custode, aiutante di anziani e donne sole in difficoltà,
egli si guadagna il rispetto degli altri (salvo rischiare di perderlo in alcuni
momenti critici delle privatizzazioni, quando abusivi e senzacasa fino ad
allora tollerati vengono buttati fuori): “Il mio status riconosciuto di
guardiano già mi trasformava; in particolare il viso e l’andatura. (Proprio
allora ho cominciato a percorrere i corridoi a passo lento, misurato, tenendo
le mani in tasca). Curiosamente, a partire dal momento in cui mi sono scoperto
guardiano e qualificato come tale, la gente ai vari piani della casalbergo ha
cominciato a considerarmi scrittore.
Come spiegarlo? Qualcosa è scattato in loro (nei loro cervelli). Ormai ai loro
occhi ero lo Scrittore, vivevo da Scrittore. Eppure sapevano e vedevano che non
scrivevo una riga. A quanto pare uno scrittore poteva farne a meno.” (p 190).
Egli prosegue in qualche modo la sua attività di scrittore nell’ascolto delle
confidenze dei diversi abitanti dell’edificio, di occasionali compagni di
sbornie, dei numerosi amici artisti a loro volta ignorati oppure casualmente divenuti
famosi ma oppressi da inquietudine e tormenti, di donne disperate che gli si
gettano fra le braccia. In una famiglia gli viene addirittura rivelato che il
loro vicino d’appartamento aveva rinunciato al suicidio grazie al fatto di
avergli potuto parlare tutte le volte che voleva. Non manca, in alcuni casi, il
sarcasmo, per esempio nei confronti di scrittori affermati: “Rimane tuttavia in
lui una segreta inquietudine, comune a molti altri personaggi divenuti famosi,
i quali sanno che le loro parole e testi, e la loro notorietà (ed essi stessi
per giunta) sono effimeri e insignificanti e che solo il piccolo schermo trasforma
la loro nullità in qualche cosa. (…)
Lo schermo televisivo come gigantesca lente d’ingrandimento di un moscerino di
passaggio.” (p 212). Egli vive di incontri, continui racconti, ospitalità
altrui e sentimenti talvolta ricambiati. L’ascolto, l’osservazione attenta di
se stesso e degli altri, il confronto coi grandi personaggi della letteratura,
memoria vivente, viene a far parte intrinsecamente della sua scrittura,
puramente mentale ma costante, della propria vita. Egli non verga più romanzi,
giudicati dalle case editrici enigmaticamente opere di altro tipo, ma si attiene rigorosamente a un proprio codice morale,
derivato dalla grande letteratura, legato al rispetto dell’uomo e privo nel
modo più radicale di compromessi col potere: “Il solo giudice collettivo al cui
alto verdetto provo il bisogno di sottopormi è quello stesso che ha colmato il
mio spirito nel corso di quasi venticinque anni, la Letteratura russa…” (p
184); “E da una delle tasche era saltato fuori un volumetto, la prima parte de I demoni, quasi un lascito da scrittore
a scrittore.” (p 459). Per non scendere mai a patti e per non essere giudicato
un venduto dai propri concittadini e dalla Storia fa molte rinunce e non esita
nemmeno a uccidere. Commette due delitti, il primo in qualche modo ascrivibile
alla legittima difesa, il secondo legato al greve ambiente di spie e delazioni
che s’infiltra ovunque, compreso l’underground di artisti incompresi, falliti,
emarginati, alcolizzati che lo circonda. Dopodiché dovrà fare i conti con
Dostoevskij: “ ‘Non trasgredire il divieto di uccidere’: questa lezione
straordinariamente essenziale – per esempio in Dostoevskij – resta per noi viva
e attuale. Ma vive in quanto idea, astrazione artistica energicamente espressa.
In queste vecchie e geniali parole (indubbiamente profetiche per il loro tempo)
traspare già il tabù a venire. La letteratura possiede una grande forza di
persuasione. E’ un virus potente. (Quella letteratura continua a lavorare
dentro di noi.) Ma il non uccidere
vergato sul foglio bianco può non diventare il non uccidere su un campo innevato.” (p 191). A dispetto del suo
vitalismo, cercherà inconsciamente un proprio castigo: un periodo di Purgatorio (un Inferno limitato nel
tempo; si è riconosciuto delle attenuanti) nel reparto per individui ritenuti
pericolosi di un ospedale psichiatrico, trovando così il modo di vivere pure
lui la sorte toccata allo sfortunato e brillante fratello Venja, rovinato una
ventina d’anni prima da funzionari di regime che indagavano sull’arte
underground. La sua esuberanza e una punta d’insolenza giovanile si era
attirata l’ira di un personaggio suscettibile, a quei tempi autorizzato alla
piena libertà d’azione da un potere estremamente repressivo. Un po’ per
punizione dei delitti commessi un po’ per il desiderio d’identificarsi con il
fratello dalla mente distrutta rimasto incorrotto dalla vita e dalla Storia,
anche Petrovic prova la terribile esperienza di un io che a suon di pillole e
iniezioni viene “disciolto come nell’acido…” (p 403).
Come
tutti gli intellettuali Petrovic dispone
di un io ipertrofico, immerso in se stesso: “… io ero sotto terra, nel
sottosuolo dell’underground, chiuso a
doppia mandata in me medesimo…” (p 197), in più con la tardiva amarezza di
essere rimasto per sempre al palo (p
213). “Da me ci si può aspettare di tutto. Un guardiano, uno scroccone della
casalbergo, e nient’affatto un professore a domicilio (Zykov lo sapeva, lo
sapeva!), nient’affatto uno scrittore, e per giunta una nullità, uno zero, un
senza fissa dimora, ma… ma che non ha svenduto il proprio ‘io’.” (p 540) . “A
spaventarmi non era tanto l’idea di essere preso (prima o poi sarebbe successo)
ma di sentire calunniare la mia non facile esistenza, così amorevolmente
costruita, con gli epiteti di assassino, maniaco, schizofrenico, per loro due
più due… Dal loro punto di vista, non
avevo nessuna possibilità di uscire dal circolo vizioso. Nella loro variante migliore e più clemente
diventavo un caso clinico. Ma quale duello? Quale Puskin sulla neve? Un uomo
del Rinascimento? E poi cos’altro?...” (p 334). Infine vorrebbe uscirne, non ne
può quasi più di se stesso: “Ecco: avrei necessità di un’idea, un’idea nuova ed
efficace, ah, come ne avrei bisogno, qui e ora. Dovrei nuovamente (come l’altra
volta!) uscire dal mio soggetto. Come si esce dal vagone del metrò (continuate
pure senza di me). Come si cambia paese. Il mio ‘io’ si prendeva troppe libertà
(troppa autonomia), era opportuno imbrigliarlo e disciplinarlo. Troppo ‘io’ in
giro…” (p 334).
Diversi
anni prima ha smesso di lavorare, di far parte attiva di una società dove
troppi continuano a venire spossessati di se stessi per salire al mattino sul
filobus già stanchi prima di cominciare. Divenuto aghé lievemente inferocito, gli resta la preziosa capacità di
apprezzare la semplice ma ricca prosa della vita, come quando in una notte in
gattabuia pensa a Malevic. Nel Quadrato
nero di Malevic, riflette, da qualche parte fuori campo c’è la luna. “La
prosa della vita, devo ammetterlo, era dolce. Essa, come prometteva, donava
anche, tra le altre cose, un suono protratto e come eterno, che mi ninnava
l’udito con dolci ondulazioni ritmiche dell’aria. In parole più semplici si
trattava di un leggero ronfo. Il mio. Era l’esistenza stessa, avvolta nelle
fasce del dolce e suadente suono, a cullarmi. Dormivo. A distanza - come un’eco
– giungeva da dietro la porta il fresco, giovane russare del
druzinnik-piedipiatti, il nostro custode. Lui ronfava, io rispondevo. Prima e
seconda voce…” (p 87-88).
Pubblicato su Anobii il 12.12.2017
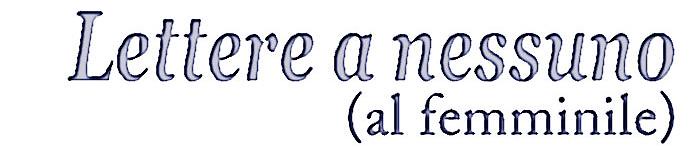
Nessun commento:
Posta un commento