Dopo l’intervista a Christian Tito, alcune domande ad Angelo Ferracuti, amico di Luigi Di Ruscio e curatore dell’edizione feltrinelliana di tutti i romanzi del 2014.
Angelo, tu sei un concittadino di Luigi Di Ruscio, operaio-poeta emigrato in Norvegia negli anni cinquanta e vissutovi fino alla scomparsa nel 2011. Sei riuscito a conservare con lui per lunghi anni un rapporto di reciproca stima e amicizia nonostante la lontananza. Vuoi raccontarci un aneddoto che ti piace ricordare della vostra lunga amicizia?
Ho conosciuto Luigi nel 1976, che ero un ragazzo, ma ne avevo sentito parlare sin da bambino perché emigrò con i miei zii a Oslo negli anni cinquanta, appartiene a un pezzo della mia mitologia famigliare. Cercavo una mia strada per la scrittura e a Fermo incontravo Luigi Crocenzi, il fotografo del Politecnico, Joyce Lussu, la traduttrice di Hikmet e una delle figure di spicco della Resistenza, e anche lui quando tornava d’estate dalla Norvegia. In quegli anni aveva pubblicato Istruzioni per l’uso della repressione da Savelli, la sua poesia era al centro di un forte interesse da parte dei critici maggiori. Non sempre con Luigi le cose erano facili, soprattutto sulle questioni legate alla politica e all’ideologia, aveva anche un carattere forte, ma sono riuscito a mantenere con lui sempre un rapporto molto franco e affettuoso, cresciuto negli ultimi anni. Nel 1987 feci il mio primo viaggio di nozze in tenda canadese in Scandinavia, e quando arrivai a Oslo lo cercai, con sua grande sorpresa, e poi lo raggiunsi a casa sua in via Aasengata 4c. Passammo insieme dei giorni molto belli, accompagnò me e mia moglie al Vigeland park, all’Orto botanico, nei suoi luoghi, insomma. Quel Paese mi affascinò moltissimo, e sette anni dopo uscì il mio primo libro, una raccolta di racconti, che si intitolava appunto Norvegia. Credo che se non ci fosse stato lui non avrei mai scritto quel libro, e la sua condotta – a uno come me che viene dal basso ed è arrivato alla letteratura per vocazione – mi ha dato sempre una grande forza. Me ne rendo conto solo adesso che sono passati tanti anni.
Ho conosciuto Luigi nel 1976, che ero un ragazzo, ma ne avevo sentito parlare sin da bambino perché emigrò con i miei zii a Oslo negli anni cinquanta, appartiene a un pezzo della mia mitologia famigliare. Cercavo una mia strada per la scrittura e a Fermo incontravo Luigi Crocenzi, il fotografo del Politecnico, Joyce Lussu, la traduttrice di Hikmet e una delle figure di spicco della Resistenza, e anche lui quando tornava d’estate dalla Norvegia. In quegli anni aveva pubblicato Istruzioni per l’uso della repressione da Savelli, la sua poesia era al centro di un forte interesse da parte dei critici maggiori. Non sempre con Luigi le cose erano facili, soprattutto sulle questioni legate alla politica e all’ideologia, aveva anche un carattere forte, ma sono riuscito a mantenere con lui sempre un rapporto molto franco e affettuoso, cresciuto negli ultimi anni. Nel 1987 feci il mio primo viaggio di nozze in tenda canadese in Scandinavia, e quando arrivai a Oslo lo cercai, con sua grande sorpresa, e poi lo raggiunsi a casa sua in via Aasengata 4c. Passammo insieme dei giorni molto belli, accompagnò me e mia moglie al Vigeland park, all’Orto botanico, nei suoi luoghi, insomma. Quel Paese mi affascinò moltissimo, e sette anni dopo uscì il mio primo libro, una raccolta di racconti, che si intitolava appunto Norvegia. Credo che se non ci fosse stato lui non avrei mai scritto quel libro, e la sua condotta – a uno come me che viene dal basso ed è arrivato alla letteratura per vocazione – mi ha dato sempre una grande forza. Me ne rendo conto solo adesso che sono passati tanti anni.
Una vita di lavoro, quella di Di Ruscio, che fu occupato per una quarantina d’anni in una fabbrica di chiodi. Spesso la fabbrica nelle sue poesie è descritta come una realtà molto pesante da sopportare, per diversi aspetti disumana, cui Luigi contrapponeva una grande vitalità e la sua purezza di cuore. Poteva bastargli una corsa in bicicletta e la contemplazione della natura per rigenerarsi dopo un turno di notte. A me pare che sia stato una persona con grandi doti di carattere. Sei d’accordo?
Nei tuoi reportage narrativi hai ancora trovato dei pezzi di quel mondo (imperniato intorno al lavoro di fabbrica di Otto-Novecento) e, se sì, quali impressioni ne hai ricavato?
Il lavoro per me è un tema politico ma anche esistenziale. Il primo racconto che ho scritto si intitolava Collocamento, era la storia di un ragazzo che chiusa l’esperienza politica dei movimenti giovanili degli anni settanta cercava un lavoro, un proprio posto nel mondo, il mio secondo libro era la storia di un camionista che ripercorreva la sua vita come in un lungo viaggio della memoria, nel terzo al centro della storia c’era un postino. Insomma, il lavoro è uno dei temi centrali del mio interesse intanto perché racconta tanti mondi diversi, realtà che interagiscono con l’attività umana tout court e ne costruiscono il destino e l’epica, e poi perché mette in luce tutte le contraddizioni e le trasformazioni di un’epoca, è specchio dei rapporti di forza tra produttori e lavoratori, tra poteri e cittadini, e ridisegna un po’ anche le antropologie. Se il legame sociale novecentesco, il legame di classe, ha creato una certa cultura del lavoro, oggi si assiste alla frammentazione e a forme di individualismo che vanno in una direzione opposta e contraria. Dai primi reportage a Monfalcone, legati ai morti per amianto nei cantieri navali, fino a quelli dei miei ultimi libri, mi rendo conto di aver raccontato la sconfitta e il declino di quel mondo, una rappresentazione spietata ma molto realistica della condizione umana di chi lavora oggi, che poi era quello che volevo fare ricollegandomi alla grande letteratura di reportage.
Anche tu, Angelo, hai dedicato buona parte della vita al lavoro. Prima di occuparti di scrittura, hai fatto per diversi anni il portalettere, raccontando poi l’esperienza in almeno due libri: Attenti al cane (Guanda, 1999) e Andare, correre, lavorare (Feltrinelli, 2015). Mi pare che per te il bilancio di quell’esperienza sia positivo.
Ho fatto diversi lavori. Operaio calzaturiero, venditore di cemento nei cantieri edili, poi di enciclopedie porta a porta, macchine per scrivere per una agenzia Olivetti, e per quindici anni il portalettere, un osservatorio privilegiato sulla realtà sociale che ha dato vita ad Attenti al cane, che ritengo il mio libro più riuscito, purtroppo ormai introvabile. Uscito da Guanda nel 1999, raccontava, e forse anticipava, le trasformazioni nella provincia italiana, che già allora cominciava a globalizzarsi; la provincia meccanica, quella americanizzata, la fine di quel mondo chiuso e claustrofobico, per certi versi idilliaco. Aver varcato le soglie delle case, aver potuto avere un rapporto di prima mano, percettivo, corporale, con una periferia tipica, certamente ha contribuito al mio lavoro di scrittura rigorosamente realistico. Esistono mestieri nella comunità con un tasso molto alto di conoscenza della vita degli altri, della meccanica sociale, e uno di questi è stato e resta quello del portalettere. Quando uscì qualcuno disse che raccontavo un paese irreale e che era solo una forzatura dovuta all’invenzione letteraria. La letteratura c’entrava, perché pensavo a libri come Winesburg, Ohio di Anderson, piuttosto che ad autori italiani, ma rileggendolo troviamo l’Italia di oggi che immaginavo quasi vent’anni fa. Potrebbe considerarsi quasi il prototipo di questo reportage Andare, camminare, lavorare. Il reportage narrativo credo sia una forma molto congeniale al nostro tempo e agli scrittori che si richiamano al realismo in letteratura. E’ un ibrido fatto di diversi materiali di senso, dove c’è la cronaca e la Storia, l’immaginazione del racconto e l’atto stesso del suo farsi. In una società sempre più virtuale ricostruisce sul campo anche lo spazio emozionale dei sensi, il corporale. L’esperienza della letteratura di reportage riesce a farci vedere ciò che è artatamente oscurato, va oltre la soglia dell’apparenza, cioè in profondità, ed è un grande esercizio di libertà. In Andare, camminare, lavorare ho usato questo Grande fratello naturale, come l’ho definito, per raccontare i luoghi dell’Italia, sei mesi di viaggi infaticabili dal nord al sud del paese. Ho cercato di andare dove l’immaginario dell’Italia era più forte, mettendo insieme luoghi eterogenei. Montagna e mare, provincia e aree metropolitane, anche alcune isole. Seguendo certo quelli che erano i desideri della mia immaginazione, ma anche tenendo conto dell’immaginario sociale, degli insediamenti culturali e industriali che più di altri fanno le identità e il conio complessivo del Paese, ma sempre fortemente suggestionato dalla presenza di alcuni scrittori italiani del Novecento che fanno parte della mia formazione che sono un po’ il file rouge del libro. Biamonti, BianciaMemorialerdi, Fenoglio, Mastronardi, Pasolini, Volponi, tanto per citarne alcuni. C’è poi l’Etna con tutta la sua straordinaria forza di natura, lo Zen di Palermo come luogo della periferia-mondo, la modernità di Milano, l’Hotel House di Porto Recanati, ma anche una Italia più remota e segreta, fatta di piccoli paesi, terre quiete come quelle molisane o marchigiane, le Dolomiti venete e le alture del Trentino. Tutti frammenti che messi insieme cercano di dare un’idea dell’Italia, oggi, dove è in corso un combattimento tra il naturale e l’artificiale, tra ciò che resta della società originaria e quella dello Spettacolo, in cui ogni atto della vita sociale diventa fiction. Sta avvenendo questo, il tentativo di omologare ulteriormente, tanto per usare un termine pasoliniano, globalizzare nell’accezione di una colonizzazione consumistica ulteriore. Il prevalere dello spettacolo sulla cultura, del consumare rispetto al riflettere che crea pensiero critico. Una nuova barbarie, insomma. Certo il bilancio di questa esperienza è stato positivo, o direi che ho fatto virtù di quello che la mia storia personale mi ha dato. Ma questo è sempre successo. Se Volponi non avesse fatto il capo del personale all’Olivetti difficilmente avrebbe immaginato libri come Memoriale, lo stesso vale per Pontiggia con La morte in banca, per Levi con La chiave a stella, per Ottieri e tanti altri scrittori che hanno usato l’esperienza autobiografica e l’osservazione sul campo per trasformarla in letteratura.
Passando invece a un aspetto delle cose più drammatico, hai affrontato un caso di morti sul lavoro nel libro edito da Einaudi Il costo della vita (2013), che narra la tragedia di tredici morti avvenute durante la normale manutenzione su una nave ancorata nel porto di Ravenna. Come nacque quel libro?
Il libro ebbe una storia editoriale piuttosto singolare, perché avevo raccolto i miei migliori reportage (libro che poi uscì da Alegre con il titolo I tempi che corrono) e il mio amico fotografo Mario Dondero mi consigliò di inviarlo a Roberto Cerati all’Einaudi, il quale lo girò a chi si occupava di narrativa, e non essendo un libro di narrativa finì nelle mani di Andrea Canobbio, editor della straniera e raffinato scrittore, ma anche curatore di una collana molto bella, Frontiere, il quale mi chiese se avevo voglio di isolare una di quelle storie per farne un libro. Mi ricordai di Ravenna e della strage della Mecnavi, pensai potesse essere una storia tipica, universalizzabile, una di quelle storie in grado di raccontarle tutte, di cui tra l’altro potevo avere maggiore nozione in quanto era accaduta in una città tipica della provincia e del centro dell’Italia, non troppo diversa dalla piccola città dove vivo. Così ho iniziato ad andare a Ravenna, all’incirca nella primavera del 2011. La più grande tragedia operaia del dopoguerra dopo la miniera di lignite di Ribolla, avvenuta nel 1954, che provocò la morte di 43 lavoratori (di cui avevano scritto ne I minatori della Maremma Luciano Bianciardi e Carlo Cassola) era accaduta dove nessuno se l’aspettava, non in una zona depressa del meridione d’Italia, ma nella Romagna “rossa”, nel cuore civile dell’Italia, dove c’era ancora il Partito comunista italiano, che aveva creato il benessere, la democrazia, un sistema di welfare da fare invidia al resto d’Europa; e il sindacato di sinistra, la CGIL, contava nella provincia quasi centomila iscritti, quindi con un controllo sociale da fare paura. E allora, pensai, se era successo a Ravenna, o anche a Ravenna, quella doveva essere la spia di qualcos’altro che andava oltre quella singola, seppure drammatica storia. Solo dopo due anni di lavoro, molti viaggi, e aver penetrato una intera comunità, intervistando i vigili del fuoco, i medici, i barellieri, gli infermieri, i cronisti, sindacalisti, i famigliari delle vittime, gli operai sopravvissuti, arrivai alla conclusione che in quel porto allora si era consumato uno scontro di civiltà del lavoro, e forse la fine di quel “contratto sociale” che è stato da Jean Jacques Rousseau in poi il fondamento della nostra democrazia. Due anni prima c’era stata la marcia dei quarantamila colletti bianchi alla Fiat, dopo lo sciopero dei 35 giorni, finito con una sconfitta drammatica del sindacato, di lì a poco sarebbe caduto il muro di Berlino, stavano declinando tutte le idee del socialismo planetario e con loro molte delle conquiste del Movimento operaio del Novecento. Insomma, in itinere mi convinsi che stavo scrivendo anche un altro libro – e questo succede quasi sempre quando si ha a che fare con i reportage -, un libro su un momento di grande trasformazione dell’Italia e del mondo contemporaneo. Credo quindi che è un libro con diversi livelli narrativi e di lettura, dove come sempre faccio metto insieme racconto tout court, inchiesta, repertorio storico, memorialistica, nell’intento di creare un ibrido complesso, che poi è la mia idea di reportage narrativo.
Nel tuo ultimo lavoro, Addio (Chiarelettere, 2016) le regioni sarde del Sulcis e dell’Iglesiente appaiono semiabbandonate e svuotate delle loro importanti attività estrattive, che ebbero tanto significato per quella regione e per l’Italia industriale e produttiva. La situazione si presenta oggi quasi più allarmante della fabbrica oppressiva del periodo fordista descritta da Di Ruscio e da altri autori dell’epoca dello sviluppo industriale. In fondo quella fabbrica, regolamentata da ritmi, turnazioni e precise norme sindacali, offriva riconoscimenti retributivi e morali che permettevano ai lavoratori di vivere, di mantenere una famiglia, di avere del tempo per se stessi e il rispetto della collettività, mentre la fine del lavoro paventata nel reportage narrativo sulla Sardegna mostra una desolazione di fronte alla quale al momento non ci sono risposte… O forse le risposte si potrebbero trovare, ma la classe dirigente non si decide a prenderle in considerazione?
Addio ha molti significati. E’ la fine di un mondo, quello postindustriale, è un punto di non ritorno non solo per il Sulcis-Iglesiente, la zona dell’Italia più dimenticata che oggi è anche quella che soffre maggiormente per la mancanza di lavoro, ma per l’Europa che vive la crisi creata da un capitalismo sempre più vorace e mobile, che delocalizza e precarizza in un mercato cannibalizzato. A Carbonia, a Iglesias, è evidente la fine di un mondo, di una civiltà del lavoro, se così possiamo chiamarla. Dopo oltre un secolo di sfruttamento, di violenza sull’uomo e sul suolo, resta solo disoccupazione, inquinamento, povertà, una parte del paesaggio sardo martoriato dall’attività estrattiva, deprivato dalle servitù militari. E’ lo stato delle cose del neoliberismo, con un aspetto inquietante, cioè la totale assenza o impotenza della politica. E poi pensavo alla struggente canzone di Domenico Modugno e all’emigrazione di ritorno, cioè ai giovani del meridione che hanno ricominciato a partire.
Non so se il libro ha un valore letterario, questo non sta a me dirlo, però sicuramente ne ha uno documentario, un po’ come le straordinarie foto di Patellani scattate nel Sulcis nel 1950 che raccontano un momento della Storia. Volevo fare un libro come quelli dei grandi reporter americani della crisi, raccontare un momento difficile della vita di una comunità, uno spaccato visto dal di dentro, vissuto in presa diretta. Ne viene fuori qualcosa secondo me di emotivamente molto forte: impoverimento sociale e dignità, voglia di lottare e impotenza, e poi molta solitudine. A parte il sindacato, i preti della Caritas, la solidarietà spontanea, molte delle persone con le quali ho parlato si sentono abbandonate, soprattutto dalla politica. La letteratura non può dare risposte, purtroppo, ma ricostruire quello che chiamo il racconto onesto, lo stato delle cose, soprattutto facendo affiorare l’invisibile.
Nell’ultimo capitolo del libro, facendo un viaggio in Islanda dove si trova una fonderia dell’Alcoa come quella di Portovesme, non solo cerco di collegare in un comune destino queste due isole meravigliose e selvagge, ma dimostro come con l’avvento della globalizzazione dei mercati agiscono le multinazionali. Qui se ne sono andati dopo aver avuto aiuti di Stato per molti anni, inquinando e lasciando a casa senza lavoro i suoi operai. Il mio conterraneo Paolo Volponi le chiamava Le mosche del capitale, che è anche il titolo di un suo celebre romanzo. “Le sapienti colorate voraci mosche del capitale”. Lo Stato ha delegato al mercato, tutto è regolato dal mercato, e il mercato non possiede un’umanità, un’etica, la sua unica prerogativa è il profitto.
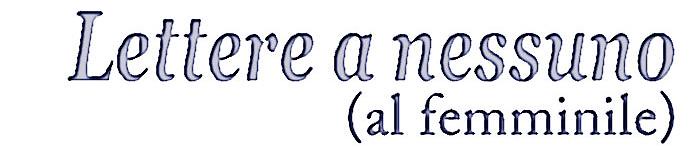
Nessun commento:
Posta un commento