Cartongesso di
Francesco Maino (Einaudi, Torino 2014): ecco un romanzo di quelli che hanno il
fuoco dentro. Questo fuoco è la rabbia, una furia polemica che colpisce a
raffica la categoria degli avvocati, di cui il
protagonista narratore fa parte, il suo ambiente, la cittadinanza, i politici
locali, la piega che ha preso la politica negli ultimi decenni, in modo
particolare nella regione Veneto ma in generale nell'Italia tutta, chiamata qui
spesso e volentieri Itaglia, con
allusione alla sua ignoranza atavica, alla sua degenerazione totale.
Il
protagonista ci fa sapere fin da subito che, collaterali alla sua principale attività
lavorativa, ha svolto altri lavori al fine della sopravvivenza fisica e morale,
tipo l'aiuto-becchino. Questa comparsa, nelle prime pagine della morte vista in faccia, ci introduce in
un contesto angoscioso e tragico.
Durante
il romanzo il protagonista, la morte, la invocherà addirittura, per sé o per
altri, talmente gli pare pesante la situazione che deve sopportare giorno dopo
giorno immerso in una realtà che lo disgusta.
Innanzitutto
veniamo a sapere che nella sua professione di avvocato, combatte
battaglie non sue e ha già perso invece la sua propria guerra. Combatte
sostanzialmente per far avere permessi di soggiorno ai clandestini con diritto:
"Litigo furiosamente per un niente,
non credo in niente, mi batto per qualcosa che non so, per un tutto che si
chiama e si dice laleggeèugualepertutti
(…) con coraggio costituzionale, credo, con il mio stile rabbioso, senza
scorciatoie, a viso aperto, poche parole, parole franche, a mani nude, ardito
sui generis, a modo mio. Avvocato analfabeta di prima linea, ragazzo della
Piave, senza lesinare energie, senza furbizia precoce, senza elmetto, mi
conquisto tre (3) foglie dignitose
messe insieme e ricevute dai clienti irregolari o clandestini, i soldi del
soldato…" (p 38). Oppure combatte per farli uscire, quando possibile, da
un carcere-tortura orrendo, com'è a quanto pare il carcere ai giorni nostri.
"Il sistema penitenziario è la dimostrazione precisa che la pena detentiva
ha fallito. Esso produce e conserva odio, spirito vendicativo, frustrazione,
cattiveria primitiva. Non ha alcuna efficacia riabilitativa, non punta a
evitare recidive. Punta a rinforzare gli assassini. Rincuorare le merde. (…) Le
carceri sono tritacarni arrugginiti, solo che il macinato che se ne ricava è,
per l'appunto, un macinato umano di cui la macelleria Zottarel non riuscirebbe
a piazzare un solo etto nemmeno tra i cannibali più affamati della terra. (…)
Io, stringi stringi, sto dalla parte dei detenuti per partito preso, mi sento come loro, son come loro (…) Il reato
che hanno commesso è quello che penso di poter compiere anch'io, un giorno o
l'altro, non tra molto, sono ladro in potenza, assassino in potenza, ladro per
fame, assassino per giustizia." (p 102).
Il senso di esclusione era emerso già dai tempi dell'università: "Sentivo che la città mi trattava come pezzente balbettante, un rifugiato, un estradato, ogni palazzo mi pareva l'occhio di Polifemo, mi sembrava di dover dire a tutti quei palazzi di Bologna il mio nome è Nessuno." (p 173).
L'identificazione
con gli esclusi ha la sua ragione sociologica nella disfatta di una
generazione: "… altri sceglievano
al posto nostro, scrivendo le regole dell'orizzonte
orrendo che ci siamo trovati a occupare senza titolo, è troppo tardi, amici
miei (…) troppo stanchi ora, troppo soli ora, troppo impreparati per imparare a decifrare la lengua del mondo novo,
difendersi dagli zulu balbettanti del mondo nuovo, dai velocisti del
tablet…" (p 60-61); e ancora: "… odio reattivo, prognosi riservata,
per le menzogne che hanno raccontato a una generazione doppia, la mia, una
generazione educata alla fiducia, alle regole. A vent'anni devi prenderti il
mondo col badile, invece! Te lo devi prendere a sprangate, coi morsi, se non lo
fai, se ti fidi, a quaranta sarai sagoma di cartapesta, ammasso d'ossa
contributive…" (p 61). Infine viene dichiarato letteralmente: "dopo
aver dato battaglia, e perso la guerra." (p 74), là dove prende forma il desiderio
di morire per la sconfitta.
Dal
desiderio di morire a quello di uccidere il passo è breve: "… non devo
dimostrare niente a nessuno eppure mi dispero, mi monta la rabbia, mi prende la
scabbia, son lì che mi dispero per tutte le volte che avrei potuto ascendere e
non l'ho fatto, tutte le volte che avrei voluto uccidere e non l'ho fatto, dire
ciò che pensavo, metter la bomba o fuggir via di qui, via dal Tribunale immondo
del Giroconto…" (p 141); "… son sempre più colpevole, più punibile,
più rinviabile a giudizio, i reati del codice son tutti a me ascrivibili…"
(p 142).
Il
mondo umano circostante è piatto e pragmatico, terribilmente brutale e avido.
Le scene di pasti animaleschi sono numerose, come se tutti indistintamente fossero
dominati da una pulsione orale pantagruelica. In
particolare i colleghi avvocati "… son varani verticali con la lingua a
forma di lametta e la parola alla stricnina, affamati di carcasse o derelitti
umani da ripulire, lentamente, cinicamente, codici alla mano…" (p 134).
Egli è
un animale ferito incapace di reagire: "Penso che hanno ragione loro: sono
solo un avvocato, un animale affamato, ferito e disperato, ma affamato di cosa,
ferito da chi, disperato per cosa?" (p 96). E qui si scende a uno strato più
profondo del romanzo, dove si allude a un complesso materno che lo ha
trattenuto in patria, quando tanti suoi ex compagni di scuola sono fuggiti
appena possibile. (Quest'allusione più intimista a un personale complesso mi conforta nell'opinione che la letteratura sia fatta più dai complessi che dai traumi.) Per lui la fuga prende la forma di un'allucinazione di
rastrellamento e deportazione: "… ho la sensazione che in qualunque
momento potrebbero venire a prendermi, i clienti ostili, i detenuti infingardi,
le guardie terrone, i cancellieri obesi, i figuranti della giustizia, la cassa
forense, i colleghi topi, i praticanti, il capo della penitenziaria, i giudici
affermati di Venessia e tutti quelli con la stessa divisa (…) Il rastrellamento
è sotto il mio studio, effettivamente, sento le voci metalliche del Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Venessia (…) che seleziona le braccia migliori, divide
i vecchi dai giovani, gli uomini dalle donne, i fratelli dalle sorelle, i
civilisti dai penalisti, chi lavora lavora, Arbeit
macht frei, chi non lavora muore, chiama il mio nome, col megafono, prego favorire generalità e specializzazione
(…) parto per un posto misterioso di confine, tra Romania e Moldavia, così
dicono, non faccio in tempo a salutare la mia famiglia, ciao amici, finalmente
parto, lascio il paese, Insaponata, l'Itaglia, parto, mi deportano, non torno
più. Grazie al cielo." (p 109). Deportazione che diventa, persino quella,
una liberazione.
L'aspetto
più inquietante è che non c'è possibilità di rivolta. "Hanno fatto di me
un complice debole. (…) siamo una popolazione di schiavi, di voltagabbana, io
per primo." (p 180).
Il
lamento è tanto più comprensibile, condivisibile, quanto più la situazione è
bloccata. E quella dell'Itaglia/Italia pare davvero senza uscita.
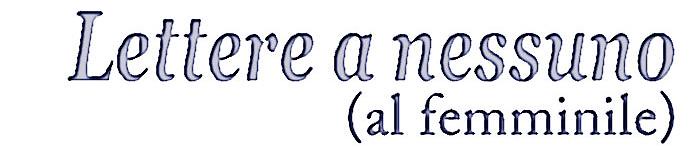
Nessun commento:
Posta un commento