Dei
grandi traumi, magari accaduti in epoca remota e infantile, è difficile parlare
perché il linguaggio con cui narrarli risulterebbe presumibilmente alterato,
sconnesso, lacunoso, minacciato da amnesie e rimozioni, poco razionale,
difficilmente referenziale. I grandi traumi si prestano idealmente al racconto
spostato, camuffato e deformato della narrativa, dell'invenzione, della
"menzogna" letteraria.
Al
contrario dei piccoli traumi, di cui forse è costellata la vita di molti, si
può parlare in maniera più disinvolta. Il mio piccolo grande trauma dell'età
adulta è stato il lavoro. Ebbi un licenziamento, o meglio un'interruzione
improvvisa del rapporto di lavoro, emotivamente quasi paragonabile, per come la
vissi personalmente, a un licenziamento in tronco, a ventinove anni, dopo due
anni che lavoravo stabilmente, continuativamente in una casa editrice. Mi si
disse semplicemente che non si aveva più bisogno di me da un momento all'altro.
Non ero regolarmente assunta, ma una collaboratrice che si recava in sede tutti
i giorni e faceva orario d'ufficio come se fosse assunta allo stesso modo degli
altri, fatto un po' anomalo ma non poi tanto se confrontato con la vasta gamma di
particolarità offerte dal lavoro irregolare che contraddistingueva l'editoria
già nel passato. La mia situazione era sempre stata "appesa a un
filo", tuttavia con le speranze tipiche dei giovani pensavo che le cose si
sarebbero sistemate col tempo, nonostante avessi assistito pur in quel breve
periodo a un caso di licenziamento vero e proprio, e fossi al corrente del
fatto che il settore editoriale era già in piena ristrutturazione, con la
progressiva esternalizzazione di redattori approdati prematuramente alla
pensione o decisi a mettersi in proprio, che avevano costituito services editoriali e continuavano a
lavorare a pieno ritmo con l'azienda. Anni novanta.
La
perdita del lavoro da un giorno all'altro, il brusco allontanamento dall'ufficio
così su due piedi una mattina che avevo creduto uguale alle altre, fu per me
invece qualcosa che non mi aspettavo e che provocò dolore, rabbia e pensieri
furiosi. Lo stato di abbattimento originatosi alcuni anni prima, in occasione
di un altro piccolo grande trauma, la fine dell'università, si andò accentuando.
Ma perché parlare di trauma anche per la fine degli studi? Forse che la fine
delle età della vita (il finire dell'infanzia, il finire dell'adolescenza) è necessariamente traumatica? No di certo, si tratta di tappe ordinarie. Nel mio caso il termine del periodo
universitario degenerò in episodi un po' più conflittuali negli anni successivi
per via dell'incontro, tutt'altro che dolce e consequenziale rispetto alla
preparazione conseguita, col mondo del lavoro.
Ricordo
che il giorno di laurea, invece di essere allegro e festoso come nella maggior
parte dei casi, per me fu tristissimo, perché capivo che finiva ormai
definitivamente il periodo degli studi. Le collaborazioni editoriali avevano
cercato di sostituire, unite a un certo spirito d'adattamento, ai miei occhi
ancora inconsapevoli del grande divario esistente fra mondo dei libri e mondo
della realtà, gli studi universitari.
Una
psicanalista che conosco ha asserito che il più delle volte nella vita delle
persone non c'è un unico grande trauma bensì tanti piccoli traumi, un insieme
di traumi che nel loro accatastarsi confuso o pressante, nel loro combinarsi e
ricombinarsi, rinforzarsi e richiamarsi a vicenda, finiscono per determinare il
nostro comportamento, anche sbagliato, autolesionistico eccetera eccetera.
Naturalmente lei intendeva piccoli traumi nel periodo canonico della crescita,
con tutta probabilità non si riferiva a quelli dell'età adulta, quando
l'individuo è più corazzato... E naturalmente l'età adulta è quella che si
raggiunge a fatica o forse mai…
Precedente
alla serie dei microtraumi lavorativi e metropolitani, c'era stato il
trasferimento dalla natale città di provincia alla metropoli suscitatrice
d'illusioni. La quale, avvenuta dopo i venticinque anni senz'accompagnamento o
seguito di alcun parente, si può definire anch'essa qualcosa di mini, una
migrazione in piccolo. L'abbacinamento della grande città suscitatrice di sogni
c'era tutto, le promesse culturali da parte della capitale italiana dell'editoria
si potevano ancora intravedere dalla distanza di una piccola città, la volontà
di lavorare nel mondo dei libri era forte, almeno al punto da cancellare tutte
le altre più concrete possibilità di trovare lavoro. Sennonché, dopo alcuni
anni di precariato redazionale, le cose dovevano cambiare drasticamente. Ed
ecco il ripiego su un posto fisso senz'alcuna relazione con gli studi, le
passioni, gli interessi maturati durante l'intera, seppur giovane, esistenza. Come d'altra parte accade a molti, mi sono smarrita nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Non sono riuscita trovare un lavoro che mi corrispondesse. Uno strappo simile a quello delle lucertole, che per sopravvivere in molti casi sacrificano la coda. Io ho sacrificato un po' più della coda; metà delle mie giornate dedicate a un lavoro d'ufficio che non mi ha mai interessato.
Quale
fu la conseguenza? Una consapevolezza più profonda, forse, di come funzionano i
rapporti sociali, così come un peggioramento del carattere.
A
seguire, col peggioramento del carattere causato in larga parte, credo, dalle
frustrazioni e dal disagio lavorativo, microconflitti quotidiani in ufficio e per
la strada, in metropolitana piuttosto che alla fermata dell'autobus; conflitti
infinitesimi, spiccioli, nati da cause per molti versi trascurabili,
passeggere, ma che potevano portare, ognuna, nella degenerazione del momento,
perfino a brevi colluttazioni, al pericolo di danni più seri. La scintilla? Spesso
il fumo: il dover respirare il fumo degli altri o il gas di scarico di qualche
auto e moto in divieto.
Col
senno di poi, o semplicemente col senno, sorge spontanea la domanda perché io
non abbia mai insegnato, considerato che una laurea comunque l'avevo e invece a
un certo punto è stato come se non l'avessi mai conseguita e mi trovassi a
cercare lavoro, a un certo punto della mia vita, come chi non possiede alcun titolo
di studio, presso le agenzie immobiliari piuttosto che nel campo delle vendite.
Ci fu anche questo, ed è strano se messo in relazione ai molti casi di laureati
che, facendo esperienze diverse un po' come me nel mondo editoriale o
pubblicitario o giornalistico, sono riusciti comunque a ripiegare in seconda
battuta sull'insegnamento.
La
risposta purtroppo affonda nella notte dell'inconscio e resta in parte, per me,
inafferrabile. Una spia di verità più profonde potrebbe essere che mia madre
era un'insegnante, una maestra, che iniziò a lavorare proprio appena dopo la
mia nascita. La nascita delle figlie, prima mia poi di mia sorella, anziché
produrre il moto esattamente contrario come per la maggioranza delle donne, cioè
più tempo dedicato alla famiglia, indusse mia madre a cominciare a lavorare. Ho
ancora vaghi ricordi di gelosia infantile nutrita anche per gli alunni di mia
madre. Un'altra radice profonda può essere legata al fatto che vissi fin da piccola
lo studio come rinuncia ad altre cose importanti per i bambini, prima fra tutte
il gioco. L'interesse per alcune materie, che era molto sostenuto e
incoraggiato dalla mamma, pur appassionandomi fin da piccola, riduceva il tempo
del gioco; ero quindi consapevole che mi toglieva qualcosa, molto.
Fondamentalmente non mi sono mai sentita né mi sentirei di chiedere a qualcuno
di rinunciare al gioco, alla vita, per studiare di più. Se lo studente riesce a
dedicarsi agli studi con equilibrio, bene per lui e per tutti; ma è
dall'allievo appunto che deve partire il desiderio o la decisione d'imparare. Su
questo sono pienamente d'accordo con quanto sentii affermare da Sanguineti
stesso, mio professore all'università: non si può insegnare nulla, si può solo
imparare. Il desiderio d'imparare è tutto e non si poteva certo dire, almeno
per quella che era stata la mia esperienza, che il sistema scolastico fosse
organizzato per suscitare e incoraggiare questo desiderio. A me e a molti
altri, almeno stando ai risultati, balzavano agli occhi tutte altre evidenze:
l'educazione al comportamento passivo, l'abitudine a uno stile di vita dettato
da obblighi e coercizioni, la divisione netta che s'imponeva fin dall'inizio
fra le classi sociali...
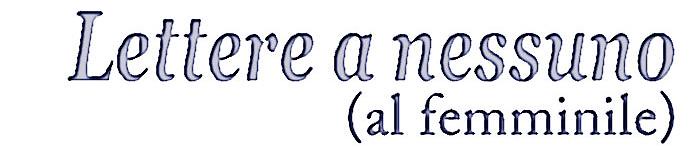
Nessun commento:
Posta un commento