Spioveva. Le ultime gocce cadevano cerchiando pozzanghere quasi placate. Stefano camminava da una ventina di minuti lungo la banchina, le scarpe impregnate d’acqua, i pantaloni fradici dal ginocchio in giù. Attraversava la piazza e saliva oltre le ultime case, per ridiscendere e portarsi fino all’attracco del piroscafo, sotto le mura del penitenziario, nell’aria umida del mare e negli aghi di freddo che attraversavano gli abiti per toccargli le ossa. Aspettava. A tratti guardava nel nero che stava soffocando la baia. Quando smise del tutto di piovere chiuse l’ombrello, lo scrollò mandando un ventaglio di gocce a rompere le altre che brillavano sopra le piante di una fioriera. Le luci dei lampioni, fredde, facevano piccole quelle dei negozi e delle insegne, e smorzate le poche che doravano le finestre delle case; e facevano più scuro il mare, candida la schiuma che si perdeva nella sabbia della spiaggia, sotto la piazza.
Il piroscafo, entrando nella baia, puntava il centro dell’abitato e virava, accostava il babordo alla banchina con le macchine a basso regime, mentre l’ormeggiatore raccoglieva le cime che gli venivano lanciate e le assicurava alle bitte. Quella sera il piroscafo stava tardando, fuori doveva esserci mare, già oltre il molo per tutto il pomeriggio era stato un ribollire di creste di schiuma. Sull’isola il piroscafo veniva chiamato vapore, in ricordo dei tempi in cui i pennacchi di fumo nero si levavano dalla linea dell’orizzonte, e significavano legame con il continente. Trasportava ancora le merci e le automobili dei turisti. La gente libera da tutto, invece, preferiva la velocità degli aliscafi.
Anche i detenuti destinati al penitenziario viaggiavano sul piroscafo. Gli abitanti dell’isola li chiamavano ergastolani, nonostante il termine avesse perduto il proprio significato, memoria di quando l’ergastolo significava ergastolo e non c’erano santi, morte fra uomini di quella compagnia, per chiudere una vita ridotta al susseguirsi meccanico di gesti e pensieri senza ali.
All’epoca dei primi ricordi di Stefano sull’isola si arrivava con una corvetta adattata all’uso civile, grigia, il nome Pola che nereggiava a poppa. I membri dell’equipaggio venivano per lo più da Trieste, avevano la mente occupata da un incubo chiamato Tito, bastava attaccare discorso per sentirsi ripetere che loro con la Iugoslavia non sarebbero andati neanche morti. Gli altri passeggeri si accorgevano della presenza degli ergastolani attraverso quella dei carabinieri di scorta. I militari vegliavano davanti a una cabina che dava sul ponte, il moschetto in spalla. Intorno avevano gente che tornava da una puntata sul continente e, nella bella stagione, qualche turista, pesce pilota degli altri che avrebbero arricchito l’isola e fatto nascere negli abitanti la smania di fare a pezzi un paesaggio insostituibile, per sostituirlo con un altro che sembrava di tutti senza appartenere più ad alcuno.
A quell’epoca gli ergastolani uscivano dalla cabina uno alla volta, i capelli tagliati cortissimi, la divisa a strisce. Sbarcavano per ultimi con le catene ai polsi, i militi li sostenevano sulla passerella, li aiutavano a salire sopra la camionetta che li avrebbe portati al penitenziario. Il penitenziario dominava l’abitato dall’alto, i bastioni antichi affacciati sul porto. Ai tedeschi, durante l’ultima guerra, doveva essere sembrato il migliore dei luoghi per arroccarsi. Con gli ergastolani non erano andati per il sottile, li avevano fucilati tutti. Dopo qualche tempo il peggio del peggio, portato dall’orda dei marocchini, cadeau della Francia che non perdonava all’Italia la coltellata alla schiena del ‘40. I tedeschi avevano resistito a lungo, come soldati niente da dire. A cose fatte i marocchini s’erano messi a giocare con le loro teste, prima di lanciarsi sulla popolazione e farne scempio. La gente di là evitava di parlarne, cose vecchie, medicate dalla buona farmacopea di sole e mare e progresso e benessere.
Stefano, sbarcando per la prima volta sull’isola, dalla passerella del vapore aveva visto con i propri occhi di bambino preso dalla fantasia un quieto allinearsi di costruzioni basse rosate dal tramonto, poche persone e qualche militare, e un gatto nero e bianco seduto sulla soglia della palazzina che stava esattamente di fronte, a pochi metri. Non conosceva altro mare che non fosse quello distillato dalle pagine dei libri di avventura sul suo saper sognare, il tanto doverlo vedere della traversata gli aveva caricato i sensi. Immaginò pirati. Scrutando le mura della fortezza cercò il conforto di bocche da fuoco puntate sulla baia. Rimase deluso. Se i pirati arrivassero in piena notte chi li vedrebbe, come fanno a dormire tranquilli i poveracci che abitano qua davanti, pensava; e aspettando il proprio turno per sbarcare riguardava le case, e il gatto che restava seduto davanti alla soglia della più vicina come aspettasse qualcuno. Ancora non sapeva che sarebbe toccato a lui dover fare i conti con certi timori notturni, visto che la meta del suo viaggio era proprio quella palazzina, come le poche altre vicine esposta a tutto; e ancora non sapeva che il gatto nero e bianco, dormendogli fra le gambe, gli avrebbe fatto da sentinella. Teneva per mano Lucia, di un paio di anni più piccola, fra i genitori provati dall’ombra dell’ultimo bisticcio e dalla quantità dei bagagli. Avrebbe finalmente conosciuto i nonni materni, nel progetto di riappacificazione costato alla mamma un lustro di tensioni e negoziati, a riprova del fatto che i conflitti familiari possono lasciare cicatrici difficili da mascherare. Indicò il gatto a Lucia, disse guarda che bello. Lucia si trovava coperta dalla gente intorno, non vide il gatto e non vide nulla. Immusonita disse uffa, disse quand’è che arriviamo, disse voglio tornare a Milano. Mentre il gatto, vai a sapere cos’hanno dentro gli animali, lasciava la soglia calda di ultimo sole, attraversava guardingo i passi delle persone, sfiorava con il lucido del pelo il copertone di una delle ruote della camionetta in attesa degli ergastolani, e a coda diritta arrivava a strusciarsi sulle ginocchia di Stefano come lo conoscesse da sempre, incurante di Lucia che gridava mamma ho paura, mamma mi graffia.
Stefano, allora, del mare sapeva meno che nulla. Appena arrivato in spiaggia s’era messo a correre sopra i lastroni di pietra lambiti dall’onda e coperti di alghe viscide, finendoci crocifisso e ricevendone una botta alla nuca e nella schiena di quelle che, in epoche dalla mescola più languida, avrebbero portato al pronto soccorso. La sera dello stesso giorno, dal balcone del salotto, aveva visto per la prima volta gli ergastolani che scendevano dal vapore, per la gente di lì un’attrazione.
Pochi giorni di quieto adattarsi, solo l’amaro delle prime incomprensioni fra gli adulti e le avvisaglie delle discussioni che ne sarebbero nate; e, all’improvviso, nel punto stesso dove si trovava in quel momento ormai uomo con tanta vita dietro le spalle e non delle più facili, era arrivata la svolta nel suo concepire il mondo. Il ricordo lo fece rabbrividire. Il suo modo di sentire: un brivido lungo la schiena, estenuante come una scarica elettrica. Quanto tempo è passato, com’è cambiata ogni cosa qua intorno. Ma la bitta, questa bitta; e la guardava senza osare neppure sfiorarla con la scarpa, o con la punta dell’ombrello.
Un peschereccio aveva catturato una tartaruga di mare. Una bestia grande, vitale, che tentava di arrancare con le pinne inermi sulle tavole del ponte, l’espressione severa e risentita e dolente di quegli occhi che sembravano avere visto nascere il mondo. Le tagliarono la testa. Per tagliargliela l’appoggiarono sul bordo della murata, al cospetto della gente accorsa. Stefano stava in piedi sulla bitta, vide il povero viso di pappagallo triste gridare senza suoni nello strazio, le pinne battere frenetiche l’elemento estraneo dell’aria, il torrente del sangue precipitare sulle mani degli uomini e sulla murata e sul mare, che se n’adombrava facendosi colore del vino.
Quella notte Stefano avvertì per la prima volta i brividi della febbre improvvisa e altissima e fugace che gli avrebbe segnato certi momenti della vita, e per la prima volta sentì la stretta intorno all’esofago. Nel delirio vide un grande veliero carico di vele uscire da un infinito di fumo bianco. L’indomani mattina, mentre ripigliava i sensi nelle lenzuola ghiacciate dal sudore, distinse intorno a sé l’animazione della novità.
«La nave scuola, la nave scuola!» sentì gridare.
Lucia irruppe nella camera, si mise in punta di piedi per spingere le persiane socchiuse, gli disse corri a vedere. A lui bastò inginocchiarsi sul letto. La nave scuola stava entrando nella baia, ancora carica di vele.
«L’ho già vista» disse senza sorpresa, perché si trattava della stessa nave che aveva appena sognato.
La nave scuola si chiamava Ebe. Non avrebbe navigato ancora per molto, le navi invecchiano presto. Sarebbe finita nel Museo della Scienza e della Tecnica, a Milano. A volte Stefano tornava a vederla. Tolta all’acqua, sembrava ormai un espediente scenografico permeato dall’odore di polvere spessa, tanto diverso da quello di buon legno bagnato e salmastro e mare che Stefano e Lucia avevano respirato visitandola da bambini. Nulla a ricordarle la vita, in quel padiglione luminoso e soffocante dove stava rinchiusa fra altri cimeli spenti.
Stefano tornava a guardarla in occasioni particolari, quando avvertiva troppo forte in sé il bisogno di pensare pensieri risolutivi. Bastava il primo sguardo, e una mano rapace lo prendeva all’esofago, il guizzo del brivido di certa febbre gli percorreva la schiena. Per coincidenza singolare la nave scuola aveva attraccato nel punto in cui era stata decapitata la tartaruga, una delle poderose cime era stata avvolta intorno a quella stessa bitta, che dopo trent’anni rimaneva uguale e senza memoria.
Raccolse l’ombrello. Sotto la luce metallica dei lampioni che facevano sciabolare d’argento le pozzanghere tornò verso l’imbarcadero, dove di lì a poco sarebbe arrivato il vapore. Non si trattava più della vecchia corvetta Pola, con quell’equipaggio di triestini gioviali che ancora non sapevano che fine avrebbe fatto la loro città, e cosa sarebbe accaduto a loro stessi. Il nuovo vapore era una grande nave candida che prendeva il mare correndo. Gli avrebbe portato Lucia.
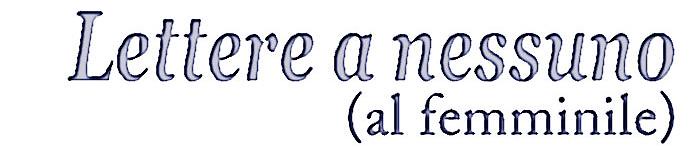
Nessun commento:
Posta un commento