Alcune
osservazioni illuminanti esposte in chiave saggistica si trovano in un testo di
Vitaliano Trevisan, Tristissimi giardini,
(Laterza, Roma-Bari 2010), dove conurbazioni denominate periferia diffusa, che occupano sempre più spazio oggigiorno
rispetto a quella che avrebbe dovuto essere una brillante città diffusa, si presentano come qualcosa di contraddittorio e
incoerente che genera disagio pure in una giornata limpida osservate dall’alto:
“Osservando
la periferia diffusa, anche in un giorno così limpido, la vista si offusca, la
ragione vacilla. Cercare di coglierla nel suo insieme ci sembra un non senso.
Non si può descrivere una forma che non si fissa nel tempo, né inscrivere in un
sistema di relazioni coerenti una conurbazione che ha perso per strada i suoi
tradizionali riferimenti. Al loro posto troviamo frammentazione,
parcellizzazione, successione casuale, sovrapposizione altrettanto casuale.
Riconosciamo una serie. Un’armonia sembra nascere, ma subito si interrompe; né
si trova continuità nella dis-armonia, dato che anch’essa si interrompe.” (p 135).
Un
embrionale senso d’angoscia è qui legato all’estraneità e allo smarrimento di
fronte a luoghi che dovrebbero apparire familiari ma non lo sono più. Allo
smarrimento si aggiunge un senso di abbandono e di degrado: “… in questa
grandissima periferia policentrica che non ha coscienza di sé, tutto è pensato
a pezzi, e fatto e rifatto a pezzi (…) il processo di frammentazione continua
senza sosta, con la stolidità, la sciatteria e la mancanza d’amore, se si eccettua
quello per il denaro…” (p 17).
Da
chi sono abitati questi luoghi?
“(…)
mi rendo conto che la città e la provincia – e la mia strada – sono piene di
vecchi che si tengono aggrappati con tutte le forze a quel poco che hanno: la
casa per cui hanno lavorato tutta la vita, l’orto, il giardino, e una serie di
abitudini che fanno riferimento a un mondo che si va estinguendo con loro (…)
Non deve perciò stupire questo attaccamento alle cose…” (p 59).
“Il
sospetto che l’industria pubblica produca vecchi malati – semilavorati -, per
poi immetterli nel mercato sanitario cosiddetto privato, non è infondato:
cliniche, centri diagnostici, di riabilitazione, convalescenziari eccetera,
sembra un mercato in cui di privato c’è solo il guadagno.” (p 67).
Da
tali osservazioni inquietanti all’incubo il passo è breve. Tant’è vero che in
una pagina di Ugo Cornia più o meno degli stessi anni quel paesaggio fatto di
strade a lunga percorrenza, rotatorie, svincoli, lontano dai centri abitati,
quasi totalmente privo di segnaletica e di presenze umane, nel dormiveglia,
diventa l’anticamera dell’inferno: una catabasi nel territorio cementificato,
un digradare verso un fondovalle che allude a un progressivo degrado, per una
strada tortuosa, priva di indicazioni, distante dai centri abitati, che pare
condurre soltanto a capannoni industriali con merci accatastate, unicamente
percorsa da camion che non si fermano:
“Spesso mi immaginavo che morire sia più
o meno come partire da Monte Babbio (un paese di tre case dove abita un mio
amico), in una situazione di luce come quando sta finendo la notte, prendere
una stradina asfaltata in discesa in mezzo ai boschi di quercioli, tutta a
curve, e scender giù in discesa verso la valle, aspettando che la luce arrivi.
Scendi per cinque o sei chilometri fino a quando non arrivi a una strada più
grande, e lì dopo altri tre chilometri iniziano a esserci delle rotonde e degli
svincoli lunghissimi dove passa lentamente qualche camion. Allora uno
cercherebbe delle indicazioni per sapere dov’è andato a finire e capire fin
dove deve arrivare, ma passano soltanto questi camion che vanno via dritti e
non c’è nessun altro. Tu allora continui a seguire la strada più grande, dove
continuano a passare questi camion, e la segui finché non arrivi a un ponte su
un fiume. Decidi di fare il ponte, che è lunghissimo, e vedi che sotto ci passa
il fiume e che l’alveo del fiume ha quell’aria a metà tra i lavori in corso e
il lasciato andare, con dei sassi e qualche spelazzo di piante rinsecchite, e
cammini e cammini sul ponte che durerà più di un chilometro, mentre continuano
a passare i camion. Poi quando hai finito il ponte ti troverai davanti ad altri
svincoli e a delle altre rotonde. Allora vai giù per uno svincolo, che passa
attorno a dei grandi pioppi, e di colpo ti accorgi che sei dentro una specie di
agglomerato urbano, vedi che c’è anche una ferrovia e percorri il marciapiedi
che costeggia la ferrovia fino a quando sulla destra c’è un sottopassaggio
pedonale che passa sotto le rotaie. Visto che non sei ancora riuscito a parlare
con nessuno perché passavano soltanto dei camion che andavano abbastanza
spediti, decidi di andar giù per il sottopassaggio.” Il testo continua su
questo tono ancora per un po’ (è riportato in nota*) fino a che “finalmente
vedi che sta arrivando un anziano con un cane al guinzaglio, allora lo saluti e
gli chiedi dove siete e lui ti dice che quello è l’aldilà e invece eri tu che
finalmente avevi preso sonno.” (Ugo Cornia, Sulle
tristezze e i ragionamenti, Quodlibet, Macerata 2008, pp 103-108).
Non-luogo,
periferia abbandonata, cementificazione a oltranza, Paese per vecchi, cui
s’aggiunge il mito berlusconiano dell’eterna giovinezza restaurata, immaginario
collettivo legato a pubblicità, cinema e serie televisive: queste realtà e
tematiche nutrono profondamente la visione poetica del Nosocomio di Rosaria Lo Russo (Nel
nosocomio, Effigie, Milano 2016). Quadri di marginalità e di squallore vengono elaborati al punto da richiamare archetipi degli inferi. Qui abuso edilizio, quartieri dormitorio,
ecomostri, case popolari vengono trasfigurati nell’immagine della casa di cura
o di riposo, dell’obitorio e infine del cimitero: metafore dell’Italia di
questi anni. L’atmosfera ovattata, riparata, “finta” da palestra-centrobenessere-casadiriposo,
la teledipendenza, il relax dei pensionati ormai tagliati fuori dalla storia si
affiancano a immagini agghiaccianti come questa: “C’è anche più povertà della
povertà i seminterrati corridoi interminabili dove chiunque si perde e sente il
freddo delle cantine entrare nelle ossa e spesso rinuncia ad andare a trovare
l’amico perduto.” (p 55).
* Riporto in nota la parte saltata nella lunga citazione della pagina di Ugo Cornia: “Lì c’è
una strada drittissima, abbastanza larga, sia sulla destra che sulla sinistra
ci sono dei muri alti di cemento armato, che non vedi che cosa c’è dietro, e
però da dietro i muri sporgono dei gran cubi di roba rivestita di cellofan e
più in là vedi anche del fumo bianco che esce da dei fumaioli. Ce n’è varie di
queste colonne di fumo che vedi spuntare qua e là. E poi, cinquecento metri più
in là, vedi anche delle file di gente che entra dentro questi muri di cemento
armato e vai avanti. E vai ancora avanti tenendo dietro a questi muri fino a
quando non incontri una strada, vedi che è una strada un po’ grande dove
passano dei camion e quando uno si ferma per farti passare la attraversi. Di
nuovo c’è un lunghissimo muro di cemento. Più avanti vedi che c’è un’altra fila
di gente che sta entrando da un cancello aperto in uno di questi grandi cortili
con tanti cubi di roba incellofanata di due metri per due, accatastati gli uni
sugli altri, ma a quella gente non hai voglia di chiedergli niente perché non
sai chi è e che cosa vada a fare lì dentro, e poi non hai una chiara idea di
che cosa fai tu in quel posto e di come ci sei finito perché ti sembra di
essere come ubriaco. Allora decidi di andare ancora avanti per quella strada dritta che dovrà pur andare
da qualche parte, e ti sembra anche che in lontananza, alla fine della strada
ci siano degli altri pioppi. E questi supposti pioppi per vederli bisogna
sforzare la vista perché c’è sempre quella luce da fine della notte, la luce
del giorno non è ancora arrivata, anche i camion hanno i fanali ancora accesi.
A te ti sembrerebbe che ormai dovrebbe essersi fatto giorno da un po’, ma
quando guardi l’orologio fa le quattro e tre quarti, allora fai un altro po’ di
strada e riguardi l’orologio e l’orologio fa ancora le quattro e tre quarti,
deve essersi rotto. Però più vai avanti, c’è sempre di più un’aria da lavori
i corso, con dei resti di muro e dei
cespugli tra lo spontaneo e il non curato, trovi anche dei mucchi di terra
ruspata e lasciata lì. Alla fine della strada trovi una specie di piazzale che
hanno asfaltato, ma poi si vede che l’avevano lasciato perdere perché per metà
è fatto ancora soltanto di terra battuta. Poi intorno a quello spiazzo c’è
effettivamente il filare dei pioppi e più in là, sul lato del piazzale, c’è
rimasto un circolo per anziani, soltanto che adesso è chiuso. Dietro i pioppi
c’è un fosso che deve esser rimasto lì da quando coltivavano." (p 108).
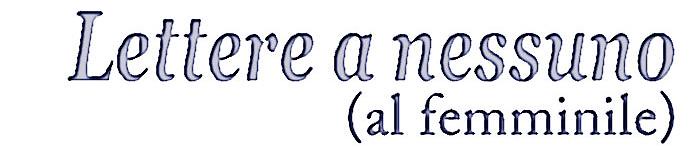
Nessun commento:
Posta un commento