R.S. Quali suggestioni letterarie hanno
avviato il motore della fabula di questo romanzo sugli insetti digitali di un
videogioco, traboccati dagli schermi, inspiegabilmente, nella realtà? Come non
pensare (ma forse è fin troppo facile e semplicistico e vago: dunque
fuorviante) a La metamorfosi di Kafka…
M.B. Di fatto, La metamorfosi di
Kafka, per quello che io ne so, è il primo ed è rimasto, fino ad oggi, l’unico
esempio di metamorfosi in insetto della letteratura. Ivi inclusa la fiaba di
magia. La storia di Gregor Samsa, ciò detto, non ha in verità proprio niente in
comune con questa di Giocare a mangiarsi. Qui la classica (ma del tutto
nuova) perdita del sembiante umano ha delle modalità delle cause una cornice ed
un senso (o meglio dei sensi) alquanto diversi. In primo luogo: la iattura,
temporanea o definitiva, qui riguarda non già una persona, il protagonista del
racconto, ma tutti. Secondariamente, causa del fenomeno da incubo è un
videogioco. E ancora, che tale fenomeno, cioè la metamorfosi del giocatore nel
proprio avatar entomologico: alter ego il più alieno dall’umanità e maschera da
idolo di un computer game nefasto; sia una minaccia incombente ogni giorno
sopra di te, e poi, a un tratto, ti piombi addosso davvero, iattura paventata
inspiegabile e inaudita, è denegato dai più. Addirittura dalla maggioranza.
Forse da tutti, escluso il fabulatore. E per concludere: Giocare a mangiarsi,
quanto al suo carattere, si presenta come una storia comica e quanto al genere
come un romanzo fantascientifico satirico. Tranne il finale, repentino e
catastrofico. La metamorfosi di Kafka è una catastrofe, vuoi figurale
vuoi esistenziale, dalla prima all’ultima riga.
R.S. Tu però sei solito affermare che
la lezione di Kafka è stata fondamentale per te. Se ce lo spiegassi, e lo
mettessi in chiaro, ora, una volta per tutte…?
M.B. La lezione di Kafka, per il
fabulatore di Giocare a mangiarsi, io la compendio in questi tre
insegnamenti. 1) Il personaggio anonimo e senza volto emerge da un passato
nebbioso. In pratica non ha passato. Come Josef K. nel Processo e K. nel
Castello. Sembra che sia circoscritto, e là confinato, in un presente
assoluto benché effimero, mutevole, fuggente, rovinoso, e al tempo stesso
immobile. Il suo fato (e quello degli altri personaggi con lui), pur nella
varietà degli accidenti comici, dei colpi di scena reali e virtuali, e
nonostante le rivelazioni ambigue, enigmatiche, e i cambi di prospettiva
deliranti risultato dei dibattiti paradossali; il suo fato appare già segnato,
già pronunciato. E in attesa di compiersi. 2) La fabula (paradossale,
meravigliosa, e nondimeno dentro la realtà e la contemporaneità) diventa subito
psichica: le immagini subiscono una sorta di rifrazione e distorsione,
deragliano dal mondo delle cose. E s’inabissano nella psiche. Immagini mentali.
3) La narrazione trasposta: cioè i fatti, i dati, divergono dal piano letterale
verso piani ulteriori. Quasi per un gioco di specchi. Quasi in fuga verso
l’infinito. Paradigma di queste tre caratteristiche, il sogno. Il fabulatore di
Giocare a mangiarsi, io sostengo (non si tratta di un paradosso), è, ciò
nonostante, il meno kafkiano tra gli scrittori italiani d’oggi. Tra i
postmoderni, intendo, che lo frequentano, Kafka, e lo citano sotto enigma. Non
è kafkiano, lui. È uno, piuttosto, che (l’abbiamo dimostrato) risente della
lezione di Kafka. Più che non càpiti a nessuno di loro. Lui, infatti, non è
postmoderno. Lui è, al contrario, un pervicace un incorreggibile fabulatore di
ricerca. Uno di area sperimentale. È neonovecentista. A Kafka, l’inimitabile,
noi fabulatori sperimentali e di ricerca guardiamo come a una guida. O a un
apripista.
R.S. Poco fa hai catalogato Giocare
a mangiarsi nel genere fantascienza. Satirica, hai specificato. Antonio
Caronìa, esperto di fantascienza e traduttore di Philip Dick, letto il
manoscritto, si espresse in modo più sfumato. O no?
M.B. Ma sì, è così. Nella lettera
scheda che mi mandò, e che avrebbe dovuto servire da schema e da base per la
prefazione di Giocare a mangiarsi, Caronìa si domandava se questo
romanzo fosse da assegnare alla fantascienza. E si rispondeva: “non in toto”.
William Gibson, negli anni Ottanta, fu accusato dalle riviste specializzate
americane di non aver pratica del virtuale. Cioè del mondo che entrava nelle
sue storie. Notizia che appresi da Antonio Caronìa. Stessa accusa avrebbe
potuto rivolgersi a me. Con una differenza, che le storie di W. Gibson sono
comunque interne al genere, pur nella loro eterodossia. Laddove questa di
Bargellini, egli mi scrisse, ne sconfina. Ma, con un colpo di coda, alla fine
del paragrafo Caronìa faceva rientrare dalla finestra quello che aveva appena
congedato sulla porta. W. Gibson, tal e quale come avrei potuto fare io, aveva
obiettato ai suoi censori che la realtà virtuale gli interessava solo come
metafora. E il mio lettore espertissimo aggiungeva: Giocare a mangiarsi
appartiene a certa fantascienza letteraria (ed episodica) del Novecento
italiano. Si pensi a Cancroregina di Landolfi. Antonio Caronìa prese
sotto il suo interessamento il mio manoscritto. Ma andò a cozzare contro la
timidità e l’ottusità del ceto impiegatizio editoriale italiano. Ciò avveniva
dieci anni fa. Dopo qualche anno il mio Pigmalione dovette arrendersi. Adesso,
inopinatamente, Giocare a mangiarsi viene pubblicato. Da Giovanni
Giovannetti (Effigie edizioni) e inaugura questa sua scommessa: la collana il
Regisole, spazio aperto alla narrativa di ricerca. Anzi riservato alla
narrativa di ricerca. La svolta, grazie a una tua iniziativa ardita e secondo
me ispirata. Ma aspettiamo a rallegrarci che la letteratura alla fine abbia
vinto. Io già prevedo la disattenzione dolosa dell’ambiente. Tutti, o quasi
tutti, d’accordo a oscurarla, a condannarla al silenzio un’opera così fuori dai
canoni, loro e del mercato, scomoda singolare smagliante. Osteggiata, è prevedibile,
dal luna-park della vanità (e degli equivoci) e dai suoi teatri d’automi.
R.S. Lasciamo perdere, almeno per il
momento, i tuoi eroici furori (e inani) contro l’establishment. Vorrei che ci
illuminassi invece su qualcosa, a mio avviso, di molto più importante,
caratterizzante ed unico nel tuo testo: l’ossimoro di fondo, quella figura
retorica dell’antitesi, a cui Giocare a mangiarsi sembra ubbidire.
L’ossimoro è questo: da un lato il massimo della contemporaneità oggi filtrata
dalla nostra cultura in un romanzo (di certo italiano, ma forse non solo
italiano), cioè la realtà virtuale e i videogiochi, nel nostro caso un computer
game ossessivo e ferale; dall’altro, per antitesi, il massimo della
letterarietà nella elocuzione, e quegli arcaismi e latinismi, da antiquario
della lingua…
M.B. La contraddizione di fondo tra lo
stile e l’argomento di Giocare a mangiarsi, che tu hai rilevato, in
partenza è stata affatto casuale. È il mio stile, quello. Basta andare a leggere
un paragrafo di uno qualsiasi dei miei tre libri precedenti, Mus utopicus,
Del simulacro perso nei sogni, La Setta degli Uccelli. Quando ho
cominciato a scrivere Giocare a mangiarsi, l’idea fantascientifica (“non
in toto”), l’idea, la metafora l’allegoria, col marchio della contemporaneità,
dalla quale io ero stato attraversato, dové adattarsi essa al mio stile. Non,
viceversa, lo stile arcaicizzante adattarsi, lui, alla contemporaneità
angustiosa feroce e meccanica della fabula. Dopo di che, con il procedere della
scrittura, suppongo d’essermi accorto e d’essermi compiaciuto dell’effetto
nuovo. E dei vantaggi di quest’ossimoro infinito. Lo choc dovuto a una simile
stonatura, ovvero il disaccordo tra lingua e argomento, suscitava in me un
senso di lontananza filosofica dalla storia e dai suoi accidenti meravigliosi.
Una filosofica e poetica lontananza.
R.S Ma lo spaesamento del lettore? Non
pensi al lettore, quando scrivi?
M.B. No. Se ci pensassi, al lettore,
smetterei di scrivere.
R.S. Non si può dire che tu vezzeggi il
lettore. O che gli strizzi l’occhio. Ogniqualvolta lo apostrofi, sembri
quell’oste romano che insultava i suoi clienti, con loro spasso. Si veda Il
miracolo della mosca (capitolo terzo) o Giocare a mangiarsi (capitolo
primo, quello che dà il titolo al romanzo). Per esempio, dove dici (ecco qua):
“Ehi te, lettore babbuasso o babbaccione, e te, lettrice babbalocca o tarlocca,
ecc.”
M.B. La voce narrante, la voce che
declama e s’interroga, che dialoga con le persone della fabula, e che apostrofa
i lettori, quasi un cerretano, un istrione, clamante in un teatro vuoto, suo
palcoscenico la pagina, uno che dialoga con le ombre: sicché il soliloquio di
un pazzo; volevamo dire, questa è la voce di un paradossologo, il lettore
callido lo ha capito. La tradizione ci viene dall’antichità; quindi gli oratori
bizzarri, in specie gl’intessitori di elogi paradossali, migrarono in certe
accademie, in temperie barocca, e là declamarono. Ricordiamo l’Accademia degli
occulti, a Brescia. Nel nostro secolo, poi, non spunta fuori Manganelli? Salvo
le impertinenze giocose da lui rivolte al pubblico dei suoi lettori, nel teatro
vuoto del suo studiolo (inusitate da Manganelli), il fabulatore di Giocare a
mangiarsi dev’essere un tipo del genere. Orazione funebre della mosca
(capitolo settimo), con i suoi echi parodici delle orazioni funebri di Bossuet,
e del quaresimale del gesuita padre Paolo Ségneri; l’orazione funebre per una
mosca vien pronunciata in chiesa da un paradossologo montato in pergamo, si
dice, su invito della curia.
R.S. E siamo alla fortezza di parole.
L’ho definito così il tuo testo, nella quarta di copertina, tanto ci appare
saldo nella sua fattura verbale artificiosa. Compatto, compiuto, inespugnabile.
Non sarà il caso di parlarne, finalmente, della lingua di Giocare a
mangiarsi?
M.B. Una immagine ben trovata. E uno
slogan promozionale: ”fortezza di parole”. Giocare a mangiarsi dà
l’impressione, effettivamente, di arroccarsi contro l’assedio della lingua
d’uso, dei media, munito di sue mura e torrioni a somiglianza di un castello
medievale. Fuor dall’immagine: è la ricerca antiquaria, è il recupero ed il
rilancio delle parole desuete, cadute in oblio con impoverimento dell’italiano
e della sua capacità espressiva, andate a ripescare dall’autore di Giocare a
mangiarsi; sempre che l’orecchio di un filologo (anche, un po’, d’un
latinista, va da sé) l’avverta ch’è sostenibile il repêchage; è il
differenziale linguistico, dicevo, ossia lo scarto dalla lingua d’uso, il gran
segreto, secondo me, della fortezza di parole. L’intarsio, da mosaicista, di
vocaboli d’ogni registro, e d’ogni secolo, si avvale di una sintassi
altrettanto varia. Deleuze, nel suo commento alla sentenza di Proust: Les
beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, indica nella
sintassi propria di quel certo prosatore la causa dell’effetto, perché, ad
esempio, il francese di Proust, all’orecchio dei francesi, dia un suono mai
udito prima. Meditate, gente. Dico a voi, abolitori della sintassi. Il volgo
dei vostri followers, all’evento, vi applaude. Vi fa festa: oh! gl’inventori
dello stream of consciousness, oh! l’avanguardia rétro. Ma la ricerca, lo
sperimentalismo, esigono acume, amici.
R.S. Sei solito definirti fabulatore
coi dadi. Spiegaci in che cosa consiste il tuo giocare ai dadi, quando scrivi.
Da questo fatto ancora da spiegare, ossia che Giocare a mangiarsi
è una fabula aleatoria; ecco, forse da ciò, dipende il suo procedere a quadri?
Sembra che, per un fenomeno carsico, la fabula non scorra in superficie, visibile,
bensì, incavernatasi, fluisca invisibile nelle profondità, ma sia segnato il
suo percorso e come celebrato, per una festa, da una messa in scena di eventi,
da un proliferare di quadri, slegati ma a ben guardare connessi, e che alludono
a quella storia, da entomologo e moralista, di uomini e di insetti: fabula
sotterranea, sommersa…
M.B. Ortega y Gasset, in un suo
excursus sopra l’arte del romanzo, ha detto una cosa memorabile: Cervantes,
egli nota, mette in scena don Quijote e Sancho Panza. Non gl’interessa
raccontare la loro storia. Con suo stupore, leggiamo nello stesso paragrafo,
Ortega y Gasset, conversando con dei giovani romanzieri spagnoli, ch’egli non
nomina, si rese conto d’una superstizione, o dicasi fissazione, secondo lui la
più nociva e acritica, per un romanziere del Novecento, da cui costoro erano
attardati: cercare una storia. Senza di che non parte un romanzo, si pensa.
Come convincerli, quei giovani romanzieri, a ritirarsi in una grotta (s’intenda
nella immaginativa), poiché saranno visitati, là dentro, da tutte le visioni e
tentazioni ch’esalano e soffiano dall’inconscio, dall’universo mondo, invero:
ed esse prenderanno corpo, corpo sottile immaginativo, in quella loro grotta
d’eremiti. Io vi consiglio di rileggere Flaubert (ora si è intromesso il
fabulatore coi dadi): La tentation de saint-Antoine. Erano gli anni
Venti del secolo scorso, allorché Ortega scrisse il suo breve saggio sul
romanzo. Oggi s’è oscurata tanta lucidità. Si continuano a raccontare storie,
piatte e soffocanti e carcerarie, secondo il mercato comanda. Pas besoin d’une histoire, une histoire
n’est pas de rigueur, dice un personaggio di Beckett. Sarebbe da
approfondire ‘sta cosa: la pervicacia a raccontare una storia, qualunque
storia, dei romanzieri da televisione, e l’ombra, sul romanzo, della
sottocultura. Anzi, le luci: sfolgoranti siderali sulle discariche
d’eccellenza. Studi televisivi, appunto, vetrine di librerie, scaffali di
supermarkets.
R.S. Torniamo, se non ti spiace, a Giocare
a mangiarsi.
M.B. Il suo autore (così detto), e qui
concludo, giusta l’insegnamento d’un tal maestro, piuttosto che raccontarci una
storia, una idea mette in scena. Ortega y Gasset, è certo, avrebbe approvato.
Ed ingannandosi, ahimè, trarrèbbe degli auspici, dalla lettura del libro,
fausti, circa la svolta del romanzo, vicina. Lui, il fabulatore coi dadi, si
era cominciato a dire, non c’intrattiene con una storia, una idea mette in
scena. Nel senso greco, visivo, non già astratto, concettuale, del termine: una
idea sfaccettata, come gli occhi, come i bui ocelli degl’insetti. L’idea-metafora,
l’idea-allegoria di un computer game dove si gioca a divorarsi, anonimi,
ciascuno occultato ai suoi competitores da una maschera entomologica. Distinta
in diversi quadri, non raccontata, propriamente, ma assemblata alquanto a caso,
la fabula. Fabulatore coi dadi. Giochi ai dadi?, tu mi domandi. Seduto a
tavolino, al computer? La storia, e perfino le frasi, procedono a colpi di
dadi? Giocare a mangiarsi, dato che è un romanzo frattale, è franto, ex
necessitate. Ed aleatorio. Le fiamme di un incendio, le nubi, una tempesta, il
profilo di un fiordo o di una costa quale che sia, e i fiocchi di neve o di
polline, sono esempi di figure frattali addotti dal loro investigatore, da
Benoît Mandelbrot: a essi non è indebito paragonarlo, vuoi per la loro forma,
non euclidea, vuoi per lo stesso formarsi loro, caotico in certa misura, e
casuale, oltre qualunque standard; è lecito paragonarlo un simile romanzo, Giocare
a mangiarsi. Gli elementi caotici, anzi il caos immesso nel suo prodotto
verbale immaginale da un fabulatore siffatto; il caos della sua fabula, e da
cui sono terremotati i suoi periodi, fa che si debba assegnarlo al neobarocco
(nel senso di Omar Calabrese) l’autore in parola. Ma questo caos, non mica
simulato, vero e sotterraneo, è governato da chi ne sembra in balìa: l’arte
retorica, gli artifici tecnici, lo domano e piegano ai suoi scopi. In verità,
al finalismo ignoto della idea formante del testo.
R.S. E delle “forme informi” del
matematico René Thom? Parliamone, giacché le metamorfosi in insetto, definitive
o momentanee, singole o collettive, biologiche o virtuali, accadono in Giocare
a mangiarsi. In una metamorfosi, l’indugio labile e catastrofico in una
forma che sfuma e già l’imporsi d’un’altra, fa, per un attimo, che coesistano
le due forme, e siano, in un certo modo, informi. La breve metamorfosi di
Olimpia in non ricordo più che coleottero, durante una cena al ristorante Timé,
ha forse, come suo modello e legge, la teoria delle forme informi?
M.B. Acconcia conclusione
dell’intervista. Però, adesso, io taccio: prima che certi miei avversatori,
gente che nicchia e dormicchia, svegliati dalle nostre voci non vengano a
curiosare nella mia nicchia.
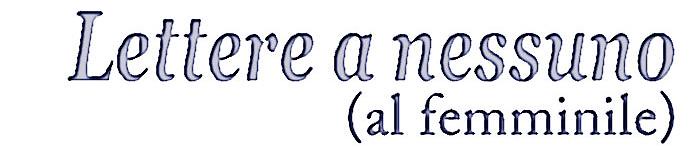
Nessun commento:
Posta un commento